Prete e gay/2. La relazione ambigua
 Chi meno omofobo della Chiesa cattolica? E’ quello che verrebbe paradossalmente da dire, vista l’incidenza dell’omosessualità tra il clero, di molto superiore a quella diffusa tra la popolazione non clericale. Eppure in questi giorni la curia palermitana (storicamente zeppa, per conto suo, di preti e vescovi omosessuali) ha sbattuto la porta in faccia alla locale comunità dei gay credenti. Questi ultimi chiedevano soltanto di poter formulare entro le mura d’una chiesa diocesana una prece di suffragio per le vittime dell’omofobia. Anche se, in punta di codice canonico, il diritto di una preghierina non lo si nega neppure ai divorziati risposati, e non sta scritto da nessuna parte che la Chiesa è contraria ad ogni forma di violenza tranne quella a danno dei gay, l’eminentissimo Paolo Romeo e il suo ausiliare mons. Carmelo Cuttitta si fanno scudo della dubitativa
Chi meno omofobo della Chiesa cattolica? E’ quello che verrebbe paradossalmente da dire, vista l’incidenza dell’omosessualità tra il clero, di molto superiore a quella diffusa tra la popolazione non clericale. Eppure in questi giorni la curia palermitana (storicamente zeppa, per conto suo, di preti e vescovi omosessuali) ha sbattuto la porta in faccia alla locale comunità dei gay credenti. Questi ultimi chiedevano soltanto di poter formulare entro le mura d’una chiesa diocesana una prece di suffragio per le vittime dell’omofobia. Anche se, in punta di codice canonico, il diritto di una preghierina non lo si nega neppure ai divorziati risposati, e non sta scritto da nessuna parte che la Chiesa è contraria ad ogni forma di violenza tranne quella a danno dei gay, l’eminentissimo Paolo Romeo e il suo ausiliare mons. Carmelo Cuttitta si fanno scudo della dubitativa giurisprudenza minoritaria di un documento magisteriale di nicchia, per opporre un diniego.
giurisprudenza minoritaria di un documento magisteriale di nicchia, per opporre un diniego.
Successivamente l’Arcivescovo ha concesso udienza ai cattolici del gruppo “Ali d’aquila”, che così hanno potuto pregare nel sagrato della chiesa, che il parroco aveva provveduto a illuminare internamente.
 Quella che sembra la solita polemica tra preti e gay si rivela un’istruttiva commedia delle parti. Preti gay contro gay laici, una lite tutta interna alla medesima realtà, di quella clericale o di quella omosessuale, a seconda del lato da cui si voglia guardarla. I due gruppi sembrano rinfacciarsi a vicenda vizi e ipocrisie obiettivamente non attribuibili in esclusiva alle rispettive controparti. Anche l’altra delle due contendenti, infatti, la comunità ecclesiale omosessuale, porta in sé non meno grandi contraddizioni e ambiguità.
Quella che sembra la solita polemica tra preti e gay si rivela un’istruttiva commedia delle parti. Preti gay contro gay laici, una lite tutta interna alla medesima realtà, di quella clericale o di quella omosessuale, a seconda del lato da cui si voglia guardarla. I due gruppi sembrano rinfacciarsi a vicenda vizi e ipocrisie obiettivamente non attribuibili in esclusiva alle rispettive controparti. Anche l’altra delle due contendenti, infatti, la comunità ecclesiale omosessuale, porta in sé non meno grandi contraddizioni e ambiguità.
Neppure i gay credenti dovrebbero mai fare a meno d’interrogarsi sul senso delle proprie ambivalenze e della voglia di mimetismo di tanta parte di loro. Quanti hanno accettato l’incauta proposta di farsi preti, illudendosi di trovare salvezza ammantando i propri conflitti di coscienza col celibato ecclesiastico e di far venire a patti ex opere operato il proprio orientamento omosessuale e la propria formazione cristiana? E quanti hanno preferito restar preti a qualsiasi costo, temendo, a causa  della loro tendenza omofila, di andare incontro ad un destino di esclusione sociale, magari da parte di quegli stessi fedeli da cui ricevevano ogni giorno stima e considerazione?Comunque sia, nel giorno in cui Roma consente a gruppi organizzati di cultori del Messale di Pio V d’ignorare vescovo e comunità locali per dir messe in latino a capriccio, gli omosessuali subiscono, di fatto, un trattamento da scomunicati, sicché non metteranno neppure un piede sul suolo consacrato del tempio.
della loro tendenza omofila, di andare incontro ad un destino di esclusione sociale, magari da parte di quegli stessi fedeli da cui ricevevano ogni giorno stima e considerazione?Comunque sia, nel giorno in cui Roma consente a gruppi organizzati di cultori del Messale di Pio V d’ignorare vescovo e comunità locali per dir messe in latino a capriccio, gli omosessuali subiscono, di fatto, un trattamento da scomunicati, sicché non metteranno neppure un piede sul suolo consacrato del tempio.
 L’educazione cattolica della stragrande maggioranza degli italiani è spesso chiamata in causa per spiegare comportamenti omofobi diffusi nel nostro Paese. Sarebbe però molto più costruttivo provare a chiedere alla comunità ecclesiale di interrogarsi su quale sia il ruolo di questa educazione nell’insorgenza del fenomeno; se l’omosessualità stessa non abbia tra le sue cause proprio l’atteggiamento sessuofobico, e troppe volte inutilmente repressivo, di tanta pedagogia confessionale.
L’educazione cattolica della stragrande maggioranza degli italiani è spesso chiamata in causa per spiegare comportamenti omofobi diffusi nel nostro Paese. Sarebbe però molto più costruttivo provare a chiedere alla comunità ecclesiale di interrogarsi su quale sia il ruolo di questa educazione nell’insorgenza del fenomeno; se l’omosessualità stessa non abbia tra le sue cause proprio l’atteggiamento sessuofobico, e troppe volte inutilmente repressivo, di tanta pedagogia confessionale.
Per altro verso, un omosessuale credente, una volta raggiunta un certa statura nella crescita di fede può legittimamente chiedersi appunto cos’abbia a che fare questa educazione tanto col suo essere credente quanto col suo essere gay.
L’autorevolezza della Chiesa nello svolgimento della sua funzione pubblica di connettivo sociale passa in gran parte dal suo proporsi come agenzia educativa, e questo è a sua volta fondato sulla difesa di un preciso modello familiare. La difesa di un’astratta moralità “naturale” della famiglia, dell’indissolubilità naturale del sacro vincolo, la santificazione della figura materna, l’intrinseco disordine naturale ritenuto connesso a qualsiasi atto sessuale fuori dalla fecondità del matrimonio, soprattutto quelli contro natura, sono altrettanti caratteri di questa idealizzazione romantica del ménage familiare borghese, certamente utili alla conservazione del modello e anche della funzione culturale di chi se ne fa portatore, ma comunque distinti e distantissimi dalla precipua vocazione ecclesiale all’agape. A questo punto nessuna ipocrisia apparirà mai troppa, nessuna caricatura dell’amore sacramentale abbastanza grottesca da indurre le autorità ecclesiastiche a interrogarsi sulla propria etica sessuale, a smettere di dare cristiana benedizione a qualsiasi forma di  bieco familismo, purché con parvenze eterosessuali ed esteriormente rispettoso dell’autorità ecclesiastica, a non accogliere qualsiasi autocandidatura al sacerdozio sulla sola promessa celibataria, a ripensare i rapporti tra uguaglianza battesimale e ministero pastorale nella Chiesa, a rinunciare alle nostalgie di egemonia culturale.
bieco familismo, purché con parvenze eterosessuali ed esteriormente rispettoso dell’autorità ecclesiastica, a non accogliere qualsiasi autocandidatura al sacerdozio sulla sola promessa celibataria, a ripensare i rapporti tra uguaglianza battesimale e ministero pastorale nella Chiesa, a rinunciare alle nostalgie di egemonia culturale.
 “Omosessualità” non indica un tipo umano, ma solo un orientamento dell’identità sessuale. Non esiste perciò un “tipico” omosessuale, neppure nella Chiesa. Non esiste alcun format cristoterapeutico dell’omofilia, esattamente come non dovrebbe esistere neppure una specifica “pastorale” delle persone omosessuali. Non deve rimanere competenza riservata a teologi o ecclesiastici l’autocomprensione credente del mistero della persona umana come vero luogo teologico in cui Dio appare e abita in tutta la sua sovrana libertà di scelta. E’ nella persona stessa del credente, nel suo percorso esistenziale tracciato dalla speranza in Cristo, che diviene evidente l’universale chiamata ad essere partecipi dell’esperienza che egli ha del Padre (cfr. Gv 14). Il consacrato è solo un credente la cui esistenza è fatta particolarmente trasparente di ciò che tutti accomuna. Egli allarga i propri spazi interiori per fare di sé il luogo di accoglienza del trascendente. A questa idea si ricollegano molti dei simboli cui tradizionalmente si è fatto ricorso per esprimere lo stato di consacrazione: il “Carmelo”, il “Tempio”, il “Monte” sul quale Dio appare…
“Omosessualità” non indica un tipo umano, ma solo un orientamento dell’identità sessuale. Non esiste perciò un “tipico” omosessuale, neppure nella Chiesa. Non esiste alcun format cristoterapeutico dell’omofilia, esattamente come non dovrebbe esistere neppure una specifica “pastorale” delle persone omosessuali. Non deve rimanere competenza riservata a teologi o ecclesiastici l’autocomprensione credente del mistero della persona umana come vero luogo teologico in cui Dio appare e abita in tutta la sua sovrana libertà di scelta. E’ nella persona stessa del credente, nel suo percorso esistenziale tracciato dalla speranza in Cristo, che diviene evidente l’universale chiamata ad essere partecipi dell’esperienza che egli ha del Padre (cfr. Gv 14). Il consacrato è solo un credente la cui esistenza è fatta particolarmente trasparente di ciò che tutti accomuna. Egli allarga i propri spazi interiori per fare di sé il luogo di accoglienza del trascendente. A questa idea si ricollegano molti dei simboli cui tradizionalmente si è fatto ricorso per esprimere lo stato di consacrazione: il “Carmelo”, il “Tempio”, il “Monte” sul quale Dio appare…
Non è solo affare dei laici, gay od eterosessuali che siano, ripensare l’eros alla luce della trascendenza dell’amore oblativo di Cristo, in quanto riflessione che possa servire a spogliare sia l’eros, ma anche l’agape, di quelle interpretazioni culturalmente contrassegnate, che hanno ridotto l’uno e l’altro a utilità funzionali a determinati assetti del potere. Allo stesso modo, non è riservata al punto di vista eterosessuale la miopia sessuofobica. Quasi per tutti i preti, omosessuali compresi, il problema consiste nell’evitare o limitare la pratica omosessuale tra il clero. Ma la  questione più preoccupante non è per nulla quella di come, dove, a chi apporre appropriati braghettoni. Il problema è che l’attuale assetto istituzionale ecclesiastico favorisce una pratica che per altri versi è condannata; il problema è che su questo doppio legame molti, troppi preti e laici rischiano di saltare; il problema è che l’ipocrisia del <i>nisi caste caute</i>, i mimetismi lobbistici, le coperture pietose o interessate forse salvano la faccia all’istituzione ma abbandonano a sé stesse le persone.
questione più preoccupante non è per nulla quella di come, dove, a chi apporre appropriati braghettoni. Il problema è che l’attuale assetto istituzionale ecclesiastico favorisce una pratica che per altri versi è condannata; il problema è che su questo doppio legame molti, troppi preti e laici rischiano di saltare; il problema è che l’ipocrisia del <i>nisi caste caute</i>, i mimetismi lobbistici, le coperture pietose o interessate forse salvano la faccia all’istituzione ma abbandonano a sé stesse le persone.









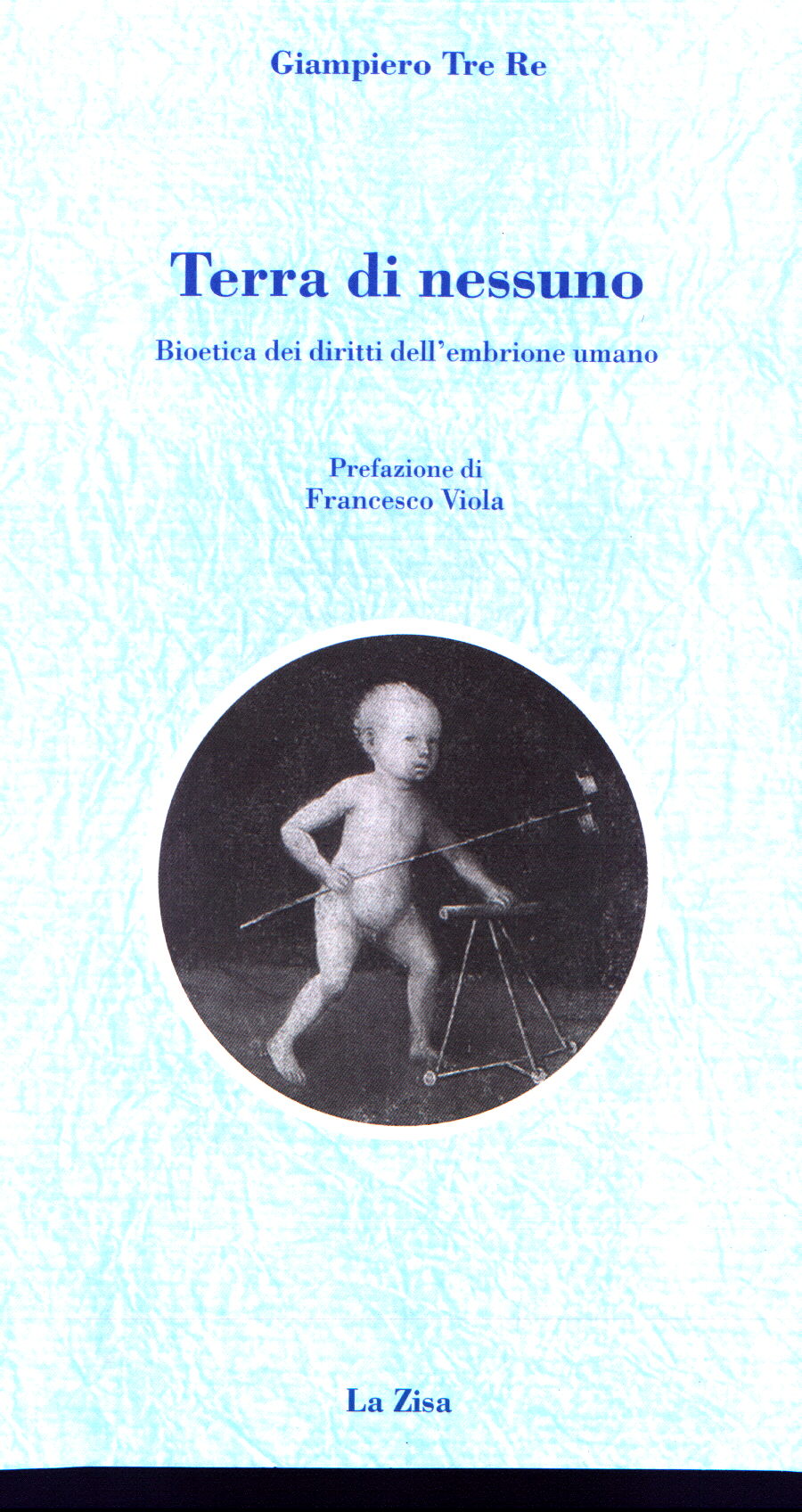
C’è un’induzione filosofica dal cristianesimo alla scienza moderna?
Ed attraverso il “principio di discernimento” [tra autonomia delle realtà mondane e primato del trascendente]?
I suoi ricordi sulla scolastica sono sufficienti a consentirle di formulare la questione nei suoi termini appropriati. La mia risposta è positiva ad entrambe le domande.
Definiamo sinteticamente la scolastica così: un sistema istituzionale di produzione e trasmissione del sapere. Questa sua duplice caratteristica, d’esser “pubblica” e “universale”, almeno nelle sue aspirazioni, ha fatto sì che la scolastica diventasse una tappa obbligata di quel processo di sviluppo delle condizioni storiche di ciò che oggi chiamiamo “scienza”. Da un lato infatti la scolastica ha aperto la strada all’idea che “scientifici” non sono i “contenuti” bensì la “struttura formale” di un certo discorso: la scienza non è tale per ciò che dice, ma per come lo si dice. Dall’altro lato l’esigenza di universalità del sapere contiene in germe le strutture formali del discorso scientifico, quali il carattere convenzionale del metodo, l’esattezza e l’univocità del linguaggio, la controllabilità attraverso la dialettica intersoggettiva del dialogo critico. Attraverso questo passaggio epistemologico si conduce quel graduale superamento del principio di autorità, di cui abbiamo detto, che determina poi il carattere “democratico” tipico delle scienze moderne.
Qual è esattamente il contributo dato a questo processo dal pensiero ebraico-cristiano, nella sua specificità di pensiero religioso, storicamente distinto dall’attitudine logico-speculativa che lei giustamente attribuisce al pensiero greco quale suo tratto caratterizzante?
Si tratta, a mio parere, di un impulso preciso e nello stesso tempo assai articolato. In breve, si può condividere ciò che lei sostiene: “[la] tendenza alla logicità formale rigorosa (ma anche tendenzialmente asettica ed impersonale) […] è particolarmente spiccata […] negli europei…”, ma un conto è ciò che è razionale, un altro ciò che del razionale è pensabile; effettivamente, storicamente pensabile solo entro la cornice di una narrazione culturale. Ragione e pensiero, logica e conoscenza, non sono la stessa cosa. E’ esattamente qui, in questa distinzione, che il pensiero teologico ha dato il suo contributo alla nascita della scienza moderna. Solo per accenni: il tempo è un’istituzione sociale; ci sono dunque concezioni culturali del tempo: lineare e ciclica. Incompatibile, quest’ultima, con il tempo “sperimentale” e con la visione scientifica della realtà, mentre l’altra ne rappresenta una condizione imprescindibile per il suo avvento.
Un secondo contributo del pensiero ebraico-cristiano alla nascita della scienza è legato all’atteggiamento ermeneutico, tipico di questa tradizione di pensiero, nei confronti della realtà.
A differenza di Aristotele, la sapienza ebraica non guarda alla scienza come a un “prodotto naturale” che l’intelligenza si limita a dedurre sillogisticamente dalla realtà o, per usare una metafora, a cogliere direttamente dall’albero allungando la mano; ma una narrazione, una lettura umana, un’interpretazione dei significati impressi nelle strutture storico/creaturali di una realtà intimamente sensata. Questo tipo di atteggiamento mentale nei confronti della realtà è infinitamente più vicino alla concezione moderna di scienza come sistema di controllo e confronto di rappresentazioni concettuali della realtà (teorie scientifiche), e che perciò ne hanno preparato la comparsa più immediatamente, di quanto non possa dirsi della sapienza greca. Entrambi questi aspetti (la dialettica tra razionale e pensabile, da un lato, e l’atteggiamento ermeneutico-discorsivo verso la realtà, dall’altro) s’intrecciano variamente nella genealogia del pensiero scientifico.
Chiedo scusa in anticipo se sarò costretto ora ad entrare “nel tecnico” per fare un discorso che per forza di cose potrà sembrare ostico.
La patristica e il Cantico delle creature che lei cita esprimono un pensiero in cui è contenuta una razionalità, esattamente come, per altro verso, la razionalità greca ha dato esiti assai diversi tra loro non solo nelle macroscopiche differenze, poniamo, tra l’idealismo di Platone e l’ontologismo di Aristotele, ma anche all’interno di una stessa discendenza filosofica, come quella di Platone, di cui la scuola ateniese di Giamblico sviluppa l’orientamento mistico-esoterico, laddove la scuola neoplatonica di Alessandria, con Ipazia, ne sviluppa invece le tendenze matematico-scientifiche. Aspetti, peraltro, quello mistico-religioso e quello scientifico, compresenti non solo in Platone, ma già in Pitagora. Il platonismo influenza il pensiero cristiano, per lo meno in Occidente, nella sua versione alessandrina, proprio perché quest’ultima esprime l’esigenza di un pensiero filosofico più “razionale”. Ciò vale, attraverso Agostino, fino a scolastica inoltrata, cioè fino ad Alberto Magno e Tommaso d’Aquino. La fortunata congiuntura di poter avere finalmente disponibile l’opera di Aristotele direttamente in greco e non più solo nella traduzione dei filosofi-scienziati arabi, convince l’Aquinate che non solo il pensiero di Aristotele fosse scientificamente assai più rigoroso di quello platonico, ma che l’assoluta incompatibilità del pensiero di Aristotele con quello di Platone e, a maggior ragione, con la dottrina cristiana della creazione e dell’anima, non fosse legata tanto ai presupposti della filosofia aristotelica in sé, spesso tacciata di immanentismo e materialismo, quanto alla versione che di esso era stata diffusa fino a quel momento in Occidente dai suoi commentatori arabi.
Di fatto l’interpretazione tomasiana di Aristotele è meno preoccupata di conciliare fede e ragione, quanto di garantire la non contraddittorietà tra discorso teologico e scienza (almeno quella che all’epoca era ritenuta veramente tale, cioè la filosofia naturale, o Fisica, di Aristotele). Possiamo dire che il programma tomista di tracciare rigorosamente i limiti del discorso teologico ha un risvolto strettamente epistemologico, perché produce l’effetto di definire anche il campo di ciò che teologia non è, cioè il campo della filosofia e delle scienze naturali. Tommaso non vuol anzitutto battezzare Aristotele, né dare un’interpretazione religiosa del pensiero aristotelico quanto piuttosto risolverne le aporie e garantire un impianto scientifico al proprio pensiero teologico. Pur di salvaguardare le linee generali di questo progetto, cioè le linee generali del pensiero scientifico di Aristotele, Tommaso non esita a “contaminarne” l’impalcatura filosofica con innesti provenienti dalla filosofia cristiana (Boezio) o dal neoplatonismo (Proclo) mostrando così di non soffrire di alcun dogmatismo filosofico né di subire affatto alcun complesso d’inferiorità nei confronti di Aristotele.
Ne è un chiaro esempio la revisione tomista apportata ai concetti di “ente” ed “essenza”. Per Aristotele “ente” è la sostanza concretamente esistente (tode ti, “questo qui”) comprensiva di forma e materia, negli enti sensibili; l’essenza è invece la sola forma, ciò per cui “questo qui” è ciò che è. La “forma”, aristotelicamente concepita, è dunque il principio della necessità e dell’intelligibilità di un ente o sostanza, ed è al tempo stesso l’oggetto del discorso scientifico, così come la materia è il principio delle possibilità e delle determinazioni concrete, individuali, di una sostanza. I problemi connessi a questa concezione dell’ente sono due. Il primo è spiegare come e per quali vie l’essenza, un principio necessario, immutabile ed eterno sia finito nel tode ti, in “questa cosa qui” davanti a me, un ente determinatissimo, concretamente esistente nel tempo come sostanza autonoma e separata. Il secondo è epistemologico, ed è quello che qui più interessa, cioè che l’insistenza sulla sola essenza come principio d’intelligibilità, ad onta dell’affermazione che l’essenza si trovi sempre e solo nella sostanza determinata, obbliga a concludere che vi possa essere scienza anche di sostanze non solo totalmente immateriali (Dio), ma materialmente inesistenti, come l’araba fenice. Per risolvere entrambe le difficoltà Tommaso include la materia nell’essenza. In questo modo tutte le essenze che hanno l’essere, ma non sono l’essere, appaiono come qualcosa in sé non necessario, ma solo possibile; qualcosa che pur non avendo in sé nulla di logicamente o metafisicamente contraddittorio rispetto alla possibilità di essere in atto, anzi recando in sé un’inclinazione, una propensione, un’ambizione, un’attitudine e quasi un desiderio essenziale ad esserci effettivamente, non possono tradurre questo loro candidarsi all’esistenza in una sostanza effettiva in virtù di una necessità interna alla propria essenza, ma solo grazie all’attività di un essere necessario in atto che le trascenda.
In breve: un conto è il passaggio dalla potenza all’atto all’interno di una sostanza individuale già esistente, un altro il passaggio dal non essere all’essere della sua essenza. Introducendo tale distinzione, che sancisce il primato metafisico dell’esistenza sull’essenza, Tommaso guadagna una visione più flessibile dell’essenza: non solo il concreto modo d’esistere delle diverse sostanze esprime una certa “necessità” della loro forma, non assoluta però, bensì in relazione al grado d’essere dell’ente a cui l’essenza appartiene (il che spiana la strada della conciliazione, prima apparentemente impossibile, tra l’impianto scientifico aristotelico e le dottrine della creazione e dell’immortalità dell’anima); ma nello stesso tempo (ecco ciò che più c’interessa) il guadagno rispetto ad Aristotele consiste anche nel fatto che per Tommaso qualcosa d’intelligibile c’è anche nella materia nella misura in cui questa contribuisce alla strutturazione essenziale dell’ente.
Non saprei dire se l’aristotelico Galilei conoscesse il De ente et essentia di Tommaso, ma possiamo affermare con certezza che la celebre metafora del “gran libro della natura” scritto dal medesimo Autore divino della Bibbia, prima d’essere posta da Galilei a fondamento della propria epistemologia, si trova già in Tommaso come conseguenza della sua ontologia, poggiando su un’inedita attenzione alle cose stesse nella loro concreta esistenza fattuale. Se Galilei lamenta il fatto che gli aristotelici, a differenza dello stesso Aristotele, credono più a quello che è scritto nei libri di Aristotele che a ciò che si osservare col proprio intelletto, bisogna dire però che forse questo atteggiamento antiscientifico degli aristotelici del ‘600 è in qualche modo dovuto ad un difetto di metodo che è proprio di Aristotele, il quale procede induttivamente nel momento dell’osservazione empirica (cioè a partire da sostanze concrete) ma deduttivamente (cioè a partire dall’essenza, cioè da principi metafisici) nel momento della dimostrazione.
Credo, per finire, che si possa andare ancora oltre in questa idea tomasiana dell’esistenza di una immanente struttura intelligibile anche nella stessa realtà materiale e dunque indagabile in maniera scientificamente autonoma dalla ragione umana; idea in ultima analisi risalente alla concezione del rapporto tra ente ed essenza elaborata dal Doctor Angelicus.
Anche se la “scienza” aristotelica è sostanzialmente biologia, l’epistemologia tomasiana funziona meglio non solo nelle scienze sperimentali ma anche nelle scienze biologiche e persino entro i presupposti della biologia evolutiva. La conoscenza, infatti, è, per Aristotele, conoscenza delle essenze, cioè, per lui, della sola forma. Nei viventi non umani la forma è la loro specie. Per questo l’osservativismo naturalistico di Aristotele fa tutt’uno col suo fissismo biologico: le specie biologiche, essendo forme, sono immutabili ed eterne. Ciò rende la metafisica di Aristotele inconciliabile con l’evoluzionismo. Ma, come abbiamo visto, nella concezione tomasiana dell’essenza invece è compresa la materia, in quanto principio di possibilità. In altre parole, nella concezione tomasiana è perfettamente accettabile che un certo range di possibili mutazioni della specie siano compatibili con l’essenza della specie stessa. Detto in altro modo: essenziale, o necessaria, non è la fissità delle caratteristiche morfologiche di specie o che le generazioni di viventi si riproducano sempre uguali a sé stesse, ma che le mutazioni che di fatto si produrranno nella storia evolutiva di una specie si verifichino entro un certo range di possibilità. Di fatto noi non assistiamo ad un’evoluzione per così dire “anarchica”, ma orientata. Non si passa dal vertebrato all’invertebrato, ma dall’invertebrato al vertebrato, dal meno complesso al più complesso, e così via.
Allo stesso modo credo si possa dire che Tommaso accetterebbe che la massa d’informazione genetica codificata nelle sequenze nucleotidiche del dna possa essere trattato speculativamente come qualcosa di essenziale delle sostanze viventi, sebbene metafisicamente tale informazione debba considerarsi “materia”. Ritengo assai probabile che Tommaso oggi, solo per citare una vexata quaestio contemporanea, ignorata per ovvie ragioni al suo tempo, abbandonerebbe del tutto anche la teoria dell’animazione differita dell’embriologia aristotelica, già esclusa dall’Aquinate, ma per ragioni teologiche, in un unico caso. L’hapax dell’incarnazione di Dio.
Mi scusi per la lunghezza di questo post. Sono d’accordo con lei nel considerare esaurito l’argomento.
E’ molto tardi e sono stanco. Parleremo domani dell’altro argomento che le sta a cuore.