Note sul suicidio medicalmente assistito
LA COOPERAZIONE NEL SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO
di Giampiero Tre Re
Pubblicato in F. VIOLA (a cura di), Forme della cooperazione. Pratiche, regole, valori, il Mulino, Bologna, 2004.
- «In un mondo in cui, sotto l’influsso della tecnica, le relazioni intersoggettive fossero scomparse, la morte cesserebbe di essere un mistero: essa diventerebbe un fatto bruto come la rimozione di un qualsiasi oggetto (G. MARCEL)
- «Chi mai prima d’ora si era trovato nella necessità di decidere quale durata della vita desiderare e scegliere?»
(H. JONAS)
La tecnica imprime valore alle cose. Questa è la ragione per cui quello che sfugge alla tecnica sembra sfuggire al mondo umano, tutto ciò che essa conquista appare conquistato alla verità ed al buon senso. L’adagio spesso citato: «tutto quanto tecnicamente si può, moralmente si deve», esprime appunto il carattere autoreferenziale della tecnologia in quanto fattrice di valori.
Tuttavia, la parabola della razionalità tecnologica, per tutta l’antichità fino all’Umanesimo considerata un agire moralmente indifferente ed in seguito, con la nascita del pensiero scientifico, intrinsecamente buono, non di rado incontra oggi un giudizio che sempre più di frequente vi vede una forma intrinsecamente ambigua dell’operatività umana. Applicata alla vita, la (bio)tecnologia di volta in volta aggiunge valore all’umano, lo viola o addirittura lo pone come proprio prodotto. Dopo aver mostrato il suo potere di cambiare la qualità della vita, la razionalità poietica sembra adesso volgersi ad un cambiamento qualitativo della vita, ad una mutazione tecnologica del significato dell’umano.
La trasformazione dell’immagine morale della medicina segue di pari passo il mutare dei rapporti tra scienza e tecnica. Quanto più il rapporto tra queste ultime si fa difficilmente distinguibile, la scienza diviene moralmente indifferente, la tecnica ambigua e la medicina amorale. I problemi bioetici connessi all’eutanasia mettono in risalto alcune importanti questioni inerenti a questa ambiguità del ruolo culturale giocato dalla tecnologia. Basti pensare alle dimensioni assunte dalla medicalizzazione della nascita e della morte nei Paesi occidentali: la quasi totalità dei cittadini degli Stati Uniti nasce oggi in una struttura ospedaliera e più dell’ottanta per cento vi termina la propria esistenza, il che è tra le cause principali del prolungamento della vita e dell’innalzamento della sua qualità ma, nel contempo, anche della crescita del tasso di cronicizzazione delle malattie e dell’esplosione dei problemi sanitari e morali connessi alla cura dei pazienti terminali.
L’ambiguità che dal potere tecnologico si riflette su tutte le questioni pertinenti il trattamento sanitario del morente è addirittura triplice.
Esiste anzitutto un’ambiguità che riguarda i soggetti: a chi spetti il potere di decidere se operare l’eutanasia e perché; se un tale immenso potere non sia del tipo «tutto-o-niente» e non renda dunque impossibile qualsiasi politica pubblica in materia o, all’opposto, non annulli l’autonomia morale di chi è chiamato ad esercitarlo; chi abbia diritto ad un’eventuale assistenza medica al suicidio ed alla piena «informazione»; se tali diritti del paziente non si traducano, nel concreto, in un danno per la sua libertà e in un’accentuazione, a suo svantaggio, dell’asimmetria di potere esistente nel rapporto col medico.
Vi è poi un’ambiguità sull’accettabilità dell’uso di mezzi ordinari/straordinari il cui impiego e investimento proporzionato/sproporzionato dipende in larga parte dalla disponibilità ed accessibilità di tecnologie e si presta a discrezionalità ed eccessi tanto in direzione dell’accanimento terapeutico quanto dell’eutanasia. Se poi questa sproporzione è calcolata sulla base dei costi, sia pure in termini di sofferenza fisica, che si dice debba essere proporzionata1, l’ambiguità di questo tipo di distinzione si palesa in un ricorso all’utilitarismo particolarmente sorprendente per un’etica della sacralità della vita nel cui contesto tale distinzione solitamente si pone. È significativo inoltre che la proporzionalità dei mezzi non sia in discussione in ambiti contigui, come nel caso delle cure palliative, ove sembrerebbe del tutto legittimo, anzi doveroso, il ricorso a qualsiasi mezzo, anche straordinario, per alleviare la sofferenza del paziente.
Vi è infine un’ambiguità sugli atti, anche questi tradizionalmente classificati sulla base di coppie di termini contrari, come attivo/passivo, volontario/involontario, diretto/indiretto2. L’ambiguità di quest’ultima coppia è, per esempio, legata alla difficoltà di stabilire in base a quale criterio valutare la diretta dipendenza di un effetto dall’atto: rispetto all’azione in quanto causa materiale? Rispetto all’intenzione? Rispetto all’ultimo ad agire? La distinzione «diretto/indiretto» cambia significato in ciascuna delle tre ipotesi. Il giudizio, poniamo, sulle cure palliative potrebbe mutare a seconda che consideriamo la morte del paziente come effetto «diretto» della somministrazione dell’analgesico, oppure «indiretto» dell’atto intenzionato ad alleviare la sua pena. Quanto al criterio cosiddetto «dell’ultimo ad agire», confrontiamo l’operato di un medico che somministri cure palliative con oppiacei a un malato terminale, nonostante la prevedibile conseguenza di una riduzione della sua aspettativa di vita, e la prescrizione, da parte dello stesso medico, ad un paziente che abbia chiesto assistenza per suicidarsi, di barbiturici, con l’avvertenza di non superare una certa dose, perché mortale. Secondo un giudizio che condividiamo, la prima pratica è generalmente ammessa, l’altra, per lo più, no. Assumendo, tuttavia, il criterio cosiddetto dell’ultimo ad agire il giudizio morale di liceità risulterebbe certamente più agevole nel secondo caso che nel primo: a chi volesse considerare determinante il fatto che l’azione di fornire la pillola letale, a differenza che nell’altra circostanza considerata in ipotesi, non avrebbe alcun effetto senza un ultimo intervento deliberato da parte del paziente, la responsabilità del medico, in questa seconda situazione, apparirebbe inevitabilmente meno “diretta” rispetto alle conseguenze mortali delle cure palliative.
L’ambiguità semantica non è meno vasta di quella concettuale. Rimanendo in argomento, chi è moralmente contrario all’eutanasia in genere nega che le cure palliative possano essere considerate atti eutanasici; al contrario, chi ha un atteggiamento possibilista nei confronti dell’eutanasia in generale, tende ad etichettare come tali anche le cure palliative, trovandosi così paradossalmente d’accordo, sui termini, con chi la rifiuta in toto, cure palliative comprese. È noto che una delle ragioni della fortuna del neologismo «suicidio assistito», comparso in letteratura intorno a una decina di anni fa, sta nel fatto che l’idea dell’uccisione di una persona vi si trova in maniera assai più sfumata che nel termine «eutanasia». Più che ai fenomeni da giudicare, le definizioni sembrano adattarsi alla specifica attitudine a regolamentare di cui i diversi approcci teorici si mostrano capaci; come se si cercasse una conferma dei propri presupposti teorico-pratici piuttosto che la risposta a problemi emergenti.
Quest’ambiguità concettuale e semantica ha esiti particolarmente penosi quando si riflette in una sorta di disorientamento etico diffuso. Preoccupa ancora il problema dell’accanimento terapeutico, spesso equivocato come un dovere dettato dal rispetto della vita umana, mentre si registrano casi in cui i pazienti o le loro famiglie rifiutano cure palliative scambiandole per pratiche eutanasiche. Non sorprende affatto, dato il quadro, la difficoltà di esprimere coerenti politiche pubbliche in questo settore.
L’ambiguità della tecnologia non va assecondata ma interpretata e governata; tra i compiti della bioetica e della biogiuridica vi è appunto quello di non reprimere il disagio dell’opinione pubblica su questi temi, ma di dargli un linguaggio, mostrando che la crescente potenza tecnologica, nonostante gravi errori, ingiustizie ed abusi, è immessa nel fluire dei processi della conoscenza e dell’umanizzazione.
Qualsiasi giudizio morale si ritenga di dover dare circa l’eutanasia, le cure palliative, l’accanimento terapeutico o il suicidio medicalmente assistito, non possiamo ragionevolmente ignorare la domanda intorno ai motivi che rendono non arbitrario indicare una certa forma di eutanasia col nome di «suicidio assistito», piuttosto che «omicidio pietoso» o «uccisione del consenziente». In realtà, ciascuna di queste espressioni, ovviamente, reca implicito anche un pre-giudizio morale sull’atto. Il giudizio sulla singola azione è sempre emesso inserendolo in una struttura globale di credenze e di valori insieme, il cui scopo è quello di soddisfare la domanda di senso di una certa collettività morale. Se così non fosse, la qualità morale dipenderebbe paradossalmente dalla sua denominazione e questa, a sua volta, esclusivamente dal punto di vista del potere che disporremo di far prevalere nella circostanza.
A ben guardare, insomma, la coesistenzialità, in quanto principio informatore di tutti i sistemi normativi, non sta alla base del dibattito etico soltanto in quanto pratica sociale, ma anche in quanto criterio di verità, nel senso che i codici etici di diversa matrice si affrontano innanzi tutto nel faticoso lavoro di misurare vicendevolmente le rispettive capacità di integrare, tra i propri presupposti, l’intersoggettività3. Nei rischi che si assumono nel contesto del pubblico dialogo critico risiede l’onestà di questo genere di teorie.
Il pluralismo etico non è dunque solo un dato di fatto; non è un modo d’essere di una certa morale storica né una morale esso stesso; è piuttosto una forma della moralità come tale. Il pluralismo non solo non contraddice affatto la possibilità di esistenza di una verità morale; al contrario, la presuppone, essendo espressione di un intrinseco carattere dinamico ed organico della verità morale, che ne regola internamente la crescita. Esso ha dunque basi cognitive, rispecchia, cioè, il modo d’essere processuale, dialogico, della ragione morale. Così come in assenza di una verità morale il dialogo critico perderebbe di senso, se non esistesse conflitto – cioè pluralismo etico – non solo raggiungere, ma anche semplicemente tendere alla verità risulterebbe impossibile.
L’esistenza di una pluralità di comunità morali rispecchia dunque un preciso modo d’essere della ragion pratica. Essendo una realtà vivente, la ragione morale esiste solo in quanto cresce, e cresce discorsivamente, sia al proprio interno che in relazione all’ambiente storico. C’è pertanto una molteplicità limitata di fondazioni, per quanto tale numero si accresca per effetto di reciproche ibridazioni, per necessità anch’esse radicate nelle strutture profonde del modo d’essere della ragione. Diversamente, infatti, non potrebbe verificarsi il fenomeno della comunicazione etica, che, al contrario, diviene ogni giorno più intensa.
Le diverse tradizioni morali e di pensiero etico, insomma, sono immerse in un ambiente pluralistico e conflittuale e agiscono nel quadro di un regime concorrenziale tra codici etici e tradizioni culturali; ma, se ciò è possibile, è solo perché esistono precise condizioni di fondazione dei sistemi normativi.
1. Quattro fondazioni
«”Eutanasia”, signor commissario, è un po’ come la sua “forza di volontà”: dubito della sua autenticità come termine scientifico, se mi scusate di nuovo. È insieme fantasioso e metafisico… greco in una parola…»
(H. MELVILLE)
Mettere a fuoco l’intersoggettività come aspetto centrale del problema dell’eutanasia rende particolarmente evidente la rilevanza della questione ed imprescindibile un discorso preliminare sulla fondazione del giudizio etico.
Nell’eutanasia cosiddetta volontaria, ad esempio, il problema non concerne tanto la moralità dell’atto in quanto tale (vale a dire il suicidio) ma la moralità della cooperazione. Come vedremo, sulla questione del «suicidio assistito» un giudizio di liceità viene emesso solo a partire da posizioni consequenzialiste: per cogliere tale obiettivo, parte dei sostenitori della fondazione della norma sulla base di considerazioni sulle conseguenze degli atti umani punta all’abolizione della classica distinzione attivo/passivo, accampando un certo numero di buone ragioni. Noi mostreremo tuttavia che sui presupposti non cognitivisti del consequenzialismo non è possibile prendere adeguatamente in considerazione gli aspetti intersoggettivi dell’agire e che la proposta di abolire quella distinzione classica cela in realtà questa particolare «sofferenza» intrinseca di quel determinato impianto normativo.
Il conflitto, per prendere un altro esempio, è uno dei modi più comuni in cui si presenta il carattere intersoggettivo del fenomeno della moralità in epoca di politeismo di valori ed è un aspetto ovviamente assai presente anche in tema di eutanasia. Tracciare la mappa dei rispettivi retroterra metaetici della fondazione deontologica e del consequenzialismo servirebbe a mettere in luce la difficoltà che entrambe accusano nel pensare adeguatamente il conflitto, inteso sia nel senso di conflitto di doveri, sia nel senso metaetico di conflitto tra diverse teorie di fondazione delle norme. A questo proposito, in particolare, occorre dire che il problema principale esistente tra deontologismo e consequenzialismo o -come altri preferiscono dire, stabilendo un parallelismo che tuttavia è, come vedremo, contestabile – tra etiche della sacralità della vita ed etiche della qualità della vita, non risiede, su questo punto, nella distanza delle rispettive posizioni di partenza: sul piano della prassi, la necessità di cooperare spinge sempre verso il rinvenimento di posizioni di compromesso che consentano alla ragione pratica di continuare a svolgere il suo compito: nel repertorio deontologico non mancano strumenti argomentativi e concettuali di chiara derivazione teleologica o utilitaristica (duplice effetto, male minore, ordinario/straordinario, eccezione, epikeia, ecc.) che consentiranno di rendere più malleabile l’intransigenza dei princìpi. Ma è il fatto di somigliare sempre più ad un dialogo tra sordi che qui riserba i maggiori rischi. Una comunicazione morale sempre più proceduralizzata e parcellizzata, una visione della vita etica sempre più atomistica, che va sempre più risolutamente verso la formalizzazione di soluzioni burocratiche «caso per caso» fin nelle più delicate questioni in cui sono in gioco la vita e la morte, rallenta la reale crescita della civiltà morale e giuridica e allontana l’orizzonte dell’integrazione dei codici etici e, in definitiva, il raggiungimento dell’obiettivo di un vero pluralismo etico.
Tra i compiti del discorso etico, dunque, vi è quello di esplicitare la propria fondazione delle norme e tenerla costantemente presente ed in continuo dialogo con le altre. Ora, non sempre il discorso normativo in bioetica è consapevole dei suoi presupposti metaetici.
In bioetica, come in etica, esistono solo quattro metodi normativi, risalenti ad altrettante diverse fondazioni della norma:
a. teleologica
b. consequenzialista
c. deontologica
d. assiologica
Il loro pluralismo dipende dalla complessità stessa dell’oggetto dell’etica. Diremmo che tale pluralismo non rappresenta un puro dato di fatto, semplicemente da constatare, ma un fenomeno strettamente connesso a principi strutturali e strutturanti la moralità come carattere universale dell’agire umano. In quanto tale, si tratta di un fenomeno che dà a pensare, come significano chiaramente i tentativi di ricondurre le diverse fondazioni ad un unico schema.
Lo schema qualità/sacralità (santità) della vita (QV/SV)4 è uno di questi tentativi. Il retroterra del concetto di QV è storicamente individuabile tanto nella tradizionale prassi medica, che non ha mai ritenuto la vita fisica un valore assoluto in sé, quanto nella tecnica di ponderazione costi/benefici, calcolati sulla base delle conseguenze procurate da una determinata azione od omissione sulla vita e l’insieme delle preferenze valoriali soggettive, ed infine negli sviluppi più recenti dei diritti umani. Da parte dei suoi avversari l’impostazione bioetica ispirata a SV è accusata di biologismo e di essere legata ad una visione ipostatica della «natura», spesso inefficace sul piano normativo perché rigida e intransigente sia dal punto di vista delle sue conclusioni, incapaci di porsi seriamente il problema dell’individuo concreto, in situazione, sia nel dialogo con altre impostazioni etiche, ed al tempo stesso poco rigorosa sul piano formale.
L’ambiguità cronica che affligge il concetto di natura, inoltre, porta facilmente ad equivocare circa la sacralità della vita. Non è raro, dunque, che con l’espressione «sacralità della vita» si intenda null’altro che quell’etica che parte dalla concezione deontologica e dalla fondazione ontologica della norma e per contro il criterio QV è ricollegato alla fondazione epistemologica ed al metodo consequenzialista, secondo uno schema5 che può rappresentarsi come segue:
epistemologia = fondazione consequenzialista della norma = QV
ontologia = fondazione deontologica della norma = SV
Questo genere di classificazione dà luogo tuttavia a confusioni dovute al fatto che tutte le fondazioni possono, in realtà, trovarsi alla radice tanto di approcci del tipo QV quanto di SV. Pertanto non sembra si possa assumere lo schema QV/SV come criterio di classificazione delle diverse teorie normative.
Oltre allo schema QV/SV, ed a volte combinato con questo, esiste quello teleologia/deontologia, basato sui due modi alternativi di procedere delle strategie euristiche e di fondazione delle norme adottati dalle diverse teorie etiche. Il giudizio su un atto ed il carattere vincolante di una norma, infatti, possono fondarsi soltanto o sul carattere intrinsecamente morale dei presupposti di un atto (la legge naturale, la volontà del legislatore divino o della ragion pratica, considerata capace di darsi autonomamente imperativi morali) ed avremo allora un quadro di tipo deontologico, o sulla base della preminente considerazione del ruolo creativo svolto dal soggetto morale nell’elaborazione delle strategie d’azione e nella valutazione delle conseguenze.
Si prenda in considerazione, ad esempio, il seguente schema tratto, come il precedente, dall’opera di Macintyre6
sacralità della vita = deontologia
qualità della vita = teleologia = consequenzialismo
Nella qualità della vita, infatti, si tende sempre più ad includere tutte le aspirazioni e le preferenze soggettive implicate tra le circostanze dell’atto da valutare. In questo modo il fine dell’agente (per esempio, il significato che il paziente attribuisce alle proprie aspettative di vita) assume una certa preminenza sul suo oggetto (per continuare nell’esempio, potremmo dire la sopravvivenza fisica in sé considerata). Per questo si tende a vedere nel concetto di qualità della vita, da parte di chi ritiene che esso possa considerarsi quale valido criterio regolativo dell’agire ma anche come sintesi del discorso bioetico, null’altro che lo sbocco e l’estensione sia del principio di autonomia sia del modello normativo teleologico.
Neppure questo secondo schema perviene però a risultati univoci. Da un lato, nonostante il carattere alternativo dei rispettivi presupposti, nel corso della storia del pensiero etico non è raro osservare in azione un’osmosi tra la fondazione deontologica e la teleologica; strumenti concettuali e procedimenti argomentativi migrano spesso da un campo all’altro, dando luogo a cospicue ibridazioni. D’altro canto, a meno che non voglia cadere nel non cognitivismo e ridursi così ad un vuoto volontarismo, la fondazione deontologica non deve escludere che la mens del legislatore – sia essa un’intelligenza sovrannaturale (deontologia del permesso) o la stessa ragion pratica (deontologia del dovere) – legiferi guardando, per così dire, ad un ordine razionale di finalità o comunque a principi intelligibili. A ben vedere, è possibile affermare che, in ultima istanza, la fondazione deontologica non possa fare a meno di supporre, come minimo, importanti elementi tipici della teoria concorrente.
I due schemi sinora passati in rassegna applicano, quali criteri di rilevanza, caratteristiche estrinseche alle teorie, tralasciando più profonde convergenze tra i diversi assetti normativi e differenze giacenti a livelli più basilari.
Se, infatti, assumiamo come criterio di demarcazione l’asserita conoscibilità/inconoscibilità, da parte di ciascuna delle quattro fondazioni, dei presupposti della decisione morale, uno schema alternativo può essere disegnato appunto a partire dalla discriminante: cognitivismo/non-cognitivismo (c/nc).
In breve, non cognitivista è ogni teoria che si richiama a quel tipo di fondazione epistemologica del discorso etico per cui l’agire morale risale a preferenze soggettive, che sono, per definizione, ultimativamente non conoscibili e convenzionalmente considerate tutte di pari valore. Il valore «in sé» dell’agire morale resta legato esclusivamente alla decisione ultima del soggetto ed è negata ogni legittimazione scientifica alla pretesa di giudizio valutativo sulle preferenze. La scientificità del discorso etico è connessa invece al carattere procedurale che esso viene così ad assumere: al compito di controllo del rigore formale dell’argomentazione; alla possibilità di calcolare l’efficacia di opzioni alternative sulla base della quantificazione delle preferenze e della soddisfazione ed infine al grande potere di orientare le decisioni collettive di cui gode l’etica una volta collocata all’interno della cornice epistemologica sopra descritta.
Le etiche di tipo cognitivistico iniziano il proprio discorso morale ammettendo apertamente o semplicemente supponendo la possibilità di conoscere scientificamente anche le radici ultime dell’agire morale. Respinta ogni forma di idolatria della ragione e smitizzatane ogni illusione di onnipotenza, la migliore tradizione etico-filosofica di stampo cognitivista manifesta una sua realistica fiducia sulle possibilità dell’intelletto umano di pervenire ad una vera conoscenza morale.
Si può così tirare una prima linea di demarcazione che passa tra il non-cognitivismo della fondazione sopra contrassegnata con b. e le altre, che sono del tipo opposto.
Riteniamo possibile, inoltre, elaborare una fondazione della norma sulla convergenza di a. e d. per via del fatto che i presupposti del cognitivismo non escludono per principio l’esistenza di uno specifico carattere della verità morale che fa di questa una verità libera ed in certa misura aperta all’influsso del processo maieutico e storico della scoperta dei valori che avvenga, tuttavia, entro precise condizioni di possibilità, di valutazione e di controllo, per mezzo di un metodo scientifico adeguato; cosa di cui l’etica, appunto, si fa carico.
Una seconda linea di confine passa dunque tra c., da un lato, a. e d., dall’altro: la discriminante è qui proprio l’attenzione preminente che queste due ultime rivolgono alla capacità decisionale e di scelta tra diverse opzioni possibili quale peculiare caratteristica del soggetto morale.
2. Il dibattito interno al consequenzialismo
«Non è decente che la società costringa un uomo a fare questa cosa da solo. Probabilmente, questo è l’ultimo giorno in cui sarò in grado di farla autonomamente»
(P. W. BRIDGMAN)
Il metodo consequenzialista è il solo che consenta di concludere, in maniera del tutto coerente con le proprie premesse, sulla liceità morale, almeno in determinate circostanze, di alcune forme di eutanasia; ciò non significa che nessuna dottrina che si ispiri ad una fondazione della norma di questo tipo possa concludere diversamente sull’argomento. Al contrario, esiste un dibattito interno al consequenzialismo, specie nei paesi anglosassoni, alimentato dal fatto che il contrasto tra i diversi orientamenti biogiuridici, lì particolarmente vivace, comincia a vedersi anche sul piano degli ordinamenti positivi7.
2.1. L’operatività della medicina e il morente
Tre sono i punti sui quali, in casa consequenzialista, si confrontano i pro e i contro sull’eutanasia. Si tratta dell’applicazione al problema del suicidio assistito degli argomenti classici del consequenzialismo, il calcolo di costi e benefici e la metafora polemica della cosiddetta china scivolosa; ma vi è, in primo luogo, la discussione circa le distinzioni interne al gruppo degli atti medici applicati alla fase terminale della vita umana e dunque sulla possibilità di diversificare il giudizio etico in relazione a tali atti. Da una parte si vuole offrire una nuova classificazione completa delle forme di assistenza medica al morire, basata sull’analisi della struttura formale di tali atti più che sulle loro caratteristiche esterne, sulle quali si modellerebbero, invece, le tipizzazioni tradizionali; dall’altra, strettamente connessa a questa strategia complessiva, è l’ambizione di offrire una diagnosi ed una terapia degli inconvenienti che affliggerebbero la logica del linguaggio e dell’argomentazione delle strategie normative concorrenti. Il fulcro del discorso consiste, infatti, nel porre l’accento sul controllo che medico e paziente esercitano sulle conseguenze della loro cooperazione per causare la morte del paziente stesso. Il controllo e la responsabilità che ne consegue, in quanto criteri assai più rigorosi sotto il profilo formale, dovrebbero dunque prendere il posto dei tradizionali criteri di demarcazione impiegati nell’analisi e nel giudizio sugli atti eutanasici: il criterio dell’ultimo ad agire, che guarda ai diversi ruoli assunti dai soggetti; la distinzione tra diretto/indiretto a proposito dei modi di dipendenza delle conseguenze dall’azione e commissione/omissione ossia l’aspetto esteriore assunto dall’operatività dei soggetti in azione.
Il fatto che, nel servirsi degli strumenti e dell’informazione forniti dal medico, il paziente è l’ultimo ad agire in vista della propria morte è, secondo taluni8, il criterio tradizionalmente usato per distinguere il suicidio assistito (pratica giudicata quasi universalmente illecita sia nei codici di deontologia medica sia negli ordinamenti giuridici) dalle rimanenti forme di morte medicalmente assistita di paziente capace e consenziente (eutanasia volontaria).
All’interno di questi tipi rimanenti, la pratica che abbiamo sopra denominato «sospensione del trattamento» si distingue tradizionalmente per la figura «passiva» che prende idealmente l’operatività di medico e paziente di fronte al decorso della malattia. In altri termini, l’omissione della terapia o del sostentamento è qui descritta come la rimozione di impedimenti all’avanzata delle conseguenze mortali della patologia. L’eutanasia passiva volontaria è, in genere, considerata moralmente lecita9.
In questo gruppo residuo di interventi cooperativi medico-paziente in vista della morte, si pone l’ultima distinzione tradizionale, che discerne, rispetto ai veri e propri atti di eutanasia «diretta» (illecita), le cosiddette «cure palliative», atti medici miranti non a debellare una patologia, ormai incurabile e in fase terminale, ma a lenire la sofferenza del paziente mediante il ricorso a farmaci che possibilmente, probabilmente o anche certamente hanno come prevedibile effetto secondario quello di abbreviare la prognosi di vita del paziente.
La tesi di R. G. Frey, ad esempio, è che, se assumiamo il criterio del controllo, non vi sono ragioni «decisive» per distinguere tutti questi atti sul piano morale. In primo luogo, in quanto strettamente connessa con quella di controllo dei presupposti dell’azione, quindi previsione e consapevolezza delle conseguenze e dunque responsabilità, l’idea di causalità morale sarebbe ugualmente implicata tanto nel caso di sospensione del trattamento medico quanto in quello di assistenza al suicidio, e pertanto non consente affatto di distinguervi due differenti tipi, moralmente lecito l’uno, illecito l’altro, di cooperazione medica.
«Per quanto riguarda la distinzione attivo/passivo, quale è la differenza morale tra il fatto che il dottore fornisca una pillola che produrrà la morte e il fatto che egli compia un gesto – staccare i tubi dell’alimentazione – che produrrà la morte? Entrambi gli atti si verificano a seguito di una richiesta di assistenza per morire da parte del paziente; entrambi riescono, in effetti, a determinare la morte; e in entrambi il paziente ed il dottore cooperano per produrre tale morte […] Sembra artificioso separare questi casi tramite la distinzione attivo/passivo, quando la loro somiglianza sostanziale, dal punto di vista morale, è così forte»10.
Circa le cure palliative si può dire che, quali che siano le modalità con cui si salda l’ultimo anello della catena causale (agire o non agire, con atto commissivo o omissivo, di persona – del paziente, del medico – o per il tramite dell’efficienza impersonale di un farmaco o di una macchina o dello stesso decorso patologico, con effetto singolo, duplice, molteplice) la responsabilità morale dipende comunque dal controllo esercitato da chi può intervenire sulla sequela delle conseguenze previste. Il controllo esercitato sulle conseguenze, sebbene in forme e modi di caso in caso diversi, da parte degli agenti, rende questi ultimi causa (o concausa) del risultato delle diverse azioni, cioè, invariabilmente, la morte del paziente.
Sul punto della questione interviene anche Sissela Bok11, la quale considera i problemi sul tappeto alla luce dei tratti storicamente salienti e dei più recenti sviluppi filosofici e teologici di due distinte dispute, circa la liceità del suicidio e dell’uccisione di altri, raggruppandoli in tre classi: opinioni estensive, restrittive, proibizioniste. L’Autrice disegna così una griglia che individua ben nove diverse posizioni. Quella che prevede restrizioni circa la liceità di ambedue gli atti (A), quella (C) che proibisce sempre entrambi (spesso attribuibile, secondo la nostra Autrice, alle etiche della «sacralità della vita») ed infine l’opinione, fatta propria dalla Bok, restrittiva quanto all’uccisione di sé ma in ogni caso proibizionista riguardo l’uccisione di altri (B), sono le sole tre posizioni ancora sostenute, almeno palesemente, nel dibattito contemporaneo successivo ai crimini nazisti.
Questa classificazione è chiaramente un tentativo di ricondurre tanto le diverse opzioni morali, quanto le «differenze in relazione alle diverse distinzioni tra determinare la morte e lasciare che essa sopraggiunga, tra ciò che è davvero volontario e ciò che può non esserlo, tra non somministrare e sospendere il trattamento»12, a fondazioni metaetiche reciprocamente alternative. Nello stesso tempo si tratta anche del tentativo di non offuscare, anzi «di esplorare le molte sfumature delle scelte praticabili e lo sforzo di individuare possibili premesse condivise a partire dalle quali esaminare i passi che portano alle diverse conclusioni»13. Si mette così allo scoperto la sovrapposizione di due distinti piani del dibattito, quello, appunto, dell’uccidere se stessi e quello dell’uccidere altri, cioè della cooperazione negli atti eutanasici, celata sotto l’ambiguità del termine «assistenza» medica, allo scopo di ottenere l’effetto di un distacco semantico e di senso tra questo tipo di atti medici e l’uccisione, per accostarli piuttosto all’idea, ritenuta eticamente meno problematica, di «suicidio». Per un altro verso, sulla base della griglia proposta, posizioni tipicamente di classe (A), sebbene possano appartenere al medesimo ceppo consequenzialista cui si ispirano quelle di Bok, si assestano su latitudini diverse del diagramma, sullo sfondo di un dibattito in cui «compaiono le molte tesi […] che assumono una prospettiva espansiva»14.
2.2. L’eutanasia e il consequenzialismo delle politiche pubbliche
Una legislazione sull’eutanasia è già vigente in Olanda dal 1993, mentre la legge speciale dei Territori Settentrionali dell’Australia, che, nello stesso anno, legalizzava per la prima volta l’eutanasia, sarebbe stata abolita dal Parlamento appena l’anno successivo.
Nel 1994 la Corte Suprema degli Stati Uniti pronunciandosi a favore delle leggi che proibiscono di prestare assistenza medica al suicidio negli Stati di New York e Washington mette il dibattito sull’eutanasia nei paesi di lingua anglosassone in una situazione critica. Punto di riferimento di quella sentenza fu la relazione della New York State Task Force on Life and the Law15, la quale presenta un’ampia rassegna di motivazioni, per lo più in chiave consequenzialista, che giustificano il rifiuto di legalizzare l’assistenza medica al suicidio. Il rapporto della Task Force offre dunque lo spunto per esaminare da un osservatorio privilegiato la polemica interna al consequenzialismo su un secondo problema: il classico argomento del calcolo e dell’ottimizzazione costi/benefici. I costi sono rappresentati, nei primi cinque argomenti che compaiono nella relazione, dai rischi di abusi, quali coercizione o persuasione illegittima, cui si esporrebbe un numero di soggetti deboli (a causa di depressione o sofferenza non curata) molto maggiore di coloro che beneficerebbero di un’eventuale legalizzazione dell’assistenza medica al suicidio. Questo tipo di argomento è un classico del consequenzialismo e conosce varie versioni come quella che muove dalla considerazione che non sempre un ampliamento delle possibilità di scelta si traduce in un vantaggio per il soggetto morale16; o quella che, viste le incognite implicate in una modifica delle attuali politiche sul trattamento medico dei morenti, opta per la conferma dello status quo17.
A ciò si può obiettare non solo che i rischi in questione esistono comunque nell’ipotesi che abbiamo denominato «sospensione», ma che in quest’ultimo caso sono, sotto il profilo quantitativo, assai più alti18. Tra la popolazione ipoteticamente interessata da una legalizzazione del suicidio assistito, il numero dei membri della «classe rilevante» degli individui a rischio, cui applicare il calcolo costi/benefici, subisce, infatti, una drastica riduzione se per «soggetto debole» non intendiamo qualsiasi persona depressa o sofferente ma solo, per esempio, i malati in fase terminale. I pazienti che rientrano in questo gruppo, inoltre, avrebbero «un titolo morale» al suicidio medicalmente assistito19 che meriterebbe (almeno) la stessa considerazione del diritto di rifiutare il trattamento e prevalente, «nel contesto di decisioni circa la fine della vita»20, rispetto al diritto di non invasione del proprio corpo.
Naturalmente il rapporto della Task Force non è ignaro della possibile obiezione e la previene avanzando una serie di argomenti che ha in oggetto la problematica assunzione della soglia del dolore e della capacità morale del paziente quali criteri di rilevanza per delimitare giuridicamente l’assistenza medica al suicidio e definire con esattezza giuridica una popolazione di possibili destinatari di eventuali normative sul suicidio assistito e l’eutanasia involontaria.
«La maggior parte delle proposte di legalizzazione del suicidio assistito ha respinto la malattia terminale in quanto linea divisoria perché non offrirebbe una risposta a molte circostanze che possono causare lo stesso livello di pena e dolore. Tuttavia, finché le politiche ruotano attorno alle nozioni di pena e di dolore, esse non sono arginabili; né la pena né il dolore possono essere misurati obiettivamente, o essere sottoposti ai tipi di giudizi necessari per sviluppare una coerente politica pubblica […] Una volta che l’eutanasia venga riconosciuta come alternativa “terapeutica”, la linea tra i pazienti che sono in grado di consentire e quelli che non lo sono sembrerà arbitraria ad alcuni dottori. Ad altri, apparirà apertamente discriminatorio o ingiusto negare una terapia a causa dell’incapacità del paziente di dare il proprio consenso. Come nel caso di altre decisioni mediche, alcuni dottori avranno l’impressione di potere e dovere prendere decisioni nel migliore interesse dei loro pazienti»21.
La liceità di un qualsiasi trattamento medico del morente può derivare solo dal carattere autonomo o di volontarietà della decisione del paziente circa la propria fine. Tuttavia, la volontarietà, come criterio di demarcazione, ha l’ovvio inconveniente di non essere a sua volta delimitabile. Gli argini giuridici dell’assistenza medica al suicidio o sono sufficientemente solidi (come il criterio della malattia terminale o della manifestazione del consenso), ma a prezzo di escludere dal diritto all’assistenza frange più o meno vaste di soggetti che d’altronde vantano titoli analoghi (per esempio, pazienti affetti da patologie caratterizzate da sintomatologia dolorosa acuta, ma non terminali); oppure sono più comprensivi, nel qual caso, però, perdono in oggettività e pertanto tendono a dileguarsi e a smarrire la loro funzione discriminante e limitante, di protezione contro l’abuso. Pertanto la questione centrale qui è se l’adozione di criteri estrinseci convenzionali per l’individuazione di un gruppo rilevante di legittimi candidati al suicidio assistito, quali caratteristiche della malattia come l’incurabilità, l’essere degenerativa, degradante o in fase terminale o di comportare intensa sofferenza; la futilità della terapia e l’inefficacia delle cure palliative; le condizioni soggettive, morali e psicologiche, del paziente22 ecc., accanto a criteri intrinseci come la competenza morale e l’interesse del paziente terminale, non dia luogo a insanabili contraddizioni. Perciò la Task Force pone l’accento sull’inevitabile consequenzialità tra l’adozione di requisiti tra loro tanto eterogenei per il riconoscimento della legalità del suicidio medicalmente assistito e l’esplosione dei loro effetti.
2.3. Chine scivolose e regressioni ad infinitum
Nella pratica clinica la maggiore difficoltà circa le condizioni per consentire l’accesso al suicidio assistito sta nel riconoscerne l’occorrenza, dato che tutte le circostanze che debbono radunarsi perché ciò si verifichi sono assai esposte a discrezionalità. Questa è la sostanza che alimenta lo scontro sul terzo ed ultimo fronte interno del dibattito tra bioeticisti che si richiamano alla fondazione consequenzialista della norma, la figura argomentativa della cosiddetta «china scivolosa». L’applicazione dell’argomento della china scivolosa, infatti, dovrebbe servire, in generale, allo scopo di presidiare i margini di sicurezza delle norme esistenti; ma talvolta gli si assegna anche un compito euristico in vista di nuovi rinforzi argomentativi alle prassi legittimate negli ordinamenti vigenti.
La «china scivolosa» è dunque uno strumento dialettico di chiara provenienza consequenzialista23 che qui viene tuttavia contrapposto all’opinione di altri eticisti i quali pure assumono il medesimo punto di vista traendone conclusioni sulla liceità di talune pratiche eutanasiche, come il suicidio medicalmente assistito24.
Per la definizione della china scivolosa possiamo utilmente riferirci al lavoro di M. A. Sanchez-Gonzales:
«L’argomento si può riassumere nelle due seguenti forme:
a – quando la tolleranza nei confronti di una procedura di carattere dubbio può aprire la via per l’apertura ad altre pratiche che sono dannose per l’umanità, si ha ragione sufficiente per non permettere facilmente il trattamento iniziale
b – quando le ragioni espresse in difesa di un procedimento possono venire generalizzate ed essere proclamate per delegittimare cose inaccettabili, si consiglia il riconoscimento del primo»25.
In altre parole, questo particolare procedimento funziona in base alla supposizione di giudizi morali assodati. Esemplari applicazioni della metafora della china scivolosa troviamo nel documento emesso nel 1994, a conclusione dei propri lavori, dalla New York State Task Force on Life and the Law, di cui abbiamo già detto, e nella relazione ufficiale dello stesso anno, resa dalla Commissione speciale della camera dei Lords. Ecco un passaggio di quest’ultimo:
«In ultima analisi, non crediamo che questi argomenti siano una ragione sufficiente per indebolire la proibizione dell’uccisione intenzionale. Questa proibizione è la pietra angolare della legge e delle relazioni sociali.
Proteggere ciascuno di noi imparzialmente, incarnando la fede nell’eguaglianza. Noi non desideriamo che la protezione sia diminuita e quindi raccomandiamo che non vi debbano essere cambiamenti nella legge che permettano l’eutanasia.
Una ragione per questa conclusione è che non riteniamo possibile segnare limiti sicuri all’eutanasia volontaria: creare un’eccezione alla proibizione generale dell’uccisione intenzionale aprirebbe inevitabilmente la via alla sua ulteriore erosione sia per determinazione, sia per inavvertenza, sia per la tendenza umana a saggiare i limiti di ogni regola.
Noi ci auguriamo che i corpi sanitari garantiscano un più serio controllo nei reparti di pronto soccorso, come un gradino per scoraggiare inappropriati trattamenti aggressivi da parte di medici con scarsa esperienza. Inoltre, è molto probabile che, attraverso le crescenti acquisizioni di quelli che lavorano nel campo delle cure palliative, il dolore e lo stress della malattia terminale possa essere adeguatamente alleviato nella gran parte dei casi [. . .]. Noi raccomandiamo fortemente lo sviluppo e l’incremento delle cure palliative»26.
Altamente significativi, in questo testo, la giustificazione di fondo della difesa dello status quo tramite l’appello alla forma immanente alle leggi prese nel loro complesso come espressione di un’intera civiltà giuridica; la contemporanea ribadita condanna della pratica dell’accanimento terapeutico; il favore espresso per le cure palliative e la raccomandazione per la loro diffusione.
Nel suo commento al rapporto della Task Force, di cui fu membro27, il filosofo J. Arras fornisce una duplice spiegazione dei meccanismi che determinerebbero un così inesorabile declino qualora si pervenisse ad una legalizzazione del suicidio assistito. La prima consiste in una «predizione empirica di ciò che può verosimilmente accadere una volta che una particolare pratica sociale venga inserita nel sistema sociale esistente» e individua tre ragioni «altamente problematiche» che suggeriscono prudenza nell’assumere politiche che porrebbero su una china scivolosa riguardo al suicidio assistito: l’accertamento della volontarietà; l’esistenza di agibili alternative al suicidio (cure palliative) che, come dimostra la pratica clinica, quando correttamente applicate, fanno scemare sensibilmente l’interesse dei malati terminali per la prospettiva del suicidio; le difficoltà connesse al controllo della pratica del suicidio medicalmente assistito una volta che questa fosse legalizzata. L’interpretazione di Arras al dettato della Task Force insiste sul fatto che queste tre ragioni vadano calate «nel sistema sociale esistente», o all’interno della «realtà sociale così come la conosciamo».
La seconda spiegazione è imperniata sulla forza trainante dell’«analogia delle giustificazioni»: «la logica stessa del caso esemplare di suicidio medicalmente assistito – sostiene Arras – basata com’è sui due pilastri dell’autonomia del paziente e della compassione, rende altamente improbabile che la società possa arrestarsi»28 alla legalizzazione di questi soli casi, sicché proprio la forza di questi due fondamenti ci spingerebbe fino all’eutanasia attiva non-volontaria/involontaria, passando per la tappa intermedia dell’eutanasia attiva volontaria29.
La china scivolosa è dunque una sorta di «difesa sociologica», un argomento non di principio, di tipo probabilistico, basato, cioè, su un pronostico sulle conseguenze di determinate decisioni ed atti30. Inoltre l’argomento è caratterizzato da una sorta di automatismo del suo funzionamento: esso, ad esempio, sarebbe in grado di predire che lo slittamento lungo la china avverrebbe comunque, quali che siano le precauzioni e i freni che noi potremmo escogitare per evitarlo. Da questo punto di vista appare chiaro che la china non ha in sé nulla di moralmente necessario: l’aver dimostrato l’inevitabilità della parabola non è ancora, di per sé, una rigorosa dimostrazione dell’immoralità delle condizioni in cui verremo a trovarci al temine della sua corsa. Per un verso anche la più sistematica estensione delle cure palliative non porterà mai a rendere del tutto superflua la questione del suicidio assistito; d’altro canto, per prevenire abusi o eventuali rovinose cadute lungo la china, non è indispensabile ricorrere alla proibizione del suicidio assistito o altre pratiche simili dal punto di vista delle conseguenze, come l’eutanasia attiva volontaria: sarebbe sufficiente la non proibitiva impresa di «escogitare un insieme di direttive e controlli»31.
La punta di diamante della replica all’impiego di argomenti consequenzialistici come la «china scivolosa» o la «rottura della diga», dunque, è che non basta asserire l’inevitabilità della deriva lungo il piano inclinato; occorre dimostrare perché ciò che troveremo, o potremmo trovare, nel corso della discesa ed in fondo ad essa, sarebbe da giudicarsi moralmente inaccettabile. Allo stesso modo, non basta avvertire del pericolo rappresentato da una china per dissuadere la collettività dal percorrerla, occorre ponderare i rischi rapportandoli alle opportunità che ciò può offrire. Molti sostenitori del suicidio assistito, e parte dell’opinione pubblica, infatti, non vedono di cattivo occhio neppure l’eutanasia attiva volontaria, dal momento che la sola differenza tra i due atti sta in chi agisce per ultimo. Così un piccolo cedimento su questo versante avrebbe come buona contropartita quella di prendere finalmente sul serio un diritto del morente: l’autonomia decisionale sulla propria fine.
Dell’argomento è stato fatto spesso un uso ingiustificato e «retorico», ignaro dei due assunti sui quali esso si basa e della loro fondatezza. Con il primo si assume che le linee di demarcazione che già esistono tra le diverse possibilità di intervento medico sulle fasi terminali della vita sono migliori di quelle che i fautori della legalizzazione del suicidio assistito vorrebbero sostituirvi, perché più chiare e soprattutto maggiormente in grado di «reggere le spinte verso direzioni pericolose»32. Icastica, in proposito, la sentenza di A. Flew, che esclude la rilevanza dei casi-limite rispetto al fine di tracciare linee di demarcazione33. A favore della legalizzazione, ad esempio, si sostiene sia scorretto escludere la possibilità del suicidio assistito sulla base della semplice considerazione dell’esiguo numero dei casi. Qualsiasi criterio di demarcazione noi usassimo, infatti, avremmo comunque dei casi non compresi. La semplice considerazione dell’esistenza di casi dubbi nelle zone di frontiera non giustifica affatto l’abolizione di ogni confine.
Il secondo assunto pone che la quota di rischio è impossibile da determinare perché legata anche all’imprevedibilità delle condizioni e delle trasformazioni di fattori sociali «quali l’espansione demografica, la scarsità di risorse, il fanatismo religioso, il razzismo»34.
Chi contesta l’argomento della china scivolosa lo fa spesso facendovi ricorso, come accade, per esempio adottando l’idea che se non si traccia una linea netta che consenta di legalizzare certe pratiche, l’abuso sarà inevitabile, con effetti disastrosi35. Avverso ai suoi detrattori sembra si voglia sostenere, in definitiva, che la china scivolosa deve la sua forza cogente all’impossibilità di prevedere ed includere tutti i casi e i rischi connessi ai processi di complessificazione ed integrazione sociale36, rispetto ai quali la legalizzazione del suicidio assistito andrebbe a costituire un’ulteriore variabile. L’argomento, allora, non sarebbe affatto basato su una paura quasi superstiziosa del rischio connesso deterministicamente, e tuttavia misteriosamente, alle conseguenze di certi atti, ma sulla autoconsapevolezza della struttura metaetica stessa del consequenzialismo.
3. Eutanasia e suicidio assistito tra cognitivismo e non cognitivismo
«Io non debbo mai essere solo: ecco l’imperativo etico fondamentale che fonda la mia persona, e che al tempo stesso fonda l’intersoggettività delle mie distinte valorizzazioni della vita, del mio continuo trascendermi nel valore […] la verità è che questo imperativo ci accompagna e ci sostiene dalla culla alla tomba».
(E. De Martino)
L’obiettivo di una chiarificazione generale sulle fondazioni è difficile da cogliere ove non vengano adeguatamente esplicitate in primo luogo le proprie opzioni metaetiche. Ciò risulta particolarmente evidente tanto nelle proposte di «nuove» linee di demarcazione quanto nelle classificazioni di tesi circa l’eutanasia finora portate ad esempio. Queste, infatti, sono sempre strettamente connesse ai diversi esiti cui conducono l’analisi e la valutazione dell’atto esterno operate a partire da diversi presupposti di fondazione della norma.
Ci si può chiedere «perché al dottore dovrebbe essere permesso di ignorare la scelta a favore della morte operata dal paziente» (R. G. Frey) qualora non interferiscano impedimenti di qualsiasi genere al suo consenso competente ed informato. Se, da una parte, ciò consentirebbe di accomunare nel giudizio etico svariate ipotesi di intervento medico sul malato terminale, elevato a criterio pratico e applicato rigorosamente, non sarebbe però in grado di distinguere la condizione del richiedente assistenza medica per suicidarsi da quella, invero paradossale, ma non autocontraddittoria, di un malato terminale che cercasse di ottenere dal medico che questi si accanisse terapeuticamente su di lui o del criminale che, pentitosi, chiedesse gli venisse irrogata la pena di morte o una qualsiasi altra punizione non prevista o più grave della sanzione comminata dall’ordinamento per il delitto da lui commesso. Si può certo eccepire che l’ipotesi dell’autolesionismo sarebbe verosimilmente assai rara; non sarebbe affatto difficile, tuttavia, immaginare una casistica in questa direzione, anche raccogliendo esempi dal passato.
Ora, se si abolisse la classificazione tradizionale degli atti medici sul morente per sostituirvene una basata sul suddetto criterio, più che promuovere la dignità del morire rischieremmo di scatenare l’accanimento terapeutico, come vedremo diffusamente più avanti.
Com’è stato lapidariamente detto, c’è un’ora in cui è difficile dire se sia ancora giorno o già notte, anche se, in generale, luce e tenebre sono ovviamente fatti ben distinguibili da tutti37. Spesso non è così facile dare ragione di evidenze morali immediate, universalmente diffuse e chiaramente percepite. Ad esempio, occorrerebbe fare, obiettivamente, uno sforzo su se stessi qualora si volesse evitare di prendere in considerazione la grossa differenza che il senso comune coglie intuitivamente tra terapie in grado di prolungare la vita e quegli stessi trattamenti che, posti in altre situazioni cliniche e umane, non farebbero che prolungare la morte. Se è difficile, impossibile per taluni, tracciare un confine oggettivo tra sospensione e cure palliative, da una parte, e suicidio assistito, dall’altra, ciò non toglie che tale differenza possa essere chiaramente percepita da una collettività comunicante, sulla base, diciamo così, del proprio istinto morale38. È esattamente ciò che accadrebbe ai fautori del suicidio assistito se chiedessimo che differenza passa tra il dare la morte al paziente che ne abbia consapevolmente fatto richiesta fornendogli o somministrandogli farmaci letali e lasciare che un parente o un amico ottenga lo stesso risultato premendogli un cuscino sulla faccia39. I modi del suicidio assistito sono istintivamente percepiti come parte del giudizio di liceità: essi si devono presentare, in un qualche senso, come modalità «mediche», anche se risulterebbe arduo dire in che cosa esattamente consista, sul piano morale, la differenza con altre pratiche che non presentino tale peculiarità.
Anche se il confine tra due diverse situazioni morali, in certe circostanze, è difficile da segnare, non per questo è corretto giudicarle moralmente come se si trattasse della medesima. Il punto, in genere, è da quale lato confrontare le cose; dal momento che non mancano tra loro somiglianze, la questione è: quali di questi aspetti sono essenziali? Tenendo in conto l’intera struttura dell’atto ed in particolare la natura strettamente cooperativa dell’atto terapeutico e dei rispettivi fini degli agenti morali, il fatto che l’atto terapeutico implica, in generale, a vari gradi, l’invasione del corpo del paziente e che in determinate circostanze ciò può raggiungere e superare i limiti della sopportabilità, una terza via, equidistante tra accanimento terapeutico e suicidio assistito, è possibile trovarla, e in molti casi percorrerla, facendo ricorso a strumenti concettuali, quali il teorema del duplice effetto, già noti alla nostra tradizione di pensiero. Specialmente negli atti caratterizzati dall’agire cooperativo, il principio dell’azione con duplice effetto è assai più frequente e spontaneamente applicato di quanto a prima vista non si sia portati a credere. Che l’istinto morale del senso comune tenda spontaneamente ad applicare simili ragionamenti, in particolare nella cooperazione, in cui ci si intende in vista di un fine unico, mostra che il finalismo sotteso al teorema, lungi dall’essere artificioso o fittizio, è quello che meglio rispecchia il funzionamento naturale della ragion pratica.
Pur trattandosi di un tema in cui risulta particolarmente difficile porre questioni del genere, la tentazione di rinunciare alla ricerca ed alla giustificazione etica di questa terza via è legata non ad una qualche intrinseca impervietà metafisica del problema, ma all’attitudine, strettamente legata alla fondazione normativa di stampo consequenzialista, a respingere precisamente la domanda sull’essenza dell’atto umano.
Si è visto che il giudizio espresso consequenzialisticamente sul suicidio assistito passa attraverso l’abolizione delle differenze tra questo atto e la sospensione del trattamento terapeutico in ragione del fatto che rientra fra le conseguenze di entrambi un elemento cooperativo40, vale a dire la soddisfazione delle preferenze del paziente. Il prestare assistenza medica al suicidio può, dunque, ricevere una giustificazione fondata sulle conseguenze dell’atto solo in quanto subordinato alla soddisfazione delle preferenze della persona competente; ma in che modo il consequenzialismo può prendere in considerazione la cooperazione? È infatti possibile tracciare una distinzione tra cooperazione materiale e formale.
Ora, sulla base dei presupposti del consequenzialismo le preferenze risultano per definizione soggettive, incomunicabili, inconoscibili; sempre in base ai medesimi presupposti, d’altronde, chiunque agisce lo fa spinto da preferenze soggettive. La particolare indole degli atti propri della cura medica fa sì, tuttavia, che, se le preferenze del paziente non fossero dal medico intese per se stesse, l’asimmetria di potere sul controllo delle conseguenze degli atti, tipica del rapporto medico-paziente, verrebbe senz’altro ad accentuarsi, ovviamente a discapito di quest’ultimo. Le preferenze del paziente, in quanto tale, circa il proprio benessere e la qualità della propria vita, infatti, non possono esser viste come altro rispetto alla sua stessa persona. La moralità dell’atto medico di assistenza al suicidio, dunque, può esser garantita solo se il medico fa proprie le preferenze del malato. Ciò però esclude un ruolo puramente strumentale dell’atto medico, ne riconosce la valenza morale sul piano oggettivo, ci troviamo cioè sul terreno di una cooperazione formale. In altre parole non si può cooperare a un suicidio, prestando cure mediche, se non uccidendo in senso formale.
Il punto qui consiste nel vedere se l’agire del medico, anche sotto il profilo deontologico-professionale, possa ridursi a una mera funzione strumentale-materiale. Occorre vedere se sia veramente possibile separare, nell’intenzione del medico, la volontà che vuole il fine dell’atto oggettivo (morte del paziente) da quella che vuole sia fatta la volontà del paziente. Può davvero il medico prescindere dal proprio giudizio morale (che può anche essere negativo) sull’atto in sé e sulla sua applicazione alla circostanza particolare, per volgere la propria intenzione esclusivamente alla volontà del paziente (che, per amore di tesi, si suppone sempre infallibilmente buona, purché valida)? 41
Nel suicidio assistito, quand’anche fosse il medico ad agire per ultimo, l’iniziativa è comunque da ascrivere senz’altro al paziente, ma questi cerca di procurarsi il consenso in vista di un vero atto morale del medico, il quale dovrebbe, pertanto, formulare un nuovo ragionamento morale, applicare di nuovo la regola aurea e gli altri principi, benevolenza, giustizia e autonomia, considerando certamente, tra l’altro, che il paziente non godrà del beneficio di una seconda possibilità di scelta. Anche sotto questo profilo alla sospensione del trattamento futile e al suicidio assistito si applicherebbe teleologicamente un giudizio morale identico, quanto a struttura formale, ma naturalmente di segno opposto, quanto all’enunciazione della norma: quand’anche concedessimo, infatti, che il rifiuto del trattamento non fosse che un «suicidio», la richiesta di sospensione della terapia da parte di un paziente capace non sarebbe che una ritrattazione del consenso, ritirando il quale il malato farebbe cessare la cooperazione e con essa ogni responsabilità morale del medico. La sospensione stessa, dunque, da questo punto di vista, non è altro che un caso-limite della formulazione del consenso, il quale, dopo essere stato prestato, viene ora negato da parte del paziente.
In conclusione, la cooperazione medica al suicidio non può verificarsi nel caso in cui il malato terminale chieda la sospensione della terapia: la terapia non può cominciare, perciò neppure continuare, senza consenso da parte del paziente, se il medico vuole mantenere all’atto la sua qualità moralmente buona. Quand’anche mirasse alla tutela della vita fisica del paziente, un atto che violasse il consenso si rivelerebbe strutturalmente immorale e non sarebbe insensato, allora, tornare a parlare di accanimento terapeutico, riteniamo, anche nell’ipotesi in cui il trattamento, che non si fosse ancora rivelato futile, fosse tuttavia giudicato insopportabile dal paziente moralmente maturo. Nell’ipotesi che configura una sospensione del trattamento terapeutico, dunque, il paziente ritira, non presta più o comunque nega il proprio consenso alla cooperazione; nello scenario adombrato dal suicidio medicalmente assistito, invece, il paziente richiede il consenso del medico e l’atto potrebbe perfezionarsi, anche sotto il profilo morale, solo con il consenso del medico a cooperare. La diversità dei ruoli assunti dagli agenti morali nei due casi non è considerata indifferente nell’ottica che prende l’intenzione del fine come criterio di rilevanza della qualità morale dell’azione; ma questa sostanziale differenza, mentre riceve scarsa considerazione, o addirittura nulla, in una considerazione atomistica dell’atto42, può cogliersi solo alla luce del carattere essenziale della cooperazione nel giudizio morale su questo genere di atti.
3.1. Circa l’argomento dell’analisi costi/benefici. Una critica cognitivista
Poiché il rischio di abusi si presenta ugualmente sia nell’ipotesi della sospensione che in quella dell’assistenza e poiché non abbiamo dati certi su quale delle popolazioni interessate ricaverebbe dalla legalizzazione del suicidio assistito un più favorevole saldo del calcolo costi/benefici in termini quantitativi e qualitativi (benessere e autonomia), i fautori della legalizzazione del suicidio assistito sostengono che, «come minimo», l’onere della prova dovrebbe ricadere «su coloro che vorrebbero impedire la legalizzazione di tale pretesa». Ma perché dovrebbe essere così? I motivi potrebbero essere due. Il primo è che la pretesa a ricevere assistenza al suicidio rappresenti un titolo maggiore rispetto all’interesse a non subire pressioni morali e psicologiche che incoraggino al suicidio; il secondo è l’appello al principio di ragionevolezza che attribuisce l’onus probandi all’interpretazione o all’ipotesi più restrittiva per la libertà.
Quanto al primo tra i due possibili motivi, alla luce della massima in dubio melior est pars possidentis, non appare corretto che l’onere della prova cada su chi nega la liceità del suicidio assistito. Le ragioni di chi, procedendo sull’analisi di danni e vantaggi, conclude prudentemente per la conservazione dello status quo possono infatti intendersi in questo modo: nell’eventualità di una legalizzazione del suicidio assistito, nel complesso i rischi di abusi certamente aumenterebbero, perché a quelli comunque presenti anche nella situazione attuale dell’ordinamento se ne aggiungerebbero di nuovi. A questo punto le parti in causa del dubbio tornano ad essere i candidati al suicidio assistito e i pazienti implicati nel caso di sospensione della somministrazione di terapie. Questi ultimi possono considerarsi in possesso di una presunzione di diritto assai risalente, come testimonia l’adagio voluntas aegroti suprema lex. È vero che, per ipotesi, tale presunzione è caduta nel dubbio, ma in tal senso è dubbia anche la «pretesa stringente» a ricevere assistenza medica nel suicidio, che, per giunta, non può vantare il favore del jus conditum.
Quanto al secondo motivo dobbiamo ricordare, preliminarmente, che l’assunto di riferimento non mira a formulare in via diretta la liceità del suicidio medicalmente assistito ma a mostrare non necessaria l’opinione che quest’atto medico abbia un significato morale diverso dagli interventi medici nelle fasi terminali della vita generalmente permessi dalla legge e vada dunque trattato in maniera diversa. Neppure ricorrendo al calcolo costi/benefici gli argomenti consequenzialisti giungono ad un giudizio certo di liceità sul suicidio medicalmente assistito, ma solo al fatto che l’onere della prova spetterebbe a chi la nega. Date tali premesse, sembra che nulla obbligherebbe, in ogni caso, a non ritenere illecite entrambe le pratiche. Perciò, per ipotesi, la liceità o illiceità di entrambe è dubbia.
Scendiamo ora più a fondo nel merito della questione. Il criterio di ragionevolezza che impone di applicare la misura meno restrittiva può essere formulato in questo modo:
«È ragionevole una misura restrittiva dei diritti fondamentali se, oltre a essere necessaria, è l’unico mezzo praticabile o il più mite tra quelli praticabili (criterio del minor danno)»43.
Potremmo applicare il principio di favorire l’interpretazione meno restrittiva in due distinte situazioni: se si discutesse di estendere il divieto, che colpisce una certa classe di atti, ad altri, che presentano certe analogie coi primi, considerati leciti da una legge dubbia: in una tale evenienza, fornire la prova spetterebbe a chi ritenesse che la legge non sia abbastanza restrittiva. Viceversa, se la questione si ponesse nei termini di un’estensione della norma più permissiva di cui gode una certa classe di atti (nel caso: gli atti di sospensione della terapia a chi ne faccia richiesta) ad un’altra, comprendente atti apparentemente analoghi sotto il profilo morale, ma considerati illeciti da una legge dubbia (esempio: atti di assistenza medica al suicidio) in tale circostanza il peso della prova ricadrebbe su chi ritiene che la legge posta in dubbio non sia la meno restrittiva possibile.
Delle due situazioni, quest’ultima è esattamente quella prospettata dai sostenitori della legalizzazione del suicidio assistito; mentre la prima, la restrizione del permesso o l’estensione del divieto, non è quella contemplata da chi non propone che lo status quo. Se poi si intendesse semplicemente dire che occorre scegliere, tra due proposizioni dubbie, la meno restrittiva per la libertà rispetto all’avversa, non potremmo evitare di incorrere in una petitio principii, poiché non potremmo sapere quale proposizione sia più restrittiva, e a chi spetti l’onere della prova, se prima non sciogliessimo il dubbio se trattare entrambi gli atti come legalmente permissibili o meno. Quand’anche si ammettesse che il cammino sin qui compiuto a partire dai presupposti consequenzialisti fosse servito a guadagnare che sospensione del trattamento terapeutico, cure palliative e suicidio assistito siano tutti atti equivalenti sotto il profilo morale, a noi pare che siano quanti affermano che il suicidio medicalmente assistito debba essere permesso dalle leggi a trovarsi ancora davanti la non facile impresa di sostenere il peso della prova44.
Si ricorderà, però, che l’aspetto centrale della polemica imperniata sulla valutazione di vantaggi e penalità non è quello che abbiamo appena finito di commentare, ma è legato piuttosto al reperimento di criteri non arbitrari di delimitazione della classe rilevante dei destinatari di un eventuale permesso legale di praticare l’assistenza medica al suicidio. Il nocciolo della questione, dunque, a quel che sembra, è che chi diversifica il proprio giudizio su sospensione della terapia e suicidio assistito lo fa riferendosi a fondazioni diverse, una volta facendo appello al diritto assoluto dell’ammalato di rifiutare la terapia, un’altra sulla base dell’analisi costi/benefici. Questa analisi dovrebbe invece dipendere essa stessa dall’estensione della classe di soggetti cui applicarsi e dunque, come s’è detto, da un criterio di rilevanza, un «titolo». Anche se si tratta non di un diritto giuridico, cui corrisponda un «dovere» o un obbligo da parte del medico o altri, ma piuttosto di una pretesa, di un «titolo morale» cui corrisponderebbe solo un permesso, tale «diritto», tuttavia, dovrebbe avere una ricaduta sul piano delle politiche pubbliche.
«Gli oppositori […] usano [la nozione di idoneità al suicidio assistito] in modo tale che, se una donna entra in ospedale per rimuovere delle pellicine da un’unghia, si può considerarla idonea al suicidio medicalmente assistito. Ma ciò è semplicemente sciocco. La classe rilevante è quella dei pazienti che soffrono di una malattia terminale o incurabile e intrattabile, che sono competenti, e che non sono in una posizione tale da poter morire in seguito alla sospensione o non-somministrazione del trattamento»45.
È proprio questo il punto che ci sembra indissolubilmente connesso alla difficoltà cui va incontro la determinazione di una «classe rilevante» che si voglia stabilire ricorrendo a criteri convenzionalistici. Solitamente, per determinare l’estensione della classe rilevante abbiamo bisogno di un criterio di rilevanza; nel nostro caso, ciò può essere l’interesse a ricevere assistenza al suicidio. Sennonché i criteri sui quali si modella la classe rilevante non dovrebbero a loro volta essere convenzionali. Le preferenze espresse hanno una loro oggettività fattuale finché le assumiamo, per definizione, di pari valore; l’estensione della classe rilevante andrebbe stabilita unicamente in base a queste. Ma nel caso in esame ciò è esattamente come dire che tutti i pazienti hanno titolo al suicidio assistito. D’altra parte se si volesse schivare l’obiezione ricorrendo a criteri, sarebbe come voler attribuire a certe preferenze un titolo maggiore che ad altre e ciò non lo si potrà fare a meno di modellare tali criteri sullo stampo di una classe rilevante stabilita convenzionalmente, il che è un’evidente petitio. Qui infatti accadrebbe che per individuare chi ha titolo all’assistenza abbiamo bisogno di una classe rilevante, per stabilire la quale si assume questo stesso interesse o pretesa quale criterio di rilevanza.
Che significa tutto ciò per il nostro tema? Dato che la qualità morale delle conseguenze risulta essa stessa rilevabile solo dalla possibilità di soddisfare preferenze, non sembrano rimanere in realtà argomenti cui appellarsi per negare assistenza medica al suicidio di una persona capace e consenziente e tuttavia non affetta da patologie orribilmente dolorose e/o in fase terminale. È significativo, perché coerente con la logica interna alle premesse consequenzialiste, che qualcuno abbia asserito che l’assistenza medica al suicidio andrebbe garantita anche al paziente che potesse compiere da solo le operazioni necessarie allo scopo46. A voler essere rigorosi, però, una volta assunti i presupposti del consequenzialismo, sarebbe perfettamente onesto sul piano intellettuale ammettere che semplicemente non esistono ragioni per negare assistenza medica al suicidio a qualsiasi persona giuridicamente capace ne faccia richiesta in qualsivoglia circostanza.
Un secondo livello di riflessioni si colloca su un piano più rigorosamente di principio e riguarda le difficoltà che sorgerebbero dall’ipotesi di una traduzione dei criteri di accertamento della competenza del candidato al suicidio assistito in termini giuridicamente controllabili. C’è un’analogia non accidentale tra una fondazione convenzionalistica o contrattualista delle pretese morali e dei diritti, in cui tutti si vedono riconosciuti certi titoli in quanto ciascuno li proclama per sé, ed una visione della cooperazione e della comunicazione morale quali strumenti, per quanto indispensabili, sostanzialmente estranei a quegli stessi fini individuali; così come esiste un preciso rapporto tra l’ammissione di un fondamento conoscibile dei diritti, posto al di là di ogni preferenza individuale empiricamente esperita, di ogni motivazione storicamente formulata e la concezione dell’intersoggettività quale orizzonte di senso e condizione di praticabilità dei diritti stessi.
«A tutti i pazienti che scelgono la morte e che sono competenti, informati e capaci di scelta volontaria viene negato ciò che scelgono sulla base che altri, forse più vulnerabili e più numerosi pazienti incorrano nella stessa sorte. Ma in che modo esattamente una politica che incorpora questo genere di rifiuto può riflettere una qualsiasi forma di impegno a favore dell’autonomia dei pazienti? Come può manifestarsi un tale impegno se coloro che sono capaci di operare scelte autonome circa la propria assistenza ed il proprio trattamento risultano sistematicamente perdenti rispetto alla scelta della morte per ragioni che hanno a che vedere, almeno in molti casi, con coloro che non sono autonomi? C’è qualcosa di strano in una visione della medicina in cui l’autonomia del paziente è tenuta in grande considerazione, ma nella quale, nei frangenti più cruciali della vita, tale autonomia è sistematicamente negata»47.
Allorché una norma è inserita nell’ordinamento, essa vale per tutti ed è posta non a vantaggio di qualcuno o a discapito di una classe di cittadini ma a tutela dell’intera società. Il velo di maya di cui per noi è rivestito il futuro fa sì che non sappiamo quali individui empirici, chi tra noi entrerà esistenzialmente a far parte di questa o quella classe, se nel novero dei pazienti autonomi, terminali, insopportabilmente sofferenti, oppure in quello dei non autonomi. In questo modo la norma mira a tutelare l’autonomia di tutti, senza distinzioni. Il fatto è che nella prospettiva consequenzialista è inevitabile scambiare per «autonomia» una sua particolare visione, astratta e solipsistica. A tale concezione si può a buon diritto contrapporre un’autonomia relazionale non avulsa dal contesto delle mediazioni storiche dell’intersoggettività, l’autonomia tipica di un soggetto dalla personalità psicologicamente e moralmente adeguata48, consapevole dei propri presupposti coesistenziali e non disinteressata agli effetti politici delle proprie scelte.
3.2. Cosa c’è in fondo alla china
L’argomento della china scivolosa non deve guardare solo nella direzione di un’incontrollabile valanga di conseguenze inaccettabili, ma anche verso un esagerato ispessimento dei margini di sicurezza e di un prevedibilissimo tuziorismo di reazione.
Gli argomenti a favore della legalizzazione del suicidio assistito approdano direttamente non ad un giudizio di liceità ma ad una abolizione dei confini tradizionali che distinguono i vari tipi di assistenza medica al morire; dunque resta sempre il fatto che partire da tali premesse non conduce affatto a concludere che si debba estendere il giudizio moralmente favorevole sulla «sospensione di trattamento» anche al suicidio assistito, ma semmai a riservare ad entrambi lo stesso giudizio. Attenendosi strettamente, poi, alla logica del calcolo utilitaristico, finché la manipolazione del consenso (il rischio connesso sia alla sospensione che all’assistenza, maggiormente messo in evidenza in ambito consequenzialista) sia considerato un danno dai più, non si vede come, senza interna contraddizione, il giudizio morale potrebbe non risultare addirittura più restrittivo dello status quo, dovendosi esprimere negativamente non solo a carico del suicidio medicalmente assistito ma anche sulla sospensione del trattamento terapeutico. Perciò occorrerebbe additare un rischio, solitamente non rilevato49, sotteso all’idea che non si debba né si possa distinguere tra consentire alla richiesta del paziente di omettere una terapia (atto omissivo, eutanasia passiva) e offrire assistenza al suicidio (atto commissivo), annidato nell’abolizione di ogni differenza logica tra «uccidere» e «lasciar morire»: una volta assunto il punto di vista delle conseguenze dell’atto, non è più possibile in effetti rilevare alcuna differenza, non solo tra suicidio assistito ed eutanasia volontaria passiva ma anche tra questa e l’eutanasia volontaria attiva; la mancata distinzione, tuttavia, non condurrebbe necessariamente ad una maggiore tutela della dignità del morente, ma possibilmente ad una crescita dell’accanimento terapeutico.
La ragione di questo paradosso risiede proprio in un’insufficiente considerazione delle dinamiche cooperative che verrebbero ad instaurarsi nelle circostanze. Se venisse a prevalere nella pubblica opinione l’idea che tra sospensione del trattamento terapeutico (lasciar morire) ed uccisione diretta del paziente consenziente non vi sia davvero che una differenza tanto piccola da essere trascurabile, è facile prevedere il verificarsi di una sorta di polarizzazione degli interventi sanitari sul morente tra accanimento terapeutico e assistenza al suicidio; ma se davvero il cosiddetto «lasciar morire» non fosse che una minima variante del «causare deliberatamente la morte», ragioni deontologiche spingerebbero il medico verso l’accanimento terapeutico con la forza di un dovere di coscienza. La morte del paziente vissuta come scacco professionale del medico, in quanto movente profondo dell’accanimento terapeutico, è già oggi rilevata da più parti come qualcosa di più di un puro luogo letterario; un pericolo ben più presente di quanto non siano i rischi di manipolazione del consenso50.
Anche il cosiddetto testamento biologico non risolverebbe tutti i problemi, a meno che non fosse reso obbligatorio (e riemerge qui il paradossale tratto caratteristico degli esiti controevidenti di ogni misura convenzionalistica): che avverrebbe, infatti, a chi non volesse o non avesse potuto redigere tale documento?
Esiste inoltre l’urgenza, specie nel nostro Paese, di vincere il pregiudizio, diffuso tra l’opinione pubblica, che le cure palliative siano una forma di eutanasia. Si tratta per di più di cure economicamente onerose, che richiedono un’alta specializzazione del personale e strutture apposite con ingenti spese di gestione51. Il loro inserimento nel sistema sanitario richiede una forte convergenza di volontà politica e consenso dell’opinione pubblica. Il tentativo massimalista di abolire ogni distinzione, compresa quella tra cure palliative ed eutanasia, non sarebbe controproducente in vista del conseguimento di questi interessi immediati e concretamente raggiungibili dei malati terminali?
Rischiare di sovrapporre all’accanimento terapeutico un «accanimento burocratico» finirebbe prevedibilmente per aumentare le sofferenze del malato terminale e diminuirebbe certamente i presidi alla sua riservatezza: non si verrebbe semplicemente a sostituire (ed, al limite, sommare) al tecnicismo terapeutico un’altra sovrastruttura, questa volta tecno-burocratica, alla dignità del morire? Come si potrebbe, in concreto, misurare la competenza morale del morente? Somministrandogli test, sottoponendolo ad un counseling psicologico, saggiandone il curriculum studiorum, o effettuando un rilevamento tramite un questionario? La pretesa di misurare e controllare la capacità giuridica e morale del paziente insieme a un’ancor più marcata medicalizzazione del morire e burocratizzazione della professione medica non allontanerebbero il paziente dall’appropriazione ed esercizio del suo diritto ad una morte umana, piuttosto che favorirli?
Sul sottile crinale, lungo cui ci stiamo muovendo, incontriamo dunque, in un primo momento, ragioni strategiche, o di opportunità, che mettono in guardia dal rimuovere certi argini normativi: sarebbe davvero nell’interesse di chi ora sta soffrendo rischiare di provocare la suddetta polarizzazione dell’atteggiamento della medicina sui possibili modi di intervenire nella fasi finali della malattia mortale, nell’illusione di fare in tal modo un passo avanti nel lungo cammino che resta da compiere per umanizzare il morire? È davvero nell’interesse di tutti noi…?
Oltre al cumulo di rischi, più o meno incombenti, messi in luce dalla stessa critica interna al consequenzialismo, quest’argomento rappresenta, inoltre, un test utile all’analisi delle strutture epistemologiche di questa fondazione. Su di esso riposano contemporaneamente considerazioni sull’inettitudine nomotetica del consequenzialismo e sulla forma complessiva dell’ordinamento giuridico nel suo rapporto organico con la società. A parere di chi scrive, il dibattito metaetico intorno all’argomento della china scivolosa è esso stesso posto su un pendio sdrucciolevole, nel senso che produce il paradossale effetto di mettere a nudo le aporie cui perviene la fondazione della norma di tipo consequenzialista.
Da una parte, l’argomento è puramente congetturale, basato sulla coscienza che il consequenzialismo possiede di non poter vantare certezze di principio o non poter escludere, per necessità logica, l’insorgenza di imprevedibili dati di fatto che possano rendere incontrollabili le conseguenze di un atto. Sotto questa luce il consequenzialismo presenta interessanti analogie epistemologiche con l’induttivismo metodologico. L’analisi dei fattori di rischio è perseguita, per così dire, induttivamente, secondo un procedimento che consente di giungere, al massimo, a conclusioni altamente probabili, mai logicamente necessarie52.
Per un altro verso, in assenza di un criterio oggettivo, basato sulla liceità dell’atto umano piuttosto che sullo sforzo di individuare popolazioni di soggetti che potrebbero beneficiarne o risultarne danneggiati, saremmo obbligati, proprio dalle esigenze della logica interna del tipo di fondazione consequenzialista della norma, a spostare ad infinitum la linea di demarcazione, avviando così un’inarrestabile deriva…
Il nocciolo di verità dell’argomento della china scivolosa sembra però essere un altro ancora. Quanti si pronunciano per la liceità del suicidio assistito solitamente tendono a banalizzare, a non cogliere adeguatamente la serietà delle considerazioni sugli effetti della legalizzazione del suicidio assistito sull’ordinamento. Uno degli obiettivi dell’ordinamento, in uno stato di diritto, è la necessità di bilanciare e limitare i poteri all’interno del corpo sociale. Più che uno scenario nazista, in questo senso, il timore di ciò che si trova in fondo alla china riguarda piuttosto la dissoluzione dello spirito democratico dell’ordinamento.
«Qualora abbia seri motivi per ritenere che il paziente non sia competente, o non sia informato circa possibili alternative, o sia spinto a scegliere la morte da pressioni familiari, finanziarie o sociali, il dottore ha ragioni sufficientemente gravi per non onorare la richiesta del paziente […] perché al dottore dovrebbe essere permesso di ignorare la scelta a favore della morte operata dal paziente?»53
A parte la visione idealizzata del medico (di quale medico? Del luminare, di quello fresco di laurea, del non obiettore; di quello in possesso di una certa anzianità di servizio o di un particolare permesso? Dell’anestesista, dello psichiatra, del medico di famiglia, di tutti questi insieme?) come giudice freddo e imparziale, dotato di un’imperscrutabile capacità di sentenziare infallibilmente sulle questioni riguardanti il foro interno del paziente, espressioni come quelle sopra riportate, poste a poche righe di distanza l’una dall’altra, hanno la curiosa proprietà di affermare e contemporaneamente negare una totale discrezionalità del medico sulla vita del paziente e la sua autonomia professionale e morale. Se non fosse permesso di ignorare la richiesta di cooperare alla scelta suicida del paziente, il medico sarebbe privato del suo diritto-dovere di agire secondo coscienza; se invece gli fosse permesso di non ignorarla, l’ordinamento prevedrebbe un potere senza contrappesi e fuori controllo, riconosciuto dalla legge in capo alla classe medica; un potere anomalo di vita e di morte di un certo gruppo di cittadini su tutti gli altri. Pensiamo vi sia qualche buona ragione nel ritenere che la stragrande maggioranza dei medici non accetterebbe le schiaccianti responsabilità che deriverebbero loro da questo potere immenso54.
Vista sotto questa luce, cosa significa esattamente l’accusa, rivolta ai fautori della legalizzazione del suicidio assistito, di preparare inavvertitamente il terreno a certe forme naziste di controllo sulla società civile con la quale spesso si conclude il ricorso alla metafora epistemologica del piano inclinato? Le perplessità che vi si trovano al fondo non tengono conto solo del fatto che il giudizio dipende dal tremendo impatto psicologico delle situazioni esistenziali55, ma si riferiscono probabilmente, confusamente, a una visione atomistica dell’ordinamento in contrapposizione ad un modello che potremmo definire «gestaltico», di cui la coesistenzialità costituisce il fondamento. I timori dunque riguarderebbero anche (soprattutto?) un generale indebolimento del sistema normativo inteso come coerente Gestalt.
Esistono forme diverse di cooperazione; vi sono attività collettive in cui i singoli operatori mantengono finalità individuali ed esterne a quelle altrui ed all’attività stessa; ma vi sono anche forme dell’agire umano in cui la cooperazione stessa è tutt’uno con i fini individuali di tutti i partecipanti all’impresa collettiva e persino coincidente con quel particolare interesse che la propria esistenza personale rappresenta per ciascuno di loro. La cura medica non è l’unico esempio possibile ma è forse l’emblema di questo genere di cooperazione. Anche queste forme il diritto ha lo scopo di coordinare. La cooperazione, comunque sia, può ricevere un senso giuridico esclusivamente in vista della promozione, della difesa e della crescita della coesistenza. Si avverte, insomma, nel suicidio medicalmente assistito, come il germe dell’autodissoluzione, un attacco diretto al fondamento stesso dell’ordinamento.
L’aspetto meno considerato del dibattito sull’effettività cogente dell’argomento della china scivolosa è, forse, proprio questo. La legalizzazione del suicidio medicalmente assistito non condurrà mai a scenari di tipo nazista, perché i principi di capacità e consenso rappresentano barriere insormontabili perché ciò possa davvero succedere. Davanti agli abusi ed alle esagerazioni si potrà sempre obiettare che questi nascano non dalla logica interna alla norma, ma appunto da una sua violazione, ed appellarsi, anzi, ad un più rigoroso rispetto dei principi e a maggiori controlli per attivare le capacità di autoregolazione ed autodifesa del sistema normativo. Ma, paradossalmente, qui accadrebbe che proprio questi stessi principi verrebbero a trovarsi internamente e strutturalmente vulnerabili nel loro stesso sistema immunitario. Sarebbe proprio lo svolgimento logico di tali principi a determinare la dissoluzione dall’interno dell’intersoggettività che informa qualsiasi sistema normativo ed è perciò che questi avvertono, in certi possibili sviluppi di tali principi, una minaccia alla loro stabilità e coerenza ed alla stessa convivenza civile.
4. Misericordia e potere
«Questa eutanasia è una parte non trascurabile della felicità… [Se i medici] rispettassero i propri doveri nonché le esigenze della propria professione, non risparmierebbero nessuna cura per aiutare gli agonizzanti ad uscire da questo mondo con maggior dolcezza e facilità. Ora questa ricerca la qualifichiamo ricerca sull’eutanasia esteriore, che distinguiamo da quell’altra eutanasia che si riferisce alla preparazione dell’anima e che poniamo fra le nostre raccomandazioni»
(F. BACONE)
La proposta della legalizzazione del suicidio assistito, come del resto qualsiasi altra in tema di assistenza medica al morire, è contrassegnata culturalmente: si colloca all’interno di una certa antropologia e precisi stili di vita, forme di organizzazione sociale e convinzioni collettivamente condivise circa la salute, il corpo, i beni spirituali e secolari, materiali e non. Le proposte dei fautori del suicidio medicalmente assistito, in brevi parole, indicano la possibilità di trovare soluzioni incamminandosi per la via della radicalizzazione dei termini in cui si pone la situazione attuale del problema. Essi, in realtà, finiscono col legare ancor di più il problema alle cause «culturali» che lo determinano o lo aggravano in misura assai consistente: maggiore investimento di tecnologia sulla vita umana; un più elevato grado di medicalizzazione del morire; l’assegnazione di un ruolo ancora più esclusivo di competenza della professione medica sulla morte umana; la rimozione di qualsiasi residuo di senso che ancora ricada fuori delle scelte soggettive.
Gli effetti certamente prevedibili, come s’è detto, sono: una più accentuata riduzione della morte a procedura burocratica; l’accrescimento della spersonalizzazione del morire, del disagio affettivo e della solitudine del malato terminale; riduzione dell’autonomia del medico e del paziente e nel contempo un maggiore squilibrio nell’asimmetria del reciproco potere relativo; riduzione del livello di tutela giuridica ed innalzamento del rischio di accanimento terapeutico.
Esistono però, soprattutto, ragioni di principio che sconsigliano di abolire la distinzione teorica ed anzi prescrivono di valutare la diversa qualità morale dei vari atti medici, che abbiamo preso in considerazione, su un piano di intrinseca necessità morale.
La relazione cooperativa tra il paziente e il personale sanitario è un agire realmente morale, in misura della sua intenzionalità, ed impegna la responsabilità di tutti coloro che vi partecipano. Il medico deve chiedersi se sospendendo le cure o assistendo il paziente suicida egli coopera meglio al benessere di quella persona ed è al tempo stesso miglior medico ed essere umano migliore. L’esito del dilemma, al momento, non è affatto scontato.
L’impostazione teleologica, in quanto per qualificare moralmente l’atto prende in considerazione l’intero sistema di finalità, tratta la cooperazione56 come un vero atto umano di tutti i soggetti che vi prendono parte intenzionalmente, in maniera avvertita e consenziente.
In un’ottica teleologica, quando beni intrinseci della persona entrano in conflitto occorre tutelare quelli gerarchicamente superiori. Nel campo dell’etica medica ciò significa, ad esempio, che la medicina può e deve andare oltre la terapia: è precisamente il caso delle cure palliative. Ancora, poiché il rispetto del consenso, in quanto permette alla persona di appropriarsi della responsabilità morale del proprio agire, è prioritario nei confronti della stessa tutela della vita fisica, nel caso della sospensione del trattamento non è certamente il carattere apparentemente omissivo di certi atti del medico (ad esempio, arrestare la macchina terapeutica) che fa dire che egli interrompe una cooperazione, bensì il venir meno del consenso del paziente: il fine dell’atto del medico è conseguito pienamente con l’intenzione di rispettare la volontà dell’altro e con ciò la sua responsabilità cessa, senza estendersi alle conseguenze, che, a questo punto, per quanto lo riguarda, appaiono del tutto materiali.
Anche nel caso del suicidio assistito il giudizio teleologico considera che il medico non può agire professionalmente senza cooperare, né cooperare senza deliberare sul fine dell’atto e di sé; ma qui il consenso dato dal medico alla richiesta, da parte del paziente, di assistenza al suicidio, mette in moto una responsabilità che si estende per entrambi fin là dov’è il loro ultimo fine comune57.
Abbiamo lasciato per la conclusione qualche considerazione sul delicato e sostanziale problema del rapporto tra eutanasia e misericordia. Se non è sempre corretto, ed anzi nasconde grossi pericoli, asserire che il paziente voglia sempre (soprav)vivere, è sempre vero che ogni essere umano non può non volere il proprio bene. Sgombrato il campo di quei casi in cui egli si inganna nel ritenere sia bene per lui morire piuttosto che vivere, rimarranno pur sempre situazioni in cui la persona patisca una malattia mortale percependo, a ragione, il continuare a vivere in contrasto col vero significato della vita umana; un contrasto psicologicamente insanabile tra ciò che la sua vita è di fatto e il bene che invece deve essere, quello che egli merita in quanto intrinseco al fatto stesso di essere persona.
La questione insomma non è, qui, se, a certe condizioni, sia preferibile vivere o morire58, ma un più radicale contrasto tra vivere ed essere. Il conflitto non si pone affatto all’interno dei rapporti tra essere di persona e il suo bene in quanto coincidenti. Il bene intrinseco dell’essere di persona qui entra in conflitto piuttosto col continuare ad esserci.
Il dolore può rappresentare una costrizione; può in realtà non lasciare scelte. Il dolore come distruzione di ogni altra possibilità è una sorta di morte anticipata (possibilità della fine di ogni possibilità). La riflessione etica non può ignorare o respingere il dramma legato a questa manifestazione estrema della condizione esistenziale della persona incarnata.
S. Bok si chiede come sia «possibile che la sola via d’uscita» alla «terribile» e «diffusa incapacità di occuparsi in modo adeguato delle cure al termine della vita […] consista nel concedere a coloro che la scelgano qualche forma di eutanasia o di suicidio medicalmente assistito»59. Le soluzioni che vanno sostanzialmente nel senso di una burocratizzazione del morire in una struttura ospedaliera sono assai povere e, per principio, le più ingiuste; non tengono conto dei motivi delle preferenze del morente né possono in alcun modo tenere in qualche maggior conto motivi pietosi o di misericordia rispetto a preferenze basate, poniamo, su considerazioni di tipo economico. Da una parte, esporrebbero ancor di più la situazione del malato terminale all’effetto di espropriazione e spersonalizzazione prodotto dalle attuali condizioni storiche del morire, almeno nelle nostre società occidentali, dalla medicalizzazione della morte; ma, ancor meno delle attuali risposte che il diritto è in grado di dare a queste problematiche, una soluzione burocratica non può attingere, diciamo così, al modo di Pascal, la «finezza del vertice della verità e della giustizia» celate in fondo alla decisione di una persona di terminare la propria esistenza. Al di là delle intenzioni dei singoli, ed in una maniera che presenta significative analogie con l’accanimento terapeutico, questo genere di soluzioni sarebbe nient’altro che un ulteriore esercizio di dispotismo tecnocratico sulla vita umana.
La sola reale garanzia di autonomia per i pazienti terminali è la possibilità di accedere facilmente alle cure palliative. Anche un’eventuale legalizzazione del suicidio assistito, senza quest’opzione, lascerebbe monca l’autonomia del paziente, al quale si darebbe, certo, la possibilità di scegliere se, come e quando porre fine alla propria vita; ma quanto rimarrebbe della sua libertà di non scegliere la morte?
Il primo a far uso del termine «eutanasia» nel contesto dell’etica medica, che oggi gli è abituale, Francesco Bacone60, ne distingue due forme: interiore ed esteriore. Quest’ultima, più che il valore semantico che l’uso contemporaneo assegna alla nozione di eutanasia, ha in Bacone piuttosto il significato che oggi attribuiamo all’espressione “cure palliative”. Ma con ogni probabilità, nel quadro della terminologia baconiana, la misericordia nei riguardi di chi soffre inguaribilmente per una malattia terminale sarebbe compito precipuo ed esclusivo dell’eutanasia interna, la tradizionale arte della buona morte e dell’accompagnamento del morente. Tra le tante aggettivazioni e classificazioni dell’eutanasia occorrerebbe recuperare e reinterpretare questa, interna/esterna, scomparsa, plausibilmente, per il sempre più massiccio investimento tecnologico sul rapporto tra medico e paziente. Si aprono qui spazi per una comprensione del ruolo dei comitati di bioetica e per una rimessa in dialogo della medicina con le altre “professioni della cura”: l’educatore, l’uomo di legge, ossia le professioni di chi, a vario titolo è chiamato ad occuparsi della crescita e del benessere psicofisico e mentale, morale, relazionale e spirituale della persona.
Ciò che viene in questione, qui, è precisamente un diritto a una morte umanamente degna e la necessità, anche in tema di eutanasia, di far convergere in una “bioetica dei diritti” la riflessione sui diritti dell’uomo e quella sull’impatto etico prodotto dall’applicazione della razionalità tecnologica sulla vita umana.
I diritti sono come proprietà trascendentali della persona; in quanto tali sono indivisibili non solo nel loro complesso ma anche rispetto alla loro radice, la persona stessa. La violazione di qualcuno di essi nel tentativo di tutelare la persona, o viceversa, è il segnale della presenza di una qualche fallacia. Anche volendo prescindere dalla questione della liceità del suicidio, la cooperazione medica al suicidio apparirebbe comunque, sotto questa luce, una violazione del cosiddetto diritto alla morte, in quanto non potrebbe evitare di ledere beni e diritti della persona, come l’autonomia, la riservatezza e l’intimità. Per comprendere adeguatamente questo nodo teorico non basta aumentare il controllo dell’atto formalizzandone i passaggi procedurali fino alle sue estreme conseguenze; occorre, per così dire, compiere il cammino inverso, esplicitando l’interna strutturazione personalistica dell’atto umano, anche cooperativo, e i suoi intimi legami con i processi di comunicazione e di crescita della persona umana.
1 Cfr. F. Santeusanio, Il medico di fronte alla morte, in L. Alici et al., La dignità degli ultimi giorni, Cinisello Balsamo, San Paolo, 1998, p. 22.
2 Cfr. L. Alici, Filosofia della morte, in Ibidem, p. 84 e E. Sgreccia, Manuale di bioetica. I. Fondamenti ed etica biomedica, Milano, Vita e Pensiero, 1991, pp. 477-480.
3 Nella cooperazione umana esiste una convergenza, classicamente formulata nell’opera di O. Apel e J. Habermas, tra comunicazione, interessi, informazioni, ideali configgenti: aspetti profondamente connessi l’uno all’altro, in quanto non divisibili dall’intersoggettività. «L’unica forma per giungere ad un consenso intersoggettivo e libero da passioni, è il vero dialogo, il discorso critico o la comunità di comunicazione. Il modello ideale, secondo Apel, per risolvere i conflitti etico-politici è quello della cooperazione nella comunità di argomentazione, cooperazione che in linea di principio rende possibile far valere, mediante argomenti, le necessità e gli interessi, cioè le pretese delle persone coinvolte […] Affinché l’analisi della situazione sia completa, sarebbe necessario parlare anche di ideali in conflitto, dal momento che questi costituiscono un elemento di molto peso nelle discussioni morali» (M.J. Bertomeu, La ética en los comités de ética, Quirón, vol. XIX, 1988, 82, cit. in D. Gracia, Fondamenti di bioetica. Sviluppo storico e metodo (1989), tr. it., Cinisello Balsamo, San Paolo, 1993, p. 692).
4 «Una cattiva bioetica ha recentemente scoperto un paio di concetti che dovrebbero chiarificare l’ossatura del dibattito contemporaneo. A mio avviso i due concetti sono più degli slogan che effettivi termini-chiave: essi cercano di dividere il campo della discussione in due schieramenti opposti. I contendenti giocano in favore della “Qualità della vita” o della “Santità della vita”: in mezzo non vi è quasi nulla» (P. Cattorini, Qualità della vita ed etica clinica. Introduzione e principi generali. Conferenza di apertura, in Il contesto culturale dell’etica della vita, a cura di S. Leone e S. Privitera, Roma, Armando, 1994, p. 9).
5 Cfr. A. Macintyre, A short History of Ethics, New York, Collier Books, 1966.
6 Cfr. M. A. Sanchez-Gonzales, La qualità della vita nel processo decisionale sui malati terminali, in AA. VV., Il significato della morte, Roma, Armando, 1995, p. 109.
7 Il volume Euthanasia and Physician-Assisted Suicide di Gerald Dworkin, Raymond G. Frey e Sissela Bok, pubblicato nel 1998 negli Stati Uniti per la celebre collana «For and Against», è una testimonianza essenziale di questa polemica ed al tempo stesso un prezioso contributo che ci introduce nel mezzo della questione per il rigore esemplare delle scelte metodologiche degli autori e l’individuazione dei loro obiettivi. Da una parte, infatti, il tema non è trattato in tutta la sua ampiezza (e ambiguità, vorremmo aggiungere) ma alla luce di un singolo caso, accuratamente circostanziato e appositamente scelto in quanto caso limite, in grado di funzionare come una sorta di controllo sperimentale, i cui risultati, cioè, sono in condizione di falsificare in maniera necessaria l’ipotesi opposta. Citeremo di seguito dall’edizione italiana Eutanasia e suicidio assistito. Pro e contro, trad. it., Torino, Edizioni di Comunità, 2001.
8 Cfr. R. G. Frey, Distinzioni tra tipi di morte, in Ibidem, p. 31.
9 Proprio mentre scriviamo, viene pubblicato il documento circa le «Dichiarazioni anticipate di trattamento», col quale la Commissione Nazionale di Bioetica si allinea a questo giudizio. Il rapporto non si impegna sul terreno dell’eutanasia ma contiene indicazioni per una futura regolamentazione di legge in Italia in materia di sospensione del trattamento medico futile del malato terminale. Si tratta perciò, come si vede, di un documento che ha trovato una convergenza sul giudizio di illiceità riguardo l’accanimento terapeutico. Molti bioeticisti considereranno questo risultato una parola definitiva sull’argomento; molti altri vi vedranno solo il primo passo verso ulteriori ampliamenti nel senso dell’autonomia del paziente terminale; per cui è facilmente prevedibile che ben presto il dibattito imboccherà questa strada anche in Italia.
10 R. G. Frey, Distinzioni tra tipi di morte, cit., p. 42.
11 Scegliere la morte e togliere la vita, in G. Dworkin et al., Eutanasia e suicidio assistito. Pro e contro, cit., pp. 105-117.
12 Ibidem, p. 114.
13 Ibidem, p. 108.
14 Ibidem, p. 111.
15 When Death Is Sought. Assisted Suicide and Euthanasia in the Medical Context, Albany, N. Y., maggio 1994.
16 Cfr. J. D. Velleman, Against the right to die, in «Journal of Medicine and Philosophy», 17, 1992, p. 669, cit. in G. Dworkin, Politiche pubbliche e suicidio medicalmente assistito, in G. Dworkin et al., Eutanasia e suicidio assistito. Pro e contro, cit., p. 95. Velleman si oppone all’ammissione dell’esistenza di un diritto o di un permesso a ricevere assistenza medica a morire in quanto comporterebbe una perdita in termini di benessere-autonomia del paziente, nel senso che alcune persone potrebbero risultare svantaggiate (esposte a condizionamenti della propria libera scelta, pressioni psicologiche, sensi di colpa, ecc.) avendo a disposizione una tale opzione piuttosto che essendone prive.
17 Cfr. J. Feinberg, Overlooking the merits of the individual case. An unpromising approach to the right to die, in «Ratio Juris», 4, 1991, 2, pp. 131-151.
18 Cfr. G. Dworkin, Politiche pubbliche e suicidio medicalmente assistito, in G. Dworkin et al., Eutanasia e suicidio assistito. Pro e contro, cit., p. 86. Dworkin basa questa conclusione sulle statistiche olandesi su eutanasia e suicidio assistito.
19 Ibidem, p. 86.
20 Ibidem, p. 87. In corsivo nel testo.
21 New York State Task Force on Life and the Law, When Death Is Sought. Assisted Suicide and Euthanasia in the Medical Context, cit., pp. 132-133 passim. La versione qui citata si trova nella traduzione del contributo di Dworkin, già preso in esame alle pp. 91-93. I brani riportati nel nostro testo sono indicati da Dworkin come argomenti 7 e 8 del documento della Task Force. Frey riprende stralci di questi medesimi passaggi in Il timore della “china scivolosa”, in G. Dworkin et al., Eutanasia e suicidio assistito. Pro e contro, cit., p. 59.
22 F. G. Miller, T. E. Quill, H. Brody, J. C. Fletcher, L. O. Gostin, D. E. Meier, Requesting Physician-assisted Death, in «New England Journal of Medicine», 1994, n. 331, pp. 119-123.
23 Cfr. S. Bok, Eutanasia, in G. Dworkin et al., Eutanasia e suicidio assistito. Pro e contro, cit., p. 143. Una breve nota bibliografica sulla letteratura di maggiore spicco prodotta in lingua inglese sull’argomento tra gli anni ottanta e novanta si trova in R.G. Frey, Il timore della “china scivolosa”, cit., p. 53, nota 1.
24 Così H.T. Engelhardt jr., Fashioning an Ethics for Life and Death in a Post-modern Society, in «Hasting Center Report», 19, 1989, 7-9 (Supplement).
25 M. A. Sanchez-Gonzales, La qualità della vita nel processo decisionale sui malati terminali, cit., p. 120.
26 House of Lords on Care for Dying, in «Bulletin of Medical Ethics», 95, 1994, p. 13, nostro corsivo, cit. in P. Dalla-Vorgia, Il significato della morte in Grecia, in AA. VV., Il significato della morte, cit., p. 136.
27 J. Arras, On the Slippery Slope in the Empire State. The New York State Task Force on Physician-assisted Death, in «American Philosophical Association Newsletters», 95, 1996, pp. 80-83.
28 Ibidem, p. 81; cit anche in R.G. Frey, Il timore della “china scivolosa”, cit., pp. 64-65.
29 R.G. Frey, Il timore della “china scivolosa”, p. 74.
30 Ibidem, p. 54.
31Ibidem, p. 63. Pure Dworkin in Politiche pubbliche e suicidio medicalmente assistito, cit., ammette che questo tipo di problema, connesso ai criteri in virtù dei quali circoscrivere la classe rilevante alla quale sarebbe possibile applicare il permesso di assistenza medica al suicidio, è reale; egli ritiene, in merito, che esistano già proposte che, per quanto «imperfette», possano servire da criterio di demarcazione. In particolare, il professor Kluge dell’Università di Victoria, la cui proposta Dworkin sembra voler abbracciare, richiede che sia presente una malattia o una condizione medica irrimediabile vissute dal paziente come «incompatibili con i suoi valori fondamentali». Non considerare rilevante la presenza di dolore consente di prendere una posizione estensionista a proposito del testamento biologico (consenso anticipato, per procura, ecc.). Il criterio dell’irrimediabilità della malattia, poi, permette di prendere in considerazione certe patologie degenerative.
32 S. Bok, Scegliere la morte e togliere la vita, in G. Dworkin et al., Eutanasia e suicidio assistito. Pro e contro, cit., p. 114.
33 A. Flew, Thinking about Thinking or Do I Sincerely Want to be Right?, Glasgow, Fontana/Collins, 1975, cit. in S. BOK, Scegliere la morte e togliere la vita, cit., p. 145.
34 Quest’asserzione è suffragata dalle conclusioni di autorevoli inchieste. Particolarmente significativa è l’analisi dell’impatto della legalizzazione dell’eutanasia sui livelli complessivi di violenza in contesti politico-sociali caratterizzati da regimi autoritari, come in Cina, in cui si è lanciata una campagna favorevole all’eutanasia per contenere il numero di anziani, o da un alta conflittualità sociale, come in Colombia, la cui Corte Suprema ha dichiarato legale l’eutanasia nel 1997, all’epoca in cui, insieme al Sudafrica e alla Russia, la Colombia era il Paese dal più alto tasso di criminalità nel mondo (ibidem, pp. 158-159). Per quanto riguarda l’ordinamento olandese, uno studio del 1995 (P. J. van der Mass et al., Euthanasia, Physician-assisted Suicide, and Other Medical Practices involving the End of Life in Netherland, 1990-1995, in «New England Journal of Medicine», 335, 28 novembre 1996, n. 22, pp. 1699-1705) sull’applicazione delle leggi in materia conclude che si sono registrati 1000 casi di persone non capaci che erano state uccise dai medici in violazione delle direttive (S. Bok, Scegliere la morte o togliere la vita, cit., p. 157). Uno studio condotto su larga scala negli USA nello stesso anno (A Controlled Trial Improve Care for Seriously Ill Hospitalized Patients. Study to understand prognoses and preferences for outcomes and risks of treatments (Support), in «Journal of the American Medical Association», 274, 22-29 novembre 1995, n. 20, pp. 1591-1598; cit. in S. Bok, Scegliere la morte o togliere la vita, cit., p. 150) riscontrò gravi carenze di comunicazione, incomprensione e inadempienze dei medici nel rispettare la volontà dei pazienti di sospendere terapie stressanti. Tali condizioni oggi sono, forse, addirittura meno favorevoli che in passato: i progressi per ottenere un’assistenza «decente» si sono rivelati esigui; l’incapacità di offrire cure e sollievo adeguati alla fine della vita è tuttora «massiccia» e «persistente»; la diffusione dei testamenti biologici non riesce a fornire quella protezione che si sperava potesse garantire; il diritto del malato alla piena informazione continua ad essere disatteso ed «un’alta percentuale» di loro continua a morire dopo inutili sofferenze.
35 S. Bok, Scegliere la morte o togliere la vita, cit., p. 155.
36 Ibidem, p. 146.
37 E. Burke in A. Flew, Thinking about Thinking or Do I Sincerely Want to be Right?, cit., p. 104. Cfr. una metafora assai simile anche in W. Quine, Carnap e la verità logica (1957), in I modi del paradosso ed altri saggi, Milano, Il Saggiatore, 1975, p. 390, secondo il quale la conoscenza è come una stoffa nera di fatti e bianca di convenzioni dalla quale non si è mai riusciti ad estrarre tuttavia un solo filo del tutto nero o uno del tutto bianco.
38 Sul concetto di istinto morale cfr. K. Rahner, Il problema della manipolazione genetica (1967), in Nuovi saggi III, tr. it., Roma, Paoline, 1969, p. 360.
39 Cfr. S. Bok, Suicidio medicalmente assistito, cit., p. 164.
40 Cfr. R.G. Frey, Distinzioni tra tipi di morte, cit., p. 42.
41 Cfr. J. D. Velleman, Against the Right to Die, cit., p. 669.
42 Cfr. R.G. Frey, Distinzioni tra tipi di morte, cit., p. 44. Egli ritiene che, in entrambi i casi, il medico risponda ad una richiesta (venga incontro a preferenze) del paziente (p. 45).
43 F. Viola, Ragionevolezza, cooperazione, regola d’oro, in «Ars Interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica», 7, 2002, p. 115.
44 «La secolare proibizione dell’eutanasia volontaria [crea] una forte presunzione contro l’allentamento dei divieti di uccidere, già chiaramente inadeguati» (S. Bok, Eutanasia, cit., p. 146). «Se non vi è differenza di principio fra volere intenzionalmente la morte di qualcuno e limitarsi a permetterla, non vi sarà alcun impedimento morale assoluto contro l’anticipazione della morte, una volta che si sia deciso che il prolungamento della vita sarebbe dannoso […]. Considerato il diffuso rifiuto del suicidio assistito e dell’eutanasia nella nostra cultura, l’onere della prova […] sarebbe assai pesante» (H.T. von Engelhardt jr., Manuale di bioetica (1996) trad. it., Milano, Il Saggiatore, 1991, pp. 364-365).
45 G. Dworkin, Politiche pubbliche e suicidio medicalmente assistito, cit., p. 86. Anche le ultime espressioni riportate tra virgolette sono di Dworkin, ibidem, p. 81.
46 Cfr. Ibidem, p. 139; G. Holton, Percy Williams Bridgman, in «Bulletin of Atomic Scientists», 18, 1962, pp. 22-23.
47 R.G. Frey, Il timore della “china scivolosa”, cit., pp. 69-70.
48 Cfr. D. Snygg, A. W. Combs, Individual behaviour, New York, Harper and Row, 1959.
49Cfr. P. Verspieren, Eutanasia? Dall’accanimento terapeutico all’accompagnamento dei morenti (1984) trad. it, Cinisello Balsamo, San Paolo, 1985, p. 68.
50 Vedi i dati sconfortanti pubblicati da Support, già citati. Più del cinquanta per cento delle richieste di sospensione non sono prese in considerazione, spesso neppure trascritte, ecc. Si può ipotizzare che il fenomeno sia legato alla medicalizzazione della morte. Significativamente, secondo recenti indagini, tale atteggiamento si diffonde in oriente di pari passo alla penetrazione dei modelli di organizzazione sociale e sanitaria e degli stili di vita occidentali (Cfr. Y. Oguz, L’approccio «orientale» con la morte, in AA. VV., Il significato della morte, cit., pp. 100-101).
51 Si veda al proposito la descrizione del lavoro svolto nei celebri Hospices, inventati da C. Saunders, per la cura dei malati terminali, in P. Verspieren, Eutanasia?, cit., pp. 85-98. Una dettagliata descrizione delle terapie del dolore e delle tecniche di cure palliative disponibili in F. Santeusanio, Il medico di fronte alla morte, in L. Alici et al., La dignità degli ultimi giorni, cit., 1998, pp. 27-35.
52 «Fintanto che l’argomento del tipo “china scivolosa” ha a che fare con la possibilità più che con la certezza riguardo al futuro, tale pretesa di certezza è o avanzata avventatamente dagli oppositori di una determinata politica, o erroneamente imputata loro» (S. Bok, Eutanasia, cit., p. 146).
53 Ibidem, passim.
54 Cfr. S. Bok, Suicidio medicalmente assistito, cit., 169.
55 S. Bok, Eutanasia, cit., 147.
56 Poiché esistono vari generi di cooperazione, è bene precisare che intendiamo qui la cooperazione in senso stretto, dunque non quella in cui la finalità dell’altro è irrilevante o semplice mezzo per il raggiungimento della propria, ma quella in cui ciascuno fa propria la finalità altrui.
57 H. Jonas, Il diritto di morire, in «Comunità», 42, 1988, pp. 215-234.
58 «Se la vita non è sempre meglio della morte, può essere benefico anticipare la morte, invece di lasciare che “la natura faccia il suo corso”» (H.T. von Engelhardt jr., Manuale di bioetica, cit., p. 364).
59 S. Bok, Scegliere la morte e togliere la vita, cit., p. 105, passim.
60 Il termine in sé, invece, è in uso fin dall’antichità per indicare la morte «naturale», confortata dalla presenza degli affetti più cari; cfr. Svetonio, Vita dei Cesari: «Improvvisamente spirò tra le braccia di Livia, dicendo: “Livia, fin che vivi ricordati della nostra unione. Addio!”. Ebbe così una morte dolce, come aveva sempre desiderato. Infatti, quasi sempre quando gli si annunciava che la tale persona era morta rapidamente e senza soffrire, chiedeva agli dei per sé e per i suoi una simile “eutanasia” (questo è il termine di cui era solito servirsi)».
18









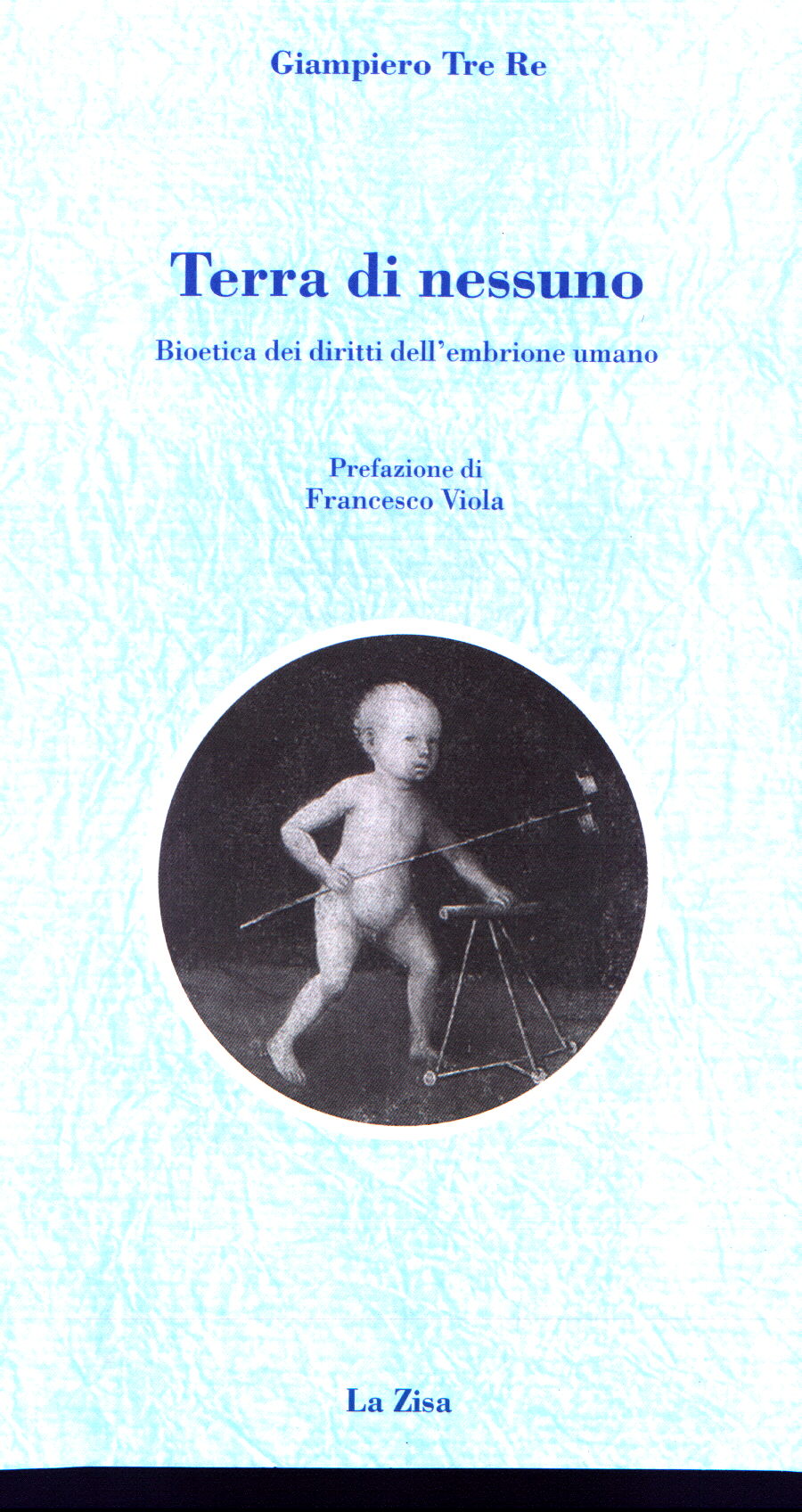
Aiutare a morire, in alcuni casi veramente drammatici, è un atto di carità verso chi lo chiede. Gli operatori sanitari non ubriacati da particolari condizionamenti mentali lo sanno bene e, quando lo negano mentono a se stessi.
Non tutti i medici sono capaci di agevolare il trapasso (escludendo i motivi professionali) , solo i più “vivi” generalmente sono quelli più ricchi d’iniziativa.
Mi dispiace, il suicidio è veramente terribile.
Pur troppo l’accumolo di sentimenti negativi come rabbia, paura, abbandono sono le parole chiave perchè nel tempo si verifica un suicido. Le vittime di queste persone ne soffrono anche perchè non conoscono pace e conforto…ma chi li potrebbe tutelare…
Ma cosa bisogna fare……mi dispiace ….morire senza un motivo specifico….
Mi dispiace, il suicidio è veramente terribile.
Pur troppo l’accumolo di sentimenti negativi come rabbia, paura, abbandono sono le parole chiave perchè nel tempo si verifica un suicido. Le vittime di queste persone ne soffrono anche perchè non conoscono pace e conforto…ma chi li potrebbe tutelare…
Ma cosa bisogna fare……mi dispiace ….morire senza un motivo specifico….forse si nasconde la mancanza di lavorare, vivere e comunicare con qualcuno….proprio per questo viene a crearsi il suicidio. Io prego per queste persone che possano trovare un rimedio.
Buona lettura