Paolo Cattorini, Qualità della vita ed etica clinica
Paolo Cattorini (Milano)*.
Qualità della vita ed etica clinica. Introduzione e principi generali
1. Prefazione
Una cattiva bioetica ha recentemente scoperto un paio di concetti che dovrebbero chiarificare l’ossatura del dibattito contemporaneo. A mio avviso i due concetti sono più degli slogan che effettivi termini-chiave: essi cercano di dividere il campo della discussione in due schieramenti opposti. I contendenti giocano in favore della Qualità della vita (qv) o della Santità della vita: in mezzo non vi è quasi nulla. Qv e santità sono presentate come principi basilari dell’argomentazione morale.
I sostenitori della santità (o piuttosto la loro caricatura) credono in un dovere assoluto e negativo: non infrangerai la teleologia della natura, ed in particolare del corpo umano. Ne segue che non interromperai i fenomeni naturali conseguenti al rapporto sessuale (la contraccezione è proibita) e ne segue che non arrecherai danno al dinamismo di auto mantenimento del corpo (il suicidio deliberato è proibito).
I sostenitori della qualità dicono di non riconoscere alcun valore o dovere assoluto in morale. La regola generale che compendia e dirige la loro condotta è la seguente: «promuovi la qv, cioè la preoccupazione per il benessere e/o l’autonomia degli individui». L’etica sarebbe una creazione umana, cioè un mezzo in vista del fine di promuovere un’adeguata qv, un mezzo che può mutare nell’interesse del fine.
La rapida diffusione e l’accoglienza avuta da tale schematica contrapposizione sono tanto sorprendenti quanto pericolose per la comprensione del movimento e del dibattito bioetico. Ecco perché io cercherò in questo intervento di fare un passo indietro e mostrare quando e come il concetto di qv è realmente e utilmente impiegato in alcuni momenti della pratica medica e nella politica sanitaria, prima di essere manipolato e stravolto nelle fantasie meta-bioetiche di certi filosofi.
2. Qualità della vita nella decisione medica.
I medici hanno sempre tenuto in gran conto i problemi della qv, nel corso della decisione clinica, ma non sempre essi hanno esplicitamente messo a fuoco la qv come un dimensione rilevante della loro pratica. Il filone più promettente e vitale della medicina occidentale non è mai stato quello vitalistico, teso a prolungare ciascuna vita ad ogni costo. Ma solo di recente, per via della crisi del paternalismo medico, dell’avvento di movimenti come quello delle cure palliative, della diffusione dell’informazione sui problemi medici attraverso i mezzi di comunicazione di massa, dell’accresciuta consapevolezza e sensibilità della pubblica opinione circa i diritti civili, per la maggiore frequenza di disturbi cronici (che non possono essere curati e devono così essere accettati come una triste compagnia della vecchiaia), solo recentemente la letteratura clinica e quella etica hanno avviato una riflessione sistematica e articolata sul significato di qv come télos della medicina.
Non voglio insistere qui sul retroterra storico di un tale cambio sul concetto di qv, ma devo comunque sottolinearne due cause, culturale e teoretica. Le chiamerò: il pluralismo morale e la scoperta del corpo (meglio: una scoperta che la fenomenologia filosofica ha esplicitamente illuminato). In un’arena pluralistica il significato e dunque il valore etico di una malattia da un lato, e di un intervento terapeutico dall’altro, sono differenti, a seconda dell’individuo, della famiglia e della comunità morale coinvolti. «Decidere cosa rappresenti il superiore interesse del paziente non è una semplice questione per tecnici, perché ciò che è bene per me si basa sulle preferenze, stili di vita, opzioni morali, priorità nel progetto di vita, tutto ciò che distingue la mia originale esistenza». Error! Reference source not found. Error! Bookmark not defined.
In secondo luogo la nostra cultura ascolta, molto più delle epoche trascorse, il linguaggio del corpo. Non è semplicemente un moda egoistica e consumista. Al contrario, ciò proviene dalla sincera comprensione del significato del “living body”, “corps veçu”, “Leib”, “corpo proprio”*, come fonte non solo di una più produttiva manipolazione del mondo, ma prima di tutto come fonte di auto comprensione. Fa già parte del senso comune l’evidenza che io non ho semplicemente un corpo, ma piuttosto io sono il mio corpo. C’è un’ identità tra l’individuo che io sono e il mio corpo, anche se questa identità non riguarda allo stesso modo tutte le parti del mio corpo: quando le mie mani si toccano, l’una mano non può essere allo stesso tempo quella che tocca e quella che è toccata.
Tutto questo significa che scoprire chi io sono e di conseguenza decidere che cosa è buono per me, che cosa è buono per me fare in una determinata circostanza, richiede una interpretazione dei segni offerti dal mio corpo vivente, segni offerti come una sorprendente prova di ciò che io voglio ed amo. Dolori, sofferenze, frustrazioni, e d’altro canto, felicità, desideri, speranze, all’inizio non sono conoscenze intellettuali, ma sono eventi globali della mia esistenza corporea. Noi possiamo dire che la ragione viene successivamente, la ragione tenta di chiarire e comunicare ciò che l’esperienza morale, dall’inizio, percepisce e testimonia. E l’esperienza morale è, insieme, ragione, emozione, libertà.
L’auto liberazione, che è stata il programma mitico di tutte le religioni e rivoluzioni, non deve dimenticare (così come questo mito è inteso nelle nostre culture occidentali) il vero, concreto sentire che il mio corpo vivente testimonia.
In quanto agente morale, io posso rischiare, addirittura dovrei rischiare la mia vita per una ragione universale, per un bene assoluto, ma questo valore universale e assoluto non può essere pensato e amato senza la mediazione del mio corpo vivente. La salvezza, che la fede promette, non può esser detta e ascoltata contro ciò che il linguaggio della mia esperienza corporea mi rivela. L’imperativo universale di una legge morale esige che non siano distrutti sentimenti e desideri ma che li si interpretino, che li si prenda nella loro genuina natura e télos. Il télos è la ricerca di un bene che non delude colui che cerca. Il comandamento non annienta il desiderio, ma piuttosto lo purifica, lo apre all’attesa per un bene che merita consenso, una devozione senza riserve.
Torniamo alla qv. Come agenti morali, il nostro imperativo morale non è quello di prolungare la vita fine a se stessa. Al contrario, noi dovremmo aprire la nostra vita al massimo possibile di sensatezza umana. Significa che io dovrei impegnare la mia vita per una buona causa, io dovrei sposare una causa che merita il mio incondizionato impegno, per la sola ragione che è propriamente la mia personale causa. In altre parole essa è la maniera in cui l’appello morale universale (fa il bene, evita il male) chiama la mia personale, corporea esistenza.
Le conseguenze in etica applicata sono chiare. Anche nelle parole di una istituzione fortemente favorevole ad un approccio per la santità della vita, è presente la considerazione delle autonome preferenze del paziente. Ho in mente la Dichiarazione sull’eutanasia della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede (1980): due pazienti nelle medesime condizioni mediche, possono decidere legittimamente, dal punto di vista etico, per due specie diverse di trattamento, se è diverso il senso umano che essi vedono come a loro appropriato, alla fine della loro vita.
«Se non ci sono altri rimedi sufficienti, è permesso, con il consenso del paziente, di ricorrere ai mezzi previsti dalle più avanzate tecniche mediche, anche se questi mezzi sono ancora ad uno stadio sperimentale e non privi di un certo rischio. Nell’accettarli, il paziente può anche mostrare generosità nel servizio all’umanità…
E’ anche permesso rimediare con i normali mezzi che la medicina può offrire. Tuttavia non è possibile imporre a nessuno l’obbligo di far ricorso ad una tecnica che è già in uso, ma che comporta dei rischi o è gravosa. Un tale rifiuto non è equivalente al suicidio; al contrario esso potrebbe essere un’accettazione dell’umana condizione, o il desiderio di evitare l’applicazione di procedure mediche sproporzionate ai risultati che ci si può aspettare, o un desiderio di non imporre eccessive spese alla famiglia o alla comunità».
Quando, nel corso delle mie lezioni, leggo queste frasi a medici colti, istruiti e sensibili, essi di solito replicano che non vi è alcun bisogno di una così autorevole istruzione, giacché essa non dice molto più di quanto usualmente essi fanno, quando giudicano la proporzionalità di un trattamento per uno specifico paziente. Quando confrontano due o più differenti forme di cura, essi misurano il dovere (D) di compiere una certa forma di trattamento facendo assegnamento ai seguenti criteri:
-qdv: l’incremento della prevista quantità della vita, il prolungamento della vita che si spera in seguito all’intervento;
-qv: l’incremento della prevista qualità della vita, il miglioramento della vita che si spera (o l’atteso peggioramento della qv che si eviterebbe);
-ps: le possibilità di successo del trattamento;
-o: oneri del trattamento a breve, medio e lungo termine, da un punto di vista fisico e psicologico (senza considerare qui le conseguenze socioeconomiche di una forma di cura).
Una formula può essere la seguente (non è possibile qui entrare nei dettagli):
D= (qdv + qv) . ps
b
Qual è il legame tra i fattori di questa formula e l’autonoma valutazione del paziente? Il legame appare chiaro se noi consideriamo per esempio il fattore qv. Il godimento o il disgusto, l’apprezzamento o la ripugnanza per alcuni aspetti della coppia “malattia-trattamento” non può essere tenuta in considerazione, se si lascia da parte la libertà soggettiva del paziente o se si rimpiazza tale soggettività con i canoni di qualcun altro, quand’anche con una ben disposta, saggia, autorevole, accurata, eticamente avveduta coscienza del medico.
Questo è il motivo per cui alcuni Autori aggiungono un altro fattore, A, l’autonomia del paziente, per distinguere la dimensione biomedica (lo stretto, ed errato, punto di vista clinico) dalla dimensione personale di sintomi come: febbre, vomito, dolore, diarrea, dispnea, immobilità, dipendenza da macchinari o protesi, mancanza di appetito, sete, isolamento, senso di debolezza e così via.
La formula diventa:
D = (qdv + qv) . ps . A
b
Ripeto che tutto questo significa che la valutazione del modo migliore di vivere la nostra vita non può aiutarci a considerare ciò che il paziente ritiene essere per lui/lei nel suo maggiore interesse, vale a dire quale tipo di vita garantisca per lui/lei una più grande qualità della vita. In altre parole, la santità della vita non è riferibile alle condizioni fisiche della sua durata. Ciò che merita il titolo di santità è l’apertura di questa vita al bene supremo e assoluto, e tale apertura può implicare una esistenza più breve, ma più umana.
Ovviamente, la valutazione personale di un sintomo, una malattia, una proposta di terapia, può essere diversa in un paziente rispetto a quella del suo medico, non solo per ragioni professionali, ma anche per le loro diverse e talvolta contrastanti filosofie. In questi casi è necessario una specie di negoziato riguardo la nozione di bene degno o interesse del paziente.
3. QUALITÀ DELLA VITA, VALORE DELLA VITA E SANTITÀ DELLA VITA
Alcune brevi considerazioni adesso su altri due usi della nozione di qv nella moderna medicina e in bioetica.
Nel mio recente libro, Sotto scacco. Bioetica di fine vita, Napoli, Liviana, 1993, ho esaminato e criticato la proposta della morte corticale. La proposta di dichiarare morto il paziente in stato vegetativo persistente non riposa semplicemente su nuovi dati neurologici, ma su una specifica tesi etica.
La tesi dice che proprio dell’uomo è il ragionamento, il potenziale della relazione umana ed inoltre dice che il sostrato per tale funzione (una funzionalità neo corticale, ora o in futuro) è la condizione necessaria per riconoscere una persona in un organismo umano.
In alcuni autori questa posizione va più a fondo: c’è un vasto raggio di forme di vita nell’umanità e si può loro assegnare un certo punteggio, calcolato sulla base della qualità delle loro prestazioni, a partire dal comatoso, al portatore di handicap, alla persona sofferente, all’adulto normale, al giovane genio di sana costituzione. Il valore ontologico, il grado in virtù del quale un tale essere merita il titolo di persona e di conseguenza la forma di rispetto che gli dobbiamo, tutto ciò dipende dal quel punteggio.
Questa posizione confonde qualità della vita con valore della vita.
Direi piuttosto che noi dobbiamo rispettare il valore di ogni vita umana allo stesso modo, quantunque essa possa essere afflitta da malattia, menomazioni, dolore o sofferenza, cioè nonostante la sua qualità sembri da classificare ad un basso livello. In tal senso la vita stessa, indipendentemente dalle persone che la vivono, ha una qualità che dev’essere rispettata. Non abbiamo criteri etici per distinguere vite valide da vite non valide così come non abbiamo solide ragioni per assegnare il nome di persona solo ad alcuni membri dell’umanità.
Anche la nozione di rispetto andrebbe ripensata: rispetto è qualcosa che noi dobbiamo anche ai fiori. Farci prossimi agli altri: questo dovrebbe essere piuttosto il dovere minimo che ci vincola l’un l’altro. L’atteggiamento interessato che proviene da queste basilari disposizioni è la stessa nei confronti di chiunque, anche se possono differire le forme, i modi, le concrete azioni che compiamo verso gli esseri umani.
La ragione di questa differenza è il fatto che noi dobbiamo giovare alle altre persone in maniera loro proporzionata, proporzionata a ciascuno di essi, ai loro bisogni, desideri, diritti, doveri.
Richard Mc Cormick, difensore di un modello relazionale potenziale per misurare il dovere di intervenire terapeuticamente, in caso di un neonato in pericolo di morte, scrive: «Ammettere che alcuni bambini muoiono non implica che alcune vite siano valide e altre no o che esiste una vita non degna d’essere vissuta. Ogni essere umano, indipendentemente dall’età o dalla condizione, è di incalcolabile valore. Il punto non è tuttavia se questo o quell’individuo abbia valore. Naturalmente egli ha, anzi, egli è un valore. Il solo punto è se questo indubbio valore non ha affatto potenzialità, nel continuare la propria sopravvivenza fisica, per tentare di partecipare, anche se in maniera ridotta, al più alto e importante dei beni (Mc Cormick intende l’amore di Dio e del prossimo). Questa non è una questione attorno al valore intrinseco dell’individuo. E’ in questione se questa esistenza mondana offrirà ad un individuo valutato come tale qualche speranza di partecipare a quei valori per i quali la vita fisica è la fondamentale condizione» (How brave a new world, 1981, 350).
4. “QUALITY ADJUSTED LIFE YEARS” E IL PRINCIPIO DI GIUSTIZIA, IN MEDICINA
C’è un altro senso e un’altra questione in cui la nozione di qv è usata, non troppo lontano dal capezzale dell’ammalato.
Nell’affrontare il problema della limitatezza di risorse, l’etica medica aveva cercato alcuni criteri chiari per stabilire la priorità nell’offrire le cure sanitarie.
Alcuni anni fa, nel 1987, il Journal of Medical Ethics (n. 13) presentò un brillante dibattito tra John Harris (Manchester) e Alan Williams (York) riguardo il significato e la consistenza di una nuova nozione, il cui architetto è lo stesso Williams: la nozione (vecchia di circa dieci anni) di Quality Adjusted Life Years (qaly).
«L’essenza di una qaly -dice Williams- è che si assume l’aspettativa di un anno di salute come avente valore uno, mentre si considera l’aspettativa di un anno senza salute avente valore minore di uno. Il suo preciso valore è più basso quanto peggiore è la qualità della vita del malato. Se essere morti è uguale a zero, è per principio possibile che un qaly sia negativo, ossia che la qualità della vita di un soggetto sia giudicata esser peggiore dell’essere morti. L’idea generale è che una attività di cura sanitaria benefica è quella che genera un bilancio positivo di qaly, e che una attività di cura sanitaria efficiente è quella in cui il costo per qaly è il più basso possibile. Un’alta priorità di attività di cura sanitaria è quella per la quale il costo-per-qaly è basso, una bassa priorità di attività di cure sanitarie è quella per la quale il costo-per-qaly è alto».
La posizione di Williams riguardo l’allocazione delle risorse per le cure sanitarie, è da lui stesso presentata come segue:
-La priorità di cura sanitaria dovrebbe essere influenzata dalla nostra capacità sia di incrementare l’aspettativa di vita sia migliorare la qv della gente;
-un particolare miglioramento nella salute dovrebbe essere ritenuto come di egual valore, a prescindere da chi lo ottenga, e dovrebbe essere approntato, a meno che esso impedisca che un più grande miglioramento sia offerto a qualcun altro;
-è responsabilità di ciascuno fare le dovute differenze, ovunque è necessario, per assicurare che le nostre limitate risorse vadano lì dove esse possano produrre il massimo beneficio.
Sono state sollevate alcune critiche contro queste proposizioni.
Usare il qaly per determinare quale gruppo di pazienti si debba trattare, è moralmente indifendibile, perché una tale politica non valuta la vita degli individui, ma anni di vita, unità di vita.
Per esempio, una tale teoria permette di sacrificare sei individui, non somministrando loro alcuna terapia che possa offrire a ciascuno un anno di salute stazionaria, a beneficio di un settimo individuo che potrà ottenerne sette anni.
Ciò significa anche che si tenderà ad utilizzare tutte le risorse disponibili per assistere quelli che guadagneranno il massimo in qaly: per fare un esempio, i giovani.
La conclusione della critica è che ogni vita dovrebbe contare per uno ed ecco perché salvare più vite dovrebbe contare di più. Per questa ragione noi dovremmo dare la priorità a salvare quante più vite è possibile, non quanti più anni di vita. E’ per l’individuo che decidiamo se valga la pena serbargli il miglioramento che gli/le si può garantire.
La posizione di Harris, d’altra parte, può essere riassunta come segue (le parole sono quelle di Williams):
-La priorità delle cure sanitarie non dovrebbero essere influenzate da altra considerazione che di tenere in vita la gente;
-Ognuno ha eguali diritti di essere mantenuto in vita, se è ciò che desidera, per quanto breve possa essere la sua prognosi e indipendentemente da quali sacrifici gli altri debbono affrontare di conseguenza;
-Quanto all’allocazione delle risorse per le cure sanitarie, noi non dobbiamo assolutamente discriminare tra le persone, neppure in base alla loro diversa capacità di giovarsi delle cure.
Sfortunatamente neppure la posizione di Harris risolve tutti i problemi.
Harris deve ammettere che «qualora noi non potessimo salvare tutti, dovremmo selezionare quelli da non salvare in un modo che non presenti ingiuste preferenze». Ma qual è questo “giusto modo”?
Se rispondiamo: «salvare il massimo di pazienti che vogliano esser salvati», non diciamo ancora nulla di chiaro, perché non diciamo per quanto tempo la vita di ciascun paziente potrà essere salvata. E’ meglio preservare la vita di tre persone che sopravviveranno solo due giorni, o quella di due che otterranno una perfetta guarigione per decenni?
Se rispondiamo: «seguire solo l’ordine casuale della lista d’attesa» rischiamo di perdere pazienti che (come il marinaio in un naufragio) può salvare altre vite e rischiamo di perderli per la sola ragione che essi sono sfortunatamente in coda alla lista.
C’è un altro limite nel distinguere con precisione il salvare la vita dal prolungare la vita e nel dare tutta la priorità al primo concetto (nel senso che dovremmo in primo luogo allocare le risorse in quelle aree ove c’è immediato bisogno di salvare vite e solo dopo destinarle ad alleviare condizioni non fatali).
Il problema di tale rigorosa distinzione è che esistono condizioni che non minacciano la vita del paziente ma che sono talmente dolorose che lasciare qualcuno in un simile stato di sofferenza costituirebbe un’ingiustificabile crudeltà, una crudeltà forse peggiore del trascurare la priorità di più fatali condizioni.
Il mio tentativo di conclusione (che sottopongo alla vostra attenzione) è che la qv venga presa in considerazione anche in una trasparente distribuzione delle risorse per le cure sanitarie. Infatti i rilevanti fattori etici che noi dobbiamo integrare, se vogliamo tracciare un giusto ordine di priorità, sono quelli che seguono: Numero di persone che noi prevediamo di salvare, selezione casuale, autonomia dei pazienti in lista d’attesa, urgenza del bisogno di cure mediche, conseguenze sociali (nel senso della valore sociale) dovuto all’importanza delle capacità individuali per il bene comune, effettività dell’intervento medico. Questa effettività dev’essere misurata attraverso il miglioramento della qv, il prolungamento della vita, le possibilità di successo, oneri psicofisici del trattamento. Come si vede, la qv ha ancora un posto in questa difficile valutazione sociale, non solo (come abbiamo detto nella prima parte del presente lavoro) a livello individuale e clinico.
Traduzione dall’inglese di Gianpiero Tre Re e Alina Petruzzella
* Paolo Cattorini, Dipartimento di umanistica medica, Istituto scientifico Ospedale S. Raffaele, Milano; Professore Associato di Bioetica, Università di Firenze.
* In italiano nel testo.









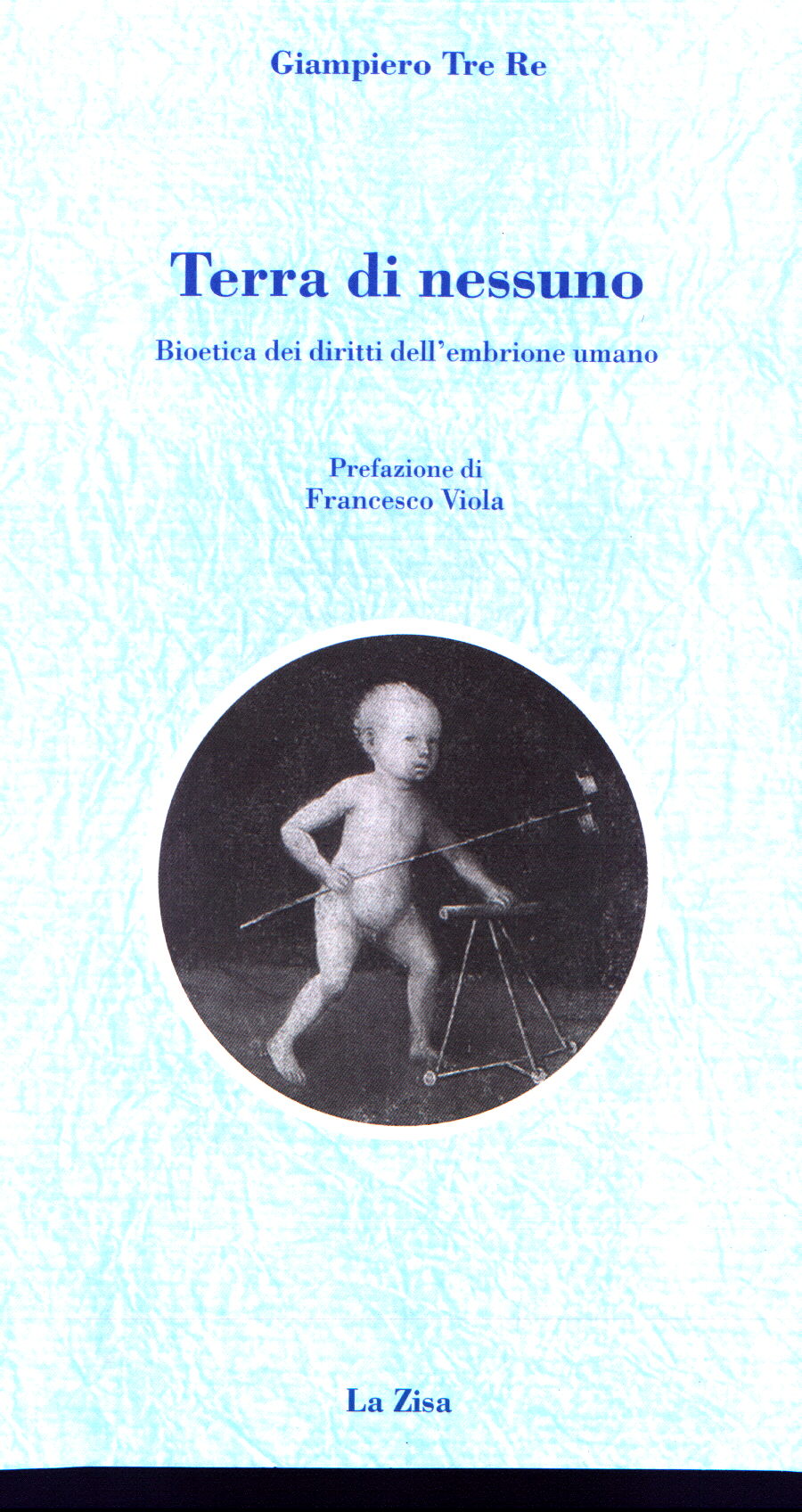
Hanno scritto