Pavel Florenskij, Lettera Terza

Pavel Florenskji, da Lettera Terza, Triunità, La colonna e il fondamento della verità, 1914.
Traduzione dal russo di P. Modesto, Rusconi Editore, Milano 1974.
Si sa che l’idea della unisostanzialità è espressa con il termine di ὁμοούσιος, omoúsios, attorno al quale e per il quale si sono svolte tutte le dispute trinitarie. Analizzare la storia di queste dispute significa osservare tutti i colori e le sfumature di cui si è arricchita l’idea di unisostanzialità. Io me ne posso esimere, rimandando alle varie storie delle controversie dogmatiche. (1)
È noto che né la letteratura sacra né quella profana dell’epoca prenicena conoscevano la differenza tra i termini οὐσία e ὑπόστασις usia e ipòstasi, che poi divennero termini tecnici. Nel linguaggio filosofico οὐσία equivaleva perfettamente a ὑπόστασις; e questo fino al secolo V dopo Cristo. Abbiamo tutte le ragioni di pensare che anche i padri del primo concilio ecumenico considerassero sinonimi i termini ipostasi e sostanza e che non avessero affatto in mente la distinzione che verrà introdotta dalla speculazione successiva. Sant’Atanasio il Grande li adopera come equivalenti e addirittura trentacinque anni dopo in concilio niceno afferma decisamente in una lettera che «l’ipostasi è sostanza e non significa altro che sostanza». La vecchia generazione dei Niceni la pensa come Atanasio, (2) e alla fine del secolo IV il beato Gerolamo in una lettera a papa Damaso dice chiaramente che «la scuola delle scienze profane conosce della parola ipostasi solo il significato di sostanza (usian)». (3) Ma è anche noto che nella teologia posteriore i due termini sono diventati distinguibili. Distinguibili sì, ma anche distinti per contenuto? È indubbio che si possono distinguere uno rispetto all’altro come la «destra» si distingue nel rapporto reciproco dalla «sinistra»; mi domando però se destro e sinistro si distinguano in sé, nel loro contenuto assoluto. È proprio vero che ipostasi significa l’individuale, mentre sostanza (οὐσία) significa il comune?
Anzitutto può servire da risposta la circostanza che fu scelta una coppia di parole che combaciano in ogni modo nel significato. Perché? Soltanto perché ciò che rispettivamente significano si distingue logicamente, solo relativamente, vicendevolmente e non in sé, non per sé.
Per adoperare un paragone rozzo, i contenuti delle due parole che vogliamo analizzare stanno l’uno all’altro come l’oggetto alla sua immagine speculare, come una mano all’altra, come un cristallo destrogiro a un levogiro, ecc. In tutti questi casi avvertiamo con chiarezza la diversità di un oggetto dall’altro, ma sotto l’aspetto logico non li possiamo definire se non l’uno con ricorso all’altro: nell’appercezione le cose stanno diversamente, ma quando ci si domandi in che cosa consista la diversità di fatto non possiamo non considerare identico il diverso: siamo costretti formalmente a riconoscere l’identità. (4)
Lo stesso vale per i termini ipostasi e sostanza. Infatti «unisostanziale» significa l’unità concreta del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, ma non l’unità nominale; in Atanasio e nei Padri niceni ὁμοούσιος omoúsios, equivale senz’altro a ἐκ οὐσίας τοῦ Πατρός «della sostanza del Padre». Ma se è così, l’ipostasi è la sostanza personale, per così dire, del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, in quanto ciascuno sia considerato a parte, non si fonda affatto con un’altra ipostasi e allo stesso tempo ne è inseparabile. Se dal punto di vista terminologico, formale, la parola ipostasi è divenuta in principio differente dalla parola usía (οὐσία), dal punto di vista del contenuto e della significazione logica, rimane decisamente uguale a usía (οὐσία). La grandezza incomparabile dei padri niceni si rivela nel fatto che osarono impiegare un’espressione totalmente identica per significato, superando con la fede il raziocinio, e, grazie a questo coraggioso colpo d’ala, acquistarono la forza di esprimere esattamente, perfino dal lato puramente terminologico, l’inesprimibile mistero della Triadicità. Ne consegue che ogni tentativo di delimitare usía (οὐσία) e ipostasi (ὑπόστασις), dando a ciascun termine una posizione logica autonoma, necessariamente deve portare (e porta in effetti) a razionalizzare il dogma, a «scindere l’inscindibile»; (5) all’eresia del cosiddetto triteismo. Già dall’antichità l’accusa di triteismo pende sul capo dei Cappadoci. Naturalmente è ingiusta, ma profondamente significativa. I partigiani dell’ὁμοούσιος (omoúsios) ebbero una tendenza ancor più spiccata al razionalismo. Il termine ὁμοούσιος (omoúsios) ovvero ὅμοιος κατ’ οὐσίαν significa «di uguale sostanza» e, anche se gli fu aggiunto il κατά πάντα, «in tutto», esso non è in grado di significare l’unità numerica concreta, come fa il termine ὁμοούσιος (omoúsios). Quest’ultimo stabilisce tutta la forza del misterioso dogma subito e con una sola parola, nella quale viene indicata e l’unità reale e la diversità reale. Non si può ricordare senza devoto tremore e santo stupore quel momento, infinitamente significante e unico per importanza filosofica e dogmatica, in cui tuonò a Nicea per la prima volta l’ὁμοούσιος omoúsios. Non si trattava di una questione teologica particolare ma della definizione radicale che la Chiesa di Cristo dava a se stessa. Con questo solo termine vennero espressi non solo il dogma cristologico, ma anche una valutazione spirituale delle leggi razionali del pensiero: il razionalismo fu colpito a morte e per la prima volta fu proclamato urbi et orbi un principio nuovo per l’attività della ragione.
Infatti che cos’è tutta la concezione cristiana della vita? Uno sviluppo del tema musicale che è il sistema dei dogmi, della dogmatica. La dogmatica è il simbolo di fede analizzato. Il simbolo di fede non è altro che lo sviluppo della formula battesimale «in nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo». Questa formula, poi, è senza dubbio il dispiegamento del termine ὁμοούσιος (omoúsios). Considerare l’albero di senape fronzuto e ombroso, che è la concezione cristiana della vita, come originato dal minimo seme dell’idea dell’«uniessenzialità» non è una possibilità soltanto logica, perché di fatto così fu storicamente. Il termine ὁμοούσιος (omoúsios) esprime proprio questo germe antinomico, un nome unico per tre ipostasi (6) («nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo», e non «nei nomi» delle tre ipostasi). (7)
La razionalizzazione degli omousiani traeva origine in misura notevole da preoccupazioni filosofiche. Ecco perché il grande Atanasio, asceta e maestro di spirito, privo, forse per disegno provvidenziale, di formazione filosofica, e comunque interiormente staccato da tutto ciò che non era della fede, seppe esprimere con precisione matematica ciò che perfino nell’epoca posteriore continuò a sfuggire alle precisazioni degli intellettuali.
Ci meraviglia quanto sforzo abbiano dovuto fare i Cappadoci (che si vantavano dei propri studi universitari!) per far resistenza alla terminologia filosofica che li trascinava al triteismo. Dice A.A. Spasskij che, nel quadro della terminologia dei Cappadoci, «la comunità di natura (κοινωνία) non esprime ancora l’essere reale di una sostanza e non ne garantisce l’unità numerica. La natura nella divinità e negli uomini può essere una, ma trova la propria attuazione concreta nelle ipostasi».(8)
I Cappadoci, nonostante la nota triteistica dei loro scritti, erano nell’intimo pienamente ortodossi ed è chiaro che la loro comprensione inferiore superava di molto le loro parole inesatte. San Basilio, quasi correggendosi, dichiara nella lettera 38: «Non meravigliarti se diciamo che la stessa cosa è unita e separata e se nel pensiero, quasi indovinando, ci raffiguriamo una certa divisione nuova e insolita e un’unione divisa».(9) Gregorio Nisseno nella Grande istruzione catechistica si pone decisamente al di sopra del raziocinio: «Chi penetra con esattezza nelle profondità del mistero, anche se raggiunge una qualche comprensione, modesta rispetto all’inattingibilità della divinità, non può spiegare a parole questa profondità ineffabile del mistero: come la stessa cosa sia numerabile e sfugga alla numerazione, sia contemplabile divisa e si racchiuda nell’unità, si distingua nell’ipostasi e non sia divisibile nel soggetto».(10)
In tal modo questa formula «di una sostanza» e «in tre ipostasi» è accettabile solo in quanto identifica e allo stesso tempo distingue i termini ipostasi e sostanza, cioè in quanto viene ridotta di nuovo alla dottrina puramente mistica translogica, dei padri niceni, cioè al termine ὁμοούσιος, omoúsios. Viceversa ogni tentativo di interpretare razionalisticamente detta formula immettendo nei termini οὐσία usia e ὑπόστασις ipòstasi, un contenuto differente, porta inevitabilmente al sabellianismo o al triteismo. La teologia preatanasiana, quella degli apologeti che si basavano sulla filosofia antica, inclinava al primo errore (le varie specie di monarchismo), attribuendo un peso indebito all’unità della sostanza divina e quindi privando le ipostasi del loro essere specifico. Inclinando al subordinazionismo, essa ora sottometteva il Figlio e lo Spirito Santo al Padre, ora fondeva le ipostasi. La teologia postatanasiana, anch’essa legata alla terminologia degli antichi, peccava nella direzione opposta, poiché, per controbilanciare il monarchismo degli apologeti, insisteva eccessivamente sulla autonomia delle ipostasi, cadendo così nel triteismo. Se la prima tendeva a svuotare, pur conservando le apparenze, la pluralità ipostatica della divinità, la seconda certamente tendeva a eliminare la sua unità sostanziale.
In Atanasio abbiamo l’equilibrio dei due principi. La sua teologia è quel punto dove il margine d’errore diventa rigorosamente zero, prima che la dottrina passi dal « – » al « + ». Perciò si può dire che Atanasio è un portatore eccelso della coscienza ecclesiale del nostro dogma trinitario. Dopo di lui la teologia si è forse perfezionata in questioni particolari, ma in nessuno dei padri conciliari posteriori l’equilibrio dei due principi fu così matematicamente esatto, nessuno mostrò in maniera più evidente la translogicità del dogma, come Atanasio, il difensore dell’unisostanzialità, il vescovo più ortodosso degli ortodossi.
«Tra i .difensori del concilio di Nicea», scrive A.A, Spasskij, «Atanasio ebbe un posto eccezionale: fu non soltanto il loro condottiero, ma anche l’esponente delle loro posizioni dottrinali nella Chiesa. Tutte le mene contro il simbolo niceno di solito prendevano le mosse da attacchi contro Atanasio; il suo esilio era un chiaro sintomo della reazione montante; il suo trionfo era il trionfo del concilio niceno e della sua dottrina. Si può dire che Atanasio salvò il simbolo niceno, portandolo sulle sue spalle fuori della tempesta di dubbi che esso aveva scatenato in Oriente. Non a caso la generazione posteriore ai Niceni lo definì “salvatore della Chiesa e colonna dell’ortodossia”». (11) Non a caso, aggiungo io, Gregorio il Teologo non trova parole abbastanza forti per celebrare il grande alessandrino. Lo chiama «beato, vero uomo di Dio e gran tromba della verità», che «hai sanato i mali» della Chiesa, «coraggioso difensore del Verbo», «edificatore delle anime». Gli asceti «ritenevano che per Atanasio soffrire i maggiori tormenti era la massima conquista per la sapienza, e lo valutavano molto più gradito a Dio e superiore ai prolungati digiuni, al giacere sulla nuda terra e agli altri patimenti che formavano il loro diletto». (12) L’occhio santissimo dell’universo, il vescovo dei vescovi, il maestro nella confessione della fede, questa gran voce e colonna della fede, questo, se così si può chiamare, secondo luminare e precursore di Cristo, spentosi nella vecchiaia carico di giorni ricolmi di grazia, dopo attacchi, eroismi, calunnie, morto alle passioni mentre era ancora in vita, porta nei propri tabernacoli la Trinità per la quale egli visse e sostenne le sventure». E aggiunge: «Sono sicuro che in questa descrizione tutti riconosceranno Atanasio».(13) In effetti egli fu sempre all’erta. Quando in maniera estremamente sottile si tentò di falsare razionalisticamente il termine ὁμοούσιος omoúsios, Atanasio si affrettò a premunire Gioviano, mettendolo in guardia contro coloro che «fingono di confessare la fede nicena, ma in realtà la negano reinterpretando la formula ” di una sola sostanza”». Atanasio li chiama senza esitare ariani, perché capisce, come diceva Gregorio il Teologo, che «con le sillabe crollano i confini dell’universo», che qui non ci possono essere deviazioni piccole, che ogni razionalizzazione, apparentemente sottilissima, del dogma, rende insipido il suo sale, che non è lecito parlare di deformazione del dogma quando all’eterna colonna della verità si sostituisce la polvere che il vento sospinge sulla strada. «Bisogna rispettare i padri niceni», scrisse lo stesso Atanasio, «e chi non accetta il simbolo deve essere chiamato tutto fuorché cristiano». Tutto il senso del dogma sta nell’ὁμοούσιος omousios, stabilito da Atanasio e ciò che gli è estraneo è soltanto vanità dell’uomo, opinione transeunte.
Ecco perché neanche la rozza Roma si arrese alle astute manovre, e tutte le adulazioni sapienti dei semiariani si infransero sulla pietra della fede come onde fragorose: Roma imponeva loro incrollabilmente il ritorno al simbolo niceno.
Riprendo il problema della scepsi.
Se si vuole che la legge dell’identità sia qualcosa di più della sorda radice del raziocinio, se ci si vuole liberare dell’empirìa del raziocinio, la quale non è per nulla migliore dell’empirìa dei sensi, bisogna trascendere i confini del raziocinio stesso e penetrare nel campo dove hanno radice il raziocinio e tutte le sue norme, occorre cioè raggiungere con l’esperienza una sintesi del non relativo e della relazione, del primario e del derivato, della quiete e del moto, dell’unità e dell’infinitezza, ecc. Il raziocinio non accetta questi accoppiamenti; dove A è A e solo A, la sintesi che cerchiamo è decisamente impossibile. E se è possibile, lo è solo oltre i limiti del raziocinio e, una volta raggiunta, sarà pensata come il limite ideale del raziocinio, come l’al di là dal limite, il trascendente, o come il principio regolatore. Ma nel tentativo di afferrare questa sintesi, il raziocinio, per la sua stessa natura, non può percepirne la globalità integrale e inevitabilmente la scompone in termini incompatibili, che si contrappongono l’uno all’altro. La coincidentia, oppositorum immancabilmente crolla e si polverizza in apposita che si escludono a vicenda. Allora al raziocinio non resterà che eliminare uno dei termini a favore dell’altro, oppure alternarli ritmicamente: una lotta come quella dei campi visivi policromi nel caleidoscopio: o l’uno o l’altro, ma non la sintesi! La vittoria di un termine sull’altro corrisponderà a questa o quella eresia, mentre l’alternarsi dei campi corrisponderà alla «ortodossia» razionalistica dei manuali, la quale in realtà è una pseudo-ortodossia, un mazzo di eresie incompatibili fra loro.
Nella ricerca dell’attendibilità ci siamo scontrati con una combinazione di termini che per il raziocinio non ha e non può avere senso, «Trinità nell’unità e unità nella trinità» non significa nulla per il raziocinio; se ne coglie il vero contenuto, che non si adatta al raziocinio, così come la radice quadrata . Tuttavia proprio la norma costitutiva del raziocinio, cioè le due leggi dell’identità o non contraddizione e di ragion sufficiente, ci portano a questa combinazione, esigono che essa abbia un senso, che sia il punto di partenza di tutto il sapere. Il raziocinio deve esigere la trinità nell’unità, ma non la può comprendere e così condanna se stesso. Per poter sentire nell’esperienza questa esigenza, questo postulato della ragione (sempre che sia possibile averne l’esperienza!), la ragione deve pensarle, deve costruirsi una norma nuova e per giungervi deve vincere il raziocinio, l’unica cosa che c’è in noi di ingiustificato; la sapienza di Dio e la sapienza dell’uomo si scontrano. Perciò la ragione non sarebbe mai potuta arrivare da sé a questa combinazione; solo l’autorità «di Colui che ha il potere» può costituire il punto d’appoggio per questo sforzo. (14) Dopo aver prestato fede e aver creduto che in questo sforzo stia la verità, la ragione deve rinunciare alla propria limitazione entro i confini del raziocinio, rigettare la chiusura delle costruzioni razionalistiche e rivolgersi alla norma nuova, diventare una ragione «nuova». Qui si richiede un atto eroico e libero. Libero perché la ragione può fare lo sforzo ed elevarsi al meglio, ma anche non farlo per tenersi al finito, al relativo, al «buono» che già possiede. È un atto eroico perché impone sforzo, tensione, rinuncia di sé, abbandono del «vecchio Adamo», mentre l’immediatezza, «il naturale», il finito, il noto, il relativo, continuano ad attirare. Se è mai raggiungibile «il cuore impavido della verità immutabile», di cui Parmenide (15) sentiva l’attrazione, la strada per arrivarci non può evitare il Getsemani dell’eroismo della fede.
Ariani e ortodossi sono il caso tipico di due posizioni inconciliabili: «Mentre gli ortodossi», scrive uno studioso, «si domandavano se si dovevano pensare in Dio tre Persone reali, tre unità indivisibili della sostanza divina e rispondevano con un’affermazione categorica, gli ariani si domandavano se si poteva pensare una trinità di Persone divine restando indivisa l’unità della sostanza, e rispondevano che era impossibile». (16) Compiendo l’atto eroico della fede gli ortodossi cercavano il dovuto il supremo; invece gli ariani, mettendosi interiormente sulla difensiva, domandavano con circospezione se la verità non esigesse da loro dei sacrifici e davanti al Getsemani si tiravano indietro. Ambedue fecero una scelta libera: gli ariani adoperarono la loro libertà per scegliere la schiavitù, gli ortodossi per liberarsi dalla prigionia nella limitatezza carnale. «Voi osate insegnare e pensare l’impossibile», scriveva Eunomio a Basilio il Grande e a Gregorio Nisseno alludendo al dogma cristologico. (17) Questo è il grido della carne, del raziocinio guidato dai principi del mondo e pieno di egoistica paura per la propria integrità, del raziocinio contento di se stesso nonostante la sua piena dissoluzione interiore, del raziocinio nel suo terrore infinito del più piccolo dolore, del raziocinio che osa adattare perfino la verità a se stesso e alle proprie regole cieche e insensate. Contro il terrore animale esiste un solo mezzo; la sferza. «Colui che ha il potere» l’ha alzata sul marcio raziocinio: «In verità vi dico: se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde; e chi odia la sua-vita in questo mondo, la salverà per la vita eterna» (Gv. 12, 24-25). Chi non vuole perdere la propria vita rimanga pure nella geenna, nel fuoco inestinguibile dell’ ἐποχή), «dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue» (Mc. 9, 46).
E così il punto di partenza è una piena confidenza e una piena vittoria volontaria sull’inclinazione alla carnalità, sulle esitazioni che frenano l’ascesa, sulla prigionia del raziocinio, in ossequio alla fede. Coperto di sangue, dirò nello sforzo: «Credo quia absurdum est. Non voglio nulla di mio, nemmeno il raziocinio, voglio solo Te, Te solo! Dic animae meae: Salus tua Ego sum Sia fatta non la mia ma la tua volontà. Trinità Unità, misericordia di me!». (18)
Questo stadio necessario dell’evoluzione personale lo vediamo tipicamente rappresentato nella storia della Chiesa del secolo II da Tertulliano che con tutta la sua personalità ardente espresse allo stato puro il primo gradino della fede: «Credo quia absurdum». (19) Credo nonostante i gemiti del raziocinio, credo appunto perché |nell’inimicizia del raziocinio verso la mia fede vedo il pegno di qualcosa di nuovo, di inaudito, di superiore. Non discenderò nelle bassure del raziocinio nonostante gli spauracchi che esso mi agita davanti. Ho già visto che restando con il raziocinio perirò nell’ἐποχή; adesso voglio essere «insensato». Alle sue assicurazioni adulatrici ribatterò: «Menti! Le ho già udite mille volte!». E allora sibili pure implacabile la frusta.
Benedetto colui che ha conservato gli augusti
usi dei padri, le loro tradizioni notturne,
che, prosternatosi, canta i salmi,
che con la volontà ha troncato il dubbio della mente
che legge la santa Bibbia con devozione e, udita la campana del notturno, glorificando,
pregando, accende alla santa icona il cero sacro e piange dinanzi ad essa.
Dopo essermi elevato su un nuovo gradino, assicuratemi di non scivolare di nuovo sul piano del raziocinio, dico a me stesso; «Adesso credo e spero di comprendere ciò in cui credo; adesso non trasformerò in finito e temporale il mio io infinito ed eterno, e in me l’unità suprema non si dissolverà in momenti incompatibili. Adesso vedo che la mia fede è fonte di comprensione superiore e che in essa il raziocinio attinge la profondità». E riposandomi dopo gli ostacoli affrontati ripeterò tranquillo con Anselmo di Canterbury:
«Credo ut intelligam. Da principio mi sembrava di sapere qualcosa; dopo la svolta, ho incominciato a “credere”. Adesso invece so, perché credo».
L’umanità impiegò nove secoli per arrivare a questo stadio. Ora passo al terzo grado; voglio rendermi conto del significato della mia fede. Vedo che essa è adorazione del «Dio Noto», (20) vedo che non soltanto credo, ma so. I confini della fede e del sapere si fondono, crollano le mura di cinta del raziocinio, tutto il raziocinio si trasforma in una sostanza nuova, E io con gioia esclamo:
«Intelligo ut credam!. Siano rese grazie a Dio per tutte le cose. “Noi ora vediamo infatti come per mezzo di uno specchio, in modo non chiaro; allora invece vedremo direttamente in Dio; ora conosco solo in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente nello stesso modo con cui sono conosciuto” (1Cor. 13, 12)». L’umanità ha impiegato altri nove secoli per raggiungere questo gradino.
Gli stadi della fede sono dunque tre, sia nella filogenesi che nell’ontogenesi, ma nel descriverli sono andato troppo avanti. Devo tornare indietro e spiegare in che cosa consista l’ultimo stadio della fede nella Santissima Trinità; in altre parole come nella realtà venga sperimentata la verità del dogma e risolta l’ἐποχή.
L’eroismo della fede ha superato, vinto e debellata l’«insensatezza» razionalistica del dogma e ha riconosciuto che in esso sta la fonte del sapere. Però lo scopo finale resta l’immediatezza del dogma e questa, nella condizione umana, ha due gradi: la conoscenza simbolica e la conoscenza diretta (anche se non esauriente).
L’eroismo della fede sta nel passare dalla verità assertoria e immediata del mondo alla verità apodittica «del dogma, che però non è ancora un dato immediato, sta nel preferire al «qui» dubbio ma presente, il «là» attendibile ma ancora non presente.
La legge di identità, o di non contraddizione, e sua forma suprema ci sono comprensibili nelle loro possibilità; l’esigenza di percepire la realtà di questa possibilità è tutt’uno con la necessità di uscire dal piano dei concetti per entrare nella sfera dell’esperienza viva.
L’intuizione intellettuale è quell’ultimo anello che conlude tutta la catena delle deduzioni. Senza di essa ci aggiriamo nella cerchia dei postulati e dei presupposti del sapere attendibile, i quali sono ineluttabili ma inaccertabili, e tutta la catena gettata verso il cielo, resta sospesa per aria se non si aggancia «lassù», e quindi dovrà, con un sinistro tonfo, ricadere sulle nostre teste. E se la verità non esistesse affatto? In questo caso tutta la realtà si trasforma in un incubo assolutamente senza senso e folle e siamo costretti a passare ἐποχή ragionevole ma tormentosa alla folle agonia, disperatamente crudele, soffocando in eterno ed eternamente morendo senza la verità.
Tra il Dio Uno e Trino cristiano e la morte per pazzia tertium non datur. Attenzione: non esagero; semmai non trovo parole abbastanza forti per esprimermi. Non c’è nemmeno lo spazio di un capello tra la vita eterna nel seno della Trinità e la morte seconda che è eterna. Infatti il raziocinio nelle sue norme logiche costitutive o è totalmente assurdo, pazzo fino nell’intimo della sua struttura, costituito da elementi indimostrabili e quindi del tutto casuali, oppure ha per suo fondamento il translogico; o bisogna ammettere che le leggi della logica sono per principio casuali, oppure bisogna inevitabilmente ammettere che hanno un fondamento translogico, il quale dal punto di vista dello stesso raziocinio è un postulato necessario e quindi per il raziocinio ha un carattere antinomico. Ambedue le scelte oltrepassano l’ambito del raziocinio, ma la prima dissolve il raziocinio infondendo nella coscienza un’agonia insensata e sempiterna, la seconda rafforza la ragione con l’eroismo del superamento di se stessa, con la croce, la quale, agli occhi del mero raziocinio, è uno stupido rifiuto di se stessi. La fede che ci salva è il principio e la fine della croce e della concrocefissione al Cristo. Ma una fede (quella che si chiama «razionale», cioè fornita di prove provenienti dalla ragione), una fede secondo la formula di Tolstoj: «Voglio comprendere in modo che ogni tesi necessaria mi appaia come una necessità della ragione», (21) è un’escrescenza dura e maligna, rigida e pietrificata del cuore, che impedisce di volgersi a Dio, una ribellione contro Dio, un frutto mostruoso dell’egoismo umano che vuole sottomettere a sé anche Dio. Molte sono le specie di ateismo, ma il peggiore è la cosiddetta fede «razionale», o meglio razionalistica, perché, oltre a non ammettere l’oggetto della fede («le cose che non vediamo» [Ebr, 11, 1]), mostra la propria doppiezza, ammette Dìo per rigettare la sua essenza che è «l’indivisibilità», cioè la transrazionalità. La fede razionale è infamia e fetore davanti a Dio. Non crederai finché non avrai rinnegato te stesso, la tua legge. Invece, la «fede razionale» non vuole rinnegare la propria indipendenza, aseità, e inoltre afferma di conoscere la verità laddove, non rinnegando se stessa, può avere in sé soltanto se stessa. Si conosce la verità solo attraverso la verità; per conoscerla bisogna averla e per questo è necessario cessare di essere soltanto se stessi e comunicarsi alla verità. La «fede razionale» è il principio della superbia diabolica, il desiderio di non accettare in sé Dio e di spacciarsi per Dio: impostura e ribellione. L’inizio della fede è la rinuncia al monismo nel pensiero a favore di Dio. L’ininterrotta continuità monistica è la bandiera del raziocinio ribelle della creatura che si stacca dal suo Principio e Radice e si polverizza nell’autoaffermazione e autodistruzione. Viceversa la discontinuità dualistica è la bandiera dell’intelletto che perde se stesso a favore del suo Principio, e nell’unione di Lui ottiene rinnovamento e forza. All’ombra di queste due insegne contrapposte, da una parte la creatura temeraria che vuole sostituirsi al Creatore e inevitabilmente, staccandosi da Lui, piomba nell’agonia dell’eterno annientamento, dall’altra parte la creatura umile che accetta dalla verità l’eterna divinizzazione: «Ecco l’ancella del Signore, si faccia di me secondo la tua parola» (Lc, 1, 38). Ma tutto ciò è vero se la verità esiste. Quest’ultima condizione è come uno sbarramento sul ponte che conduce alla verità. Tra la conoscenza concettuale (postulativa e quindi presuppositiva) della verità, che abbiamo finora indagato, e la conoscenza propria all’intuizione intellettuale della verità (della verità sussistente, che include in sé la propria fondazione e perciò è assoluta) sta un abisso che non si può affatto aggirare e che nessuno sforzo riesce a far saltare. Perché bisogna porsi su un terreno nuovo di cui non abbiamo neanche l’idea e non sappiamo nemmeno se esista, perché i beni spirituali che cerchiamo sono posti al di là della conoscenza carnale, sono «quel che occhio mai non vide, né orecchio mai udì, né mai cuore d’uomo ha potuto gustare» (1 Cor. 2, 9; Is. 64, 3). Il ponte che conduce da qualche parte, forse all’orlo dell’abisso, forse all’Eden delle perenni gioie spirituali, oppure da nessuna parte, è la fede. Dobbiamo o morire nell’agonia sulla nostra sponda dell’abisso, o andare verso l’ignoto e cercarvi la «Terra nuova» dove «abita la giustizia» (2Piet. 3, 13). Siamo liberi di scegliere, ma dobbiamo deciderci per l’uno o per l’altro: per la ricerca della Trinità o per la morte nella pazzia. Scegli: o verme, o nulla; tertium non datur.
Forse, proprio considerando l’inevitabilità di questa scelta nacque in Pascal l’idea della scommessa con Dio. (22) Da una parte sta il tutto, ma ne siamo ancora malcerti; dall’altra sta il niente e allo stolto sembra qualcosa, ma chi ne conosce il valore reale lo considera assolutamente nulla senza quel tutto, ed esso diventa tutto se si trova il tutto. Un bottegaio espresse una volta nella forma più lampante l’idea di questa scommessa. Aveva preso in casa una profusione di lampade, icone, croci e sacramentali, e quando un «intellettuale» gli mostrò il suo scetticismo, replicò: «Eh, signor mio! Tutto questo mi costa cinquanta rubli all’anno, una sciocchezza, e sapesse gli affari che faccio!». Questa formulazione della scommessa di Pascal suona rozza, addirittura cinica, e allo stesso Pascal sarebbe parsa forse troppo interessata. Tuttavia il senso generale della scommessa rimane chiaro e uguale; vale la pena di scambiare il nulla certo con l’infinità incerta, tanto più che nell’infinità chi fa il cambio può riavere il suo nulla, ora convertito in qualcosa. Però se il vantaggio di questo scambio è chiaro per il pensiero astratto, nella vita psichica concreta non si riesce subito a realizzarlo, perché l’autonomia dell’io, presa in flagrante, si difende come una fiera ferita. Il razionalismo pagano aveva da tempo spiegato che le promesse di Cristo sono indimostrabili perché si riferiscono a beni futuri. Ma Arnobio risponde che tra due cose inattendibili bisogna preferire sempre quella che ci dà speranza. (22)
L’uomo che pensa ha già capito che non possiede nulla su questa sponda, ma per imboccare il ponte che porta al di là ci vuole sforzo ed energia. E se questo dispendio fosse vano? Non è forse meglio, pur torcendosi per i dolori dell’agonia, restare al di qua del ponte? E se lo si imbocca, vi si dovrà forse camminare tutta la vita aspettando eternamente di raggiungere l’altra riva? Ma che cosa è meglio: morire perennemente e forse, in vista della terra promessa, gelare nel freddo del nulla assoluto e bruciare nella fornace perenne dell’ἐποχή pirronistica, oppure spendere le ultime energie, forse per una chimera, un miraggio che si allontanerà man mano che si tenta di raggiungerlo? Io rimango qui; eppure una tormentosa brama e un’improvvisa speranza non mi danno pace. Allora balzo in piedi e mi metto a correre. Ma il freddo di una disperazione altrettanto improvvisa mi taglia le gambe, una paura senza confini si impossessa dell’anima: corro, corro indietro.
Andare o non andare, cercare o non cercare, sperare o disperare, temere di spendere le ultime energie e perciò spenderne dieci volte di più correndo avanti e indietro. Dov’è una via d’uscita? Dov’e uno scampo? A chi ricorrere per aiuto? Signore, Signore, se esisti, aiuta la mia anima folle, vieni Tu stesso, Tu stesso conducimi a Te! «Salvami che io lo voglia o non lo voglia». (23) Concedimi di vederti, come Tu puoi e sai. Attirami a Te con la forza e il dolore!
In questo grido di suprema disperazione è il principio di uno stadio nuovo del filosofare, il principio della fede viva. Io non so se la verità esista o meno, ma con tutto il mio essere sento che non posso farne a meno; so che, se esiste, per me è tutto: ragione, bene, forza, vita, felicità. Forse non esiste, ma io l’amo più di tutto ciò che esiste, mi unisco a lei come se già esistesse, l’amo con tutta l’anima e con tutta la mente, per lei rinuncio a tutto, perfino ai miei quesiti e ai miei dubbi. Pur dubitando, mi comporto con lei come se non dubitassi; stando sulla riva del nulla, cammino come se già mi trovassi sull’altra riva, nel paese della realtà, della giustificazione avvenuta, della conoscenza. Con il triplice eroismo della fede, della speranza e della carità è superata l’inerzia della legge d’identità. Io cesso di essere io, il mio pensiero cessa di essere mio; con un atto inattingibile rinuncio all’autoaffermazione Io = Io. Qualcosa o qualcuno mi aiuta a uscire dalla mia chiusura. Secondo san Macario il Grande, «è la verità stessa che muove l’uomo a cercare la verità» (αὕτη ἡ ἀλήθεια ἀναγκάζει τόν ἄνθρωπον ἀλήθειαν ἐπιζητεῖν). (24) Qualcosa o qualcuno spegne in me l’idea che io sia il centro della ricerca filosofica e io metto al suo posto l’idea della verità stessa. Io non sono nulla, ma rinuncio alla sola cosa che mi sia data, rinuncio a questo mio unico possesso, sacrifico alla verità l’unica cosa in mio potere, la sacrifico non per forza mia bensì per la forza della verità stessa. Se prima l’autonomia peccatrice dell’Io si sostituiva a Dio, ora con l’aiuto di Dio io sostituisco a me stesso Dio, che ancora non conosco, ma sento e amo. Getto via la paura, con volontà risoluta opero su me stesso. Abbandono la sponda dell’abisso e con passo fermo mi incammino sul ponte che, forse, crollerà sotto i miei passi. Metto nelle mani della verità stessa il mio destino, la mia ragione, l’anima della mia ricerca che è l’esigenza dell’attendibilità. In suo favore rinuncio a una dimostrazione. La difficoltà dell’atto eroico sta proprio nel sacrificare quanto posseggo di più caro, l’ultimo mio possesso, sapendo che, se anche questo mi ingannerà, se anche questo sacrificio risulterà vano, allora non ci sarà più nulla da fare. Questo sacrificio, infatti, è l’ultimo mezzo. Se la verità unitrina non rende testimonianza, dove chiederò giustizia? Imboccando il ponte della fede, mi si dischiude una profondità nuova nel passo della Lettera agli Ebrei: «La fede è il fondamento di ciò che speriamo e la prova delle cose che non vediamo» (Ebr. 11, 1); le stesse parole che prima erano una contraddizione tanto inaccettabile per il raziocinio.
Per una maggior concretezza nell’esposizione, esaiminiamo brevemente le direttrici fondamentali nella comprensione del termìne «fede» in base all’etimologia nelle diverse lingue.
Il russo verit’ (credere; vera, «fede») significa propriamente fidarsi, cioè indica un nesso morale di colui che crede con colui in cui egli crede. Alquanto simile è il tedesco glauben con i termini apparentati erlauben (permettere), loben (lodare), geloben (far voto di), lieben (amare) e l’inglese to believe (credere in qualcosa) che derivano dalla radice (cfr. il russo nella parola ljubis [ami]) e in origine significavano venerare, fidarsi e anche approvare. Il greco πιστεύειν è legato a πείθεσθαι [nell’edizione. it. che qui riproduciamo è riportato erroneamente πείσθεσθαι n.d.r.], (obbedire, propriamente «lasciarsi convincere»), ma si riferisce anche alla persona nel senso di «dare fiducia», «fidarsi». Ne consegue la proporzione:
πίστις : πιστός = fede : fedele. L’ebraico he’ĕmîn, dal verbo ‘āman (puntellare), significa «fermezza della persona e della cosa, quando ti basi su di esse», e allo stesso tempo (ciò che è molto importante) rivela la medesima radice di ‘emèt (verità). Quindi se il russo verit’ e il tedesco glauben indicano il momento soggettivo della fede, il «credere» come l’attività morale del rapporto di reciprocità con una persona determinata, l’ebraico he’ĕmîn indica la natura di questa persona quale natura della verità e la fede come permanere nella verità (a sua volta nella comprensione ebraica).
Il latino fides come il greco πίστις, indicano «dare la confidenza» e la stessa «confidenza», mentre il verbo credere è parallelo al sanscrito sraddha (mettere il proprio cuore in [Dio]) e quindi secondo l’uso latino ha significato sacrale. (35)
Note.
1 A.A. SPASSKIJ, Istorija dogmatičeskich dviženij v epochu vselenskich soborov, vol I, Sergiev Posad 1906; A.P. LEBEDEV, Istorija vselenskich soborov, in «Sobranie cerkovno-istoričeskich sočinenij», voll. III e IV, Pietroburgo 1904; V.(V.) BOLOTOV, Učenie Origena o Sv. Troice, Pietroburgo 1879; V.P. VINOGRADOV, O literaturnych pamjatnikach poluarianstva, Sergiev Posad 1912, in «Bogoslovskij Vestnik», 1911; H. COUGET, La Sainte Trinité et les doctrines antitrinitaires, 2 voll., Parigi 1905; F. TERNOVSKIJ, Greko-vostocnaia cerkov’ v periode vselenskich soborov, Kiev 1883; Ep. IOANN, Istorija vselenskich soborov, 1896; A. HARNACK, Lehrbuch der Dogmengeschichte, ed. 4; V. SAMUILOV, Istorija arianstva na latinskom zapade, Pietroburgo 1890; E. REVILLOUT, Le concile de Nicée d’après les textes coptes et les diverses collections canoniques, 2 voll., Parigi 1881 e 1899.
2 Spasskij cit., pp. 228-231.
3 Beato GEROLAMO DI STRIDONE, Lettera 15 a papa Damaso, 4 PL, 22, col, 457 a): «Tota saecularium litterarum schola nihil aliud hypostasim nisi usian novit». Questa lettera fu scritta verso la fine del 376 ed è estremamente istruttiva. La transrazionalità della formula di tre ipostasi in un’unica sostanza era troppo dura perfino per un dottore ortodosso della Chiesa; la sua audacia, incredibile in tutta la storia del pensiero, faceva girar la testa anche alle menti abituate alle massime raffinatezze intellettuali. Il beato Gerolamo lamenta: «Ma adesso, che disgrazia! Dopo il simbolo niceno, dopo la definizione alessandrina…, i campensi, un ramo degli ariani, esigono da me un nuovo nome: le tre ipostasi. Quali apostoli hanno tramandato una cosa simile?, mi chiedono. Quale nuovo Paolo, maestro delle genti, lo ha insegnato? Io domando come, secondo loro, si possono intendere le ipostasi. Mi rispondono: tre persone sussistenti. Per risposta dico che noi crediamo proprio così, ma a loro non basta l’unità nel significato ed esigono l’unità nel nome stesso: non capisco quale veleno possa nascondersi nelle voci. Noi proclamiamo: Chi non crede nelle tre ipostasi come tria enhypostata, cioè tres subsistentes personae, sia anatema. Ma siccome non siamo abituati ad adoperare questi termini, ci condannano come eretici. Se uno con la parola ipostasi intende l’essenza-usian e non ammette nelle tre persone una sola ipostasi, è separato dal Cristo: in questo caso voi e io saremo contrassegnati con il marchio del sabellianesimo. Vi supplico: fissate una definizione, se lo credete necessario, e allora non avrò timore di nominare le tre ipostasi. Se l’ordinerete, venga pure composto un nuovo simbolo dopo quello niceno; sia pure che noi ortodossi pronunciamo la stessa confessione di fede degli ariani. La scuola delle scienze profane conosce della parola ipostasi solo il significato di essenza-usian. Io mi domando chi parlerà con labbra sacrileghe di tre sostanze. In Dio c’è una natura unica, cioè quella che realmente esiste: “una est Dei et sola natura, quae vere est . Ma siccome la natura divina è una e siccome sussiste in tre persone una divinità che veramente esiste ed è una sola natura, chiunque in nome della devozione dica che sono tre, cioè che tre sono le ipostasi, ossia sostanze, tenta di asserire tre nature (“Quisquis trin esse, hoc est, tres esse hypostases, id est usias, dicit, sub nomine pietatis tres naturas conatur asserere”). Se è così, perché delle divisioni ci separano da Ario quando siamo legati dalla stessa infedeltà?… È sufficiente che nominiamo una sostanza e tre persone, sussistenti, coeterne, comperfette; si taccia pure, se si vuole, delle tre ipostasi e se ne ritenga una sola. Se invece riterrete giusto da parte nostra che si nominino tre ipostasi con la nostra interpretazione, non ci rifiuteremo. Ma, credetemi, sotto il miele si cela il veleno;
l’angelo di satana si trasforma in angelo di luce (2 Cor. 11, 14). I campensi interpretano bene la parola ipostasi, ma quando io dico che ritengo il dogma secondo la loro interpretazione, mi condannano come eretico. Perché si aggrappano tanto febbrilmente a una parola? Che cosa nascondono sotto un discorso a doppio senso? Se essi credono come spiegano, io non li condanno. Se io credo come essi professano (forse ipocritamente) di speculare, mi permettano anch’essi di esprimere il mio pensiero con le mie parole. Perciò scongiuro la tua beatitudine per la Salvezza Crocifissa del mondo e l’unisostanzialità triadica di darmi per scritto una risposta tanto significativa, vista la tua autorità, se devo tacere delle ipostasi o debba nominarle…» (op. cit., coli. 356-358).
4 Fu enorme merito di Kant rilevare che, per la ragione, nel concetto ci possono essere oggetti per nulla diversi tra loro, eppure differenti, così che la loro diversità viene percepita soltanto confrontandoli a vista. Tali oggetti sono, per esempio, la mano destra e sinistra, il guanto destro e sinistro, i triangoli della sfera simmetrici rispetto al centro ed uguali tra loro, ecc. Cfr. KANT, Von dem ersten Grunde des Vnterschiedes der Gegenden im Raum (Imm. Kants Kleine Schriften zur Logik und Metaphysik, 1768, a cura di von Kirchmann, voi. 33 [5], ed 3, pp. 124-130); De mundi sensibilis atque intellegibilis forma et principiis, 1770, c. 15; J. Kants Prolegomena zu jeder künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können (1783), ed. 4, a cura di von K. Vorlander, Lipsia 1905; Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, 1786, c. L, I, def. II, schol. III.
È vero che Kant da questo fatto dedusse, in principio, che lo spazio non è un concetto ma una realtà indipendente dal raziocinio, e in seguito che lo spazio non è un concetto ma una forma della appercezione intellettuale. Però, comunque sia, i fatti scoperti da Kant dimostrano che ci possono essere oggetti notoriamente diversi ma tali che la loro differenza non è formulata dal raziocinio, cioè che non si distinguono tra loro per questa o quella caratteristica, ma ipsa re, immediatamente. Non nelle caratteristiche ma nel senso dell’essere sta il principio della diversità; per il raziocinio, gli oggetti possono venire distinti solo uno attraverso l’altro. Com’è noto, questa scoperta kantiana fu applicata nella chimica per la prima volta da Pasteur (Vinnaja kislota i eja značenie dlja učenija o stroenii materii. Ob assimetrii organičeskich soedinenij, Pietroburgo 1894), divenne la base di tutta la stereochimica e si estese a una moltitudine di altre discipline scientifiche.
5 Noto detto dell’arciprete Avvakum. Per fornire un esempio, ecco uno dei suoi ragionamenti nello scritto indirizzato al diacono Ignatij: «Fa’ attenzione, Ignatij Solov’janin, e credi la Trinità trisussistente. Distingui la sostanza una in tre uguali: nei tre scorre la fonte della divinità. Non dire con Ario tre sostanze inuguali, ma tre sostanze, o nature, uguali. Non scavare oltre. Scindi l’inscindibile in parti uguali, uno in tre sostanze o nature. Ciascuno siede a parte: Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. I tre re celesti siedono sul trono senza nascondersi; come Pietro e Paolo e Giovanni il Teologo sono tre distinti, così si addice che il tre divino si divida» (P. SMIRNOV, Dogmatičeskie spory v raskole staroobradčestva, in Pravoslavnaja Encikiopedija, a cura di A.P. Lopuchin, Pietroburgo 1893 voi. IV, col. 1154; cfr. anche coli. 1050 ss.). È difficile vedere in queste false dottrine mostruose un errore semplicemente verbale del capo, insufficientemente istruito, del raskol. Il suo triteismo è l’espressione inconscia del generale spirito razionalistico proprio al raskol.
Il vescovo (allora archimandrita) Porfirij Uspenskij è incline a vedere in questo arianesimo addirittura un influsso storico. Descrivendo la chiesa dedicata all’Assunzione della Santissima Deipara nel monastero palestinese di S. Giacomo il Persiano, parla del quadro dei sette concili ecumenici che qui si vede: «Nel margine inferiore del quadro sono in mezzo raffigurati gli eresiarchi Ario, Macedonie, ecc., e accanto a loro un gruppo di monaci. Da notare che tutti i monaci eretici portano copricapi uguali a quelli dei nostri monaci vecchiocredenti. [Non erano forse i Russi inficiati anticamente dall’eresia ariana?] Invece gli ortodossi portano copricapi monastici (klobuki) greci, bassi, che nella forma si avvicinano ai nostri» (Episkop P. USPENSKIJ, Kniga bytija moego, 29 novembre 1843, voi. I, a cura di P.A. Syrku, Pietroburgo 1894, p. 307).
6 N.C. CEL’COV, Drevnija formy Simvola very pravoslavnoj cerkvi ili tak nazyvaemye apostol’skie simvoly, Pietroburgo 1869.
7 «…Battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» (βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος) (Mt. 28, 19). Cfr. anche la Divina Liturgia di san Giovanni Crisostomo: «E concedi a noi… di glorificare e magnificare il santissimo e magnifico tuo nome, del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo…» (δοξάζειν καˆ ἀνυμνεῖν τό πάντιμον καˆ μεγαλοπρεπές ὄνομά σου τοῦ ΠατρÕς κτλ).
Allo stesso modo sant’Ambrogio di Milano, parlando di Mt. 28, 19, dice: «Fanno rilevare che Egli [il Salvatore] disse: nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, ma non considerano che Egli vi premise “nel nome”. Egli nominò tre persone ma addusse un solo nome della Trinità… E così un Dio, un nome, una divinità, una magnificenza…» (De educatione virginis, 10, 67, 68; PL 16, col. 322).
8 Spasskij cit., voi. I, p. 500.
Basilio Magno si vantava della propria istruzione (ivi, p. 484). Suo fratello minore, Gregorio Nisseno, testifica: «Egli si preoccupava oltremodo della propria eloquenza disprezzando tutte le dignità, e per il suo valore si elevava sopra i sommi e famosi» (De vita Macrinae PG 46, col. 965).
9 PG 32, col. 333 a.
10 PG 45, col. 17 c-d.
11 Spasskij cit., vol. I, p. 267.
12 Gregorio il Teologo, Discorso 20, PG 35.
13 Id., Discorso 25, ivi.
14 Sorge qui il problema del come nasca l’idea dell’autorità del Cristo e come avvenga la misteriosa rinascita dell’anima. Non posso occuparmi di questo problema se voglio restare nell’ambito del mio studio, che ha per oggetto la teodicea e non l’antropodicea; credo doveroso notare qui una lacuna che intendo colmare con l’opera Sulla crescita dei tipi, cui penso da lungo tempo. Se il lettore non tenesse presente questa lacuna essenziale, potrebbe chiamarmi cristiano senza Cristo. È facile anche notare che in questa mia esposizione schematica tralascio anche la trattazione delle vie dell’ascesi.
15 Teofrasto, Phys. opin. fr. 6 a (Diogene Laerzio, 9, 21, 22) (DIELS, Doxogr. graeci, 483).
16 V. NESMELOV, Dogmatičeskaja sistema Grigorija Nisskago, Kazan’ 1889, p. 168.
17 Cit. in Gregorio Nisseno, Contro Eunomio, 5, PG 45, col. 688 a.
18 L’ultima espressione proviene dal Canone penitenziale di Andrea di Creta.
19 II celebre «Credo, quia absurdum» dà un’idea appena schematica del pensiero di Tertulliano. Le sue parole autentiche suonano: «Mortuus est Dei filius, credibile est, quia ineptum est; et sepultus revìxit, certum est quia impossibile est» (De carne Christi, PL 2).
20 Iscrizione che si legge sul frontone dell’ingresso occidentale della cattedrale dell’Assunzione nella Lavra della S. Trinità e S. Sergio. Siccome quest’ala, assieme al pronao di un tempo, fu costruita nel 1781 (cfr. E. [E.] GOLUBINSKIJ, Prepodobnyj Sergij Radonežskij i sozdannaja im Troickaja Lavra, ed. 2, Mosca 1909, p. 207), bisogna supporre che questa iscrizione dal profondo significato sia stata dettata dall’allora arcivescovo di Mosca Platon Levšin. Evidentemente essa esprime l’indma comprensione che egli ebbe dei rapporti che corrono tra fede e conoscenza. Un altro prelato non meno autorevole, l’arcivescovo di Cherson Innokentij Borisov, osserva acutamente: «La miope filosofia del secolo passato [sec. XVIII] sognava di rompere questa santa alleanza e di costringere il sapere a scavare la fossa alla fede; ma che cosa risultò da questo tentato matricidio? La santa fede, apprezzata da un intelletto che dimentica se stesso, si nascose nella profondità inaccessibile del cuore e la pseudoconoscenza rimase sola con i suoi sofismi nella fossa che aveva scavato» (I. CHERSONSKIJ, Opere, ed. Vol’f, vol. IV, p. 275). «Una vera filosofia può sussistere solo se alleata con il cielo, perché il vero sapere vive e si nutre non di terra ma di cielo» (Ivi, vol. X). «Noi siamo soliti a dire: il settore delle scienze, il settore del sapere, distinguendoli dal settore della fede; ma, propriamente parlando, non può esistere un settore delle scienze: esiste un unico settore illimitato, quello della fede, che interiormente si suddivide tra le scienze. Il sapere senza la fede è un mezzo senza principio e fine, e perciò chi cerca non frammenti senz’anima ma un tutto ragionevole, deve necessariamente unire la fede con il sapere» (Ivi, vol. IV, p. 274). «Che cos’è il vero sapere se non la porta naturale della fede? Che cos’è la vera fede se non il termine e il coronamento di ogni conoscenza fondata?» (Ivi, p. 156).
21 L.N. TOLSTOJ, Ispoved’, Mosca 1907. In perfetta contraddizione con questo arbitrio del raziocinio appare il principio dell’obbedienza e della crocifissione del raziocinio proposto da K.N. Leont’ev: «Io mi sottometto all’ortodossia… completamente. Accetto non solo ciò che in essa convince la mia ragione e il mio cuore, ma anche ciò che mi ripugna… Credo quia absurdum… Mi esprimo in maniera diversa: credo anche a ciò che per la debolezza umana in genere, e della mia ragione in specie, mi sembra assurdo. Non è assurdo in sé, supponiamo, ma per me è come se fosse assurdo. Tuttavia io credo e obbedisco… Forse questo è il miglior genere di fede… Noi possiamo accettare, per esempio, da qualsiasi contadino un consiglio che ci sembri ragionevole. Se un’idea altrui ha colpito la nostra mente con la sua verità, che meraviglia c’è ad accettarla? Ti pieghi a essa senza volerlo e solo ti meravigli che non ti sia venuta in mente prima di adesso. Ma credere all’autorità spirituale, sottomettersi a essa contro la propria ragione e i propri gusti nati da lunghi anni di una vita diversa, sottomettersi arbitrariamente e forzatamente nonostante tutta la tempesta delle proteste interiori, questa, mi sembra, è la vera fede» (K.N. LEONT’EV, Otec Kliment Zegergol’m, ed. 2, Mosca 1882, p. 99).
22 Sulla scommessa di Pascal con Dio, dove la posta sono i piaceri umbratili della vita terrena e la vincita è la beatitudine .eterna, cfr. B. PASCAL, Pensées, X, 1.
Si può vedere l’analisi di questo pari e la critica dell’idea pascaliana negli articoli specializzati (per non parlare delle opere di carattere generale su Pascal): S. PRUDHON, Le sens et la portée du pari de Pascal, in «Revue des deux mondes», 15 nov. 1890, pp. 285-304; L. DUGAS-C. RIQUIER, Le pari de Pascal, in «Revue philosophique», settembre 1900, pp. 224-245; J. LACHELIER, Sur le pari de Pascal, in «Revue philosophique», giugno 1901; P.S. DE LAPLACE, Essai philosophique sur les probabilités. Si tratta di un’introduzione alla sua Théorie analytique des probabilités, Parigi 1812 (1814, 1820), in Oeuvres, vol. VII, Parigi 1886. La traduzione russa fu pubblicata a cura di A.K. Vlasov, Mosca 1908. Vi si trova anche la critica della forma matematica del pari pascaliano, composta dal matematico inglese Crag. Le argomentazioni del de Laplace, e probabilmente di Crag, peccano di volgare incomprensione dell’idea di eternità.
Un’idea simile a quella di Pascal fu espressa prima di lui da Arnobio († 304), che argomenta come segue: «Non credimus, inquìtis, vera esse quae [Christus] dicit. Quid enim, quae vos negatis vera esse, apud vos liquent, cum immmentia, et nondum cassa, nullis possint rationibus refutari? Sed et ipse quae pollicetur, non probat. Ita est. Nulla enim, ut dixi, futurorum potest existere comprobatio. Cum ergo haec sit conditio futurorum, ut teneri et comprehendi nullius possint anticipationis attactu: nonne purior ratio est, ex ducibus incertis et in ambigua expectatione pendentibus, id potius credere, quod aliquas spes ferat, quam omnino quod nullas? In ilio enim periculi nihil est, si quod dicitur imminere, cassum fiat et vacuum:
in hoc damnum est maximum, id est salutis amissio, si cum tempus advenerit, aperiatur non fuisse mendacium» (Contra gentes, 2, 4, PL 5, coll., 815 b – 816 a) e Raimondo di Sabundo (fine sec. XIV-1437), Theologia naturalis sive liber creaturarum (1437). Cfr. V. DROZ, Le scepticisme de Pascal, p. 71, nota. Renouvier (Philosophie analytique de l’histoire, vol. IV, pp. 65ss.) vide in questa idea il sunto e perfino il punto di partenza di una profonda filosofia. In effetti essa fu usata, in forma riveduta e semplificata, da W. James prima nella lezione Will to Believe (col titolo: Dipendenza della fede dalla volontà e altre esperienze di filosofia popolare, trad. di S.I. Cereteli, Pietroburgo 1904) e poi messa alla base della corrente filosofica nota come «pragmatismo». Non è difficile scorgere una certa parentela di quest’ultimo con il tuziorismo dei giansenisti, ma il pragmatico oggi di moda e argomento di molte discussioni in pro e in contro non ne possiede la grandezza tragica e ascetica ed è tanto comodo da essere già riuscito a cattivarsi le simpatie del pubblico, che chiede solamente dottrine comode.
Ecco un breve elenco bibliografico delle opere in lingua russa sul pragmatismo: C. PEARSON, Grammatika nauki, trad. di V. Bazarov e P. Juškevič, Pietroburgo 1911; W. JAMES, Pragmatizm, trad. di P. Juškevič, Pietroburgo 1910; L.M. LOPATIN, Nastojaščee i buduščee filosofii (L.M. LOPATIN, Filosofskija charakteristiki i reči, Put’, Mosca 1911, in «Vopr. filos. i psich.», 1. 103); V.F. ERN, Razmyšlenija o pragmatizme (V. ERN, Bor’ba za Logos, Mosca 1911, pp. 1-25, in «Moskovskij Ezenedel’nik», 1910, nn. 17-18); A. BALABAN, Pragmatizm, in «Vopr. filos. i psich.», 1. 99, settembreottobre 1909, pp. 574-618 (alle pagine 574-575 e 598 c’è anche una bibliografia sul pragmatismo); S.S. GLAGOLEV, Novyj tip filosofii (Pragmatizm ili meliorizm), in «Bogoslovskij Vestnik», dicembre 1909. pp. 578-616; P.S. STRACHOV, Pragmatizm v nauke i religii sull’opera di W. JAMES, Le varie forme dell’esperienza religiosa, in «Bogoslovskij Vestnik», maggio 1910, pp. 112-131; ivi, giugno 1910. pp. 295-314; LAZAREV, Pragmatizm, in «Russkaja mysl’», ottobre 1909; M. EBER, Pragmatizm. Issledovanie ego različnych form, trad. di Z.A. Vvedenskaja, a cura di M.A. Licharev, introd. di A.I. Vvedenskij, Pietroburgo 1911; J.A. BERMAN, Suščnost’ pragmatizma. Novyja tecenija v nauke o my’šlenii, Mosca 1911, pp. XII + 240.
Sulla bibliografia estera riguardante il pragmatismo si possono trovare indicazioni nel libro già citato di W. James, nell’articolo di A. Balaban, ecc. Aggiungiamo soltanto: A. LALANDE, Pragmatisme et pragmaticisme, in «Revue philosophique», febbraio 1906, pp. 121156; J. BOURDEAU, Pragmatisme et Modernisme, Alcan, Parigi 1909; P. HERMANT-A. VAN DE WAELE, Les principales théories de la logique contemporaine, Alcan, Parigi 1909, pp. 207-230; F. PAULAN, Antipragmatisme et Hyperpragmatisme, in «Revue philosophique», agosto 1906, pp. 611-625; A. SCHINZ, Antipragmatisme. Examen des droits respectifs de l’aristocratie intellectuelle et de la démocratie, Alcan, Parigi 1909.
23 Ecco l’esclamazione di una ragazza in cerca di Dio: «Signore! Se esisti, mostrami che cos’è la verità e dammi la possibilità di conoscerla» (Cfr. P. FLORENSKIJ, Voprosy religioznago samopoznanija, Sergiev Posad 1907, let. II, p. 17, in «Christianin», 1907). Ancora: «Cristo mio Salvatore, che io voglia o che io non voglia, salvami! Aiutami presto, che presto perisco» (Preghiere del mattino, preghiera 8a al Signor Nostro Gesù Cristo).
24 Macario il Grande, Conversazione 7/3, PG 34, col. 525.
25 HERZOG UND HAUCH, Realencyklopädie für protestantische Theologie, ed. 3, voi. VI, Lipsia 1899, pp. 674ss., art, Glaube.
Per le considerazioni linguistiche e filologiche sulle parole «fede» e «credere», cfr. anche l’opera di A.(L) STRUNNIKOV, Vera kak uverennost’ po učeniju pravoslavija, Samara 1887, pp 35 -58 non dimenticando però che l’autore tende ad avvicinare i concetti di «fede» e «credere» a quelli di «conoscenza» e «sapere».









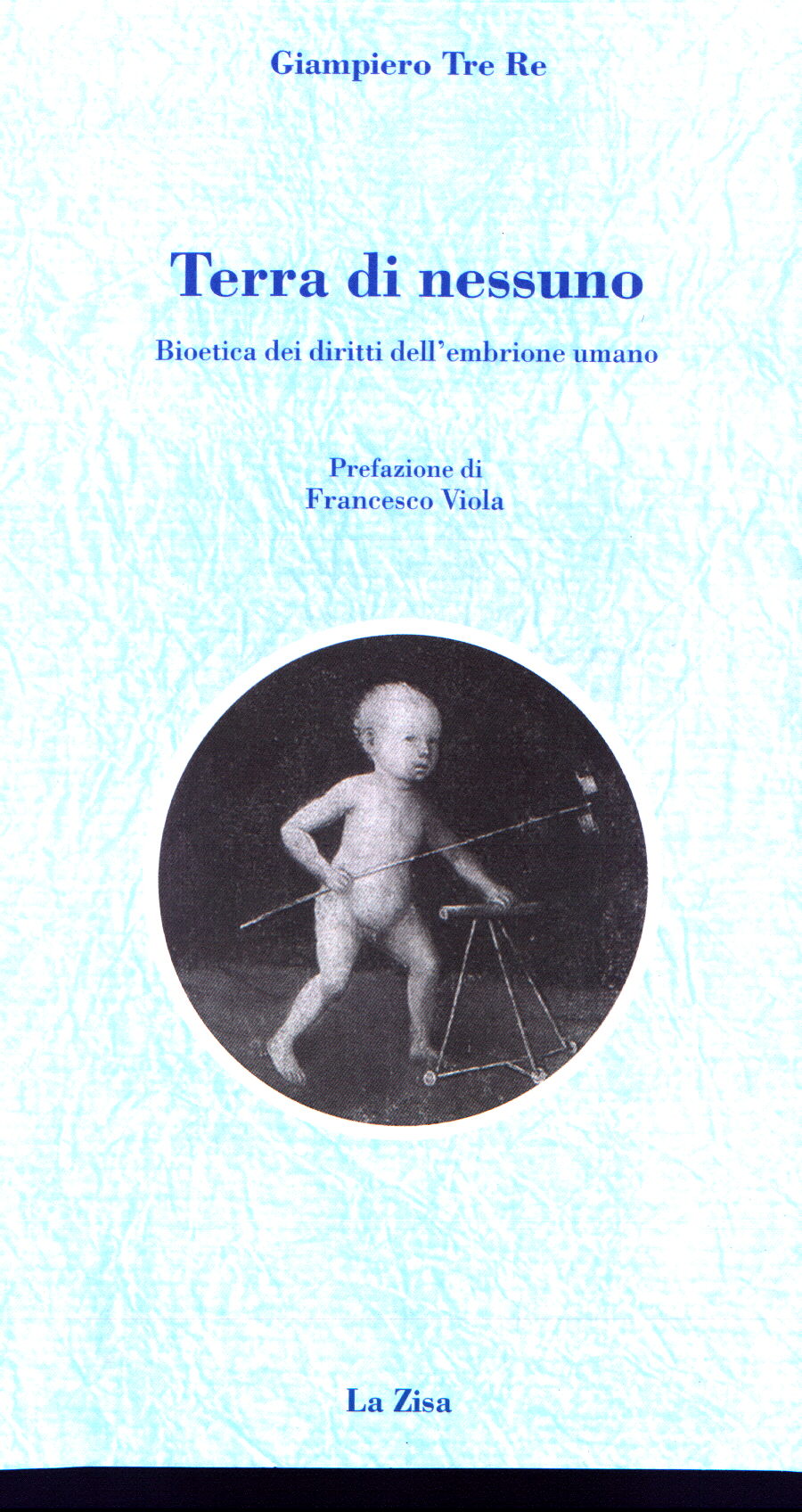
Roba x palati fini,caro Giampiero.E tu sei uno dal palato troppo fine e ami “cibi”prelibati!!
Scusate, urge un chiarimento. Ma non è che applicandosi troppo a questa lettura, si rischia di diventare come il tipo della foto? Non è di buon auspicio, direi. In tutta onestà e franchezza, io ci perderei di brutto!
E poi dicono che il troppo studio non fa male!
Vorrei vedere, dopo quattro anni di gulag.
Quello che Florenskij ha addosso non è un pigiama, ma la divisa dei detenuti.
La teologia, al contrario, rende belli, bellissimi.
P. S. Ti consiglio la lettura della voce “Florenskij” su Wikipedia. Nella compact De Agostini neppure figura; su Wikipedia è stata premiata come una delle voci migliori di tutta l’Enciclopedia.
Secondo me qui ci vuole della materia celebrale in più 🙂 e qui che qualcuno che a tre mesi sapeva già l’alfabeto
😀
Un extra di neuroni! Questa è buona.
Un supplemento di anima, ci vorrebbe.
sai cosa direbbe?” che la saggezza sta nel sapersi limitare e nel capire le proprie forze reali” e io mi esimo caro!
Dunque (se ho ben capito) non ti cimenti?
Ah poveretto! Non sapevo!
Ad ogni modo permettetemi un appunto assolutamente personale. La teologia in senso stretto non credo renda bellissimi. E’ il tocco di Dio che rende Suo riflesso e pertanto bellissimi. Lo studio della teologia può affinare questa condizione (non sempre e non a tutti) ma, la sostanza con la S maiuscola vola alta. Naturalmente come ha già esposto Giampiero altrove Parola e Trascendente sono la stessa cosa, un tutt’uno, ma personalmente sono daccordo molto, in parte, alla luce del fatto che la Scrittura ha pur sempre dei limiti invalicabili mentre, il Trascendente è infinitamente da scoprire; è particolarmente nascosto a noi.
Bravo. (Davvero).
ThanX! 🙂
Eppure non aveva ricevuto un’educazione religiosa; anzi il padre lo aveva tenuto rigorosamente lontano da ogni religione, lo stesso ambiente non favoriva alcun slancio religioso però fin da giovane aveva colto il senso del mistero nel modo più semplice che ci sia: ammirando la natura («Nelle cose più ovvie e ordinarie è nascosto un vertiginoso senso dell’infinito e della trascendenza») Un grande … un ingegnere che ha brevettato trenta invenzioni; un filosofo, un matematico, un fine teologo e oltre a tutto questo è stato un uomo che, nelle condizioni infernali del lager ha mantenuto una profonda vita spirituale,si è preoccupato di trasmettere ai cinque figli le proprie conclusioni, fino al giorno in cui immerso nei propri pensieri oltrepassò il limite della recinzione e fu fucilato all’istante.Che triste storia però.
Non “eppure”, cara 31.
Poichè.
Fortunatamente!!!
fortunatamente si perchè a quanto leggo i genitori gli insegnavano la conoscenza e il sapere escludendo completamente Dio ma poichè il Suo amore fluisce anche attraverso la natura Pavel si converti, siete voi che lo conoscete io leggo qualcosa in qua e la
Mai sentito prima.
sss
Immagino che potrebbe essere apprezzata da tutti l’idea di fare upload del pdf dei testi lunghi, ben impaginati, nella gallery multimediale e aggiungere al testo il link del pdf.
Con il copia e incolla ottengo èpagine scomposte.
Immagino che potrebbe essere apprezzata da tutti l’idea di fare upload del pdf dei testi lunghi, ben impaginati, nella gallery multimediale e aggiungere al testo il link del pdf.
Con il copia e incolla ottengo pagine scomposte.
la famiglia non gli trasmetteva niente di Dio non gli consentivano di parlare dei misteri della vita si sentiva limitato come se fra lui e loro ci fosse un muro, c’era affetto perbenismo buone maniere ma non era questo che a lui interessava. Diceva “tutte le idee scentifiche che mi stanno a cuore sono sempre state suscitate in me dalla percezione del mistero” infatti scoprì la fede nel mistero del mare, nella ricca natura del Caucaso, nei fiori nei colori e nelle rocce
Vedi quanto cose buone possono vernire fuori quando si è immuni da contaminzioni.
Meglio nessun insegnamento di un insegnamento sbagliato.
Pensando di fare cosa gradita a molti, ho inserito una nuova e più accurata impaginazione, con note in calce, della “Terza Lettera” di P. Florenskij, da La colonna e il fondamento della verità, scaricabile in formato pdf, di più agevole fruizione.
Scarica in formato pdf
Buona lettura.
Grazie!
Ci voleva!