Natura e città: un percorso ecologico
ETICA E POLITICA COME ECOLOGIA
nella tensione tra “natura” e “città”
Giampiero Tre Re
Premessa
Il percorso proposto di seguito prende come punto di partenza l’affermazione aristotelica secondo la quale la città è un prodotto naturale. Con questo celebre passo si inaugura una lunga e singolare storia di riflessioni, che attraversa per intero il pensiero politico dell’occidente.
La singolarità della vicenda risiede solo in parte nel fatto che nel corso del tempo la filosofia occidentale ha via via espresso teorie politiche diverse ed anche del tutto contrarie a quella dello Stagirita, come è accaduto, ad esempio, con Rousseau, il quale giunge alla conclusione che la città è piuttosto un prodotto artificiale. Il vero interesse dell’argomento sembra dischiudersi solo a chi lo osservi dall’odierno punto di arrivo dell’irruzione della razionalità tecnologica applicata alla “natura”. Guardata da questo punto di vista, la parabola del rapporto polis-physis appare come lo svolgersi, per tappe successive, di una traiettoria alla fine della quale i termini, così come pensati da Aristotele, risultano perfettamente rovesciati: la natura è un prodotto della città.
1. Physis e polis: le “dimensioni naturali” della città
«L’uomo è per natura un animale politico»: la più immediata conseguenza del principio stabilito da Aristotele è forse il fatto che la città è per natura, cioè ontologicamente ed assiologicamente, anteriore alla famiglia ed alle altre forme di vita umana associata ed anteriore anche all’individuo stesso, in quanto ne rappresenta la differenza specifica, costitutiva. Quest’ultima distingue, infatti, la condizione veramente e propriamente umana (tipicamente: quella del cittadino libero) non solo dall’esistenza degli altri animali, ma pure da quella della donna, del barbaro e dello schiavo.
La comunità che risulta di più villaggi è lo stato, perfetto, che raggiunge ormai, per così dire, il limite dell’autosufficienza completa: formato bensì per rendere possibile la vita, in realtà esiste per render possibile una vita felice. Quindi ogni stato esiste per natura, se per natura esistono anche le prime comunità: infatti esso è il loro fine e la natura è il fine: per esempio quel che ogni cosa è quando ha compiuto il suo sviluppo, noi lo diciamo la sua natura sia d’un uomo, d’un cavallo, d’una casa. Inoltre, ciò per cui una cosa esiste, il fine, è il meglio e l’autosufficienza è il fine e il meglio. Da queste considerazioni è evidente che lo stato è un prodotto naturale e che l’uomo per natura e un essere socievole (politikòn zvon) quindi chi vive fuori (della comunità statale per natura e non per qualche caso o è un abietto o è superiore all’uomo, proprio come quello biasimato da Omero «privo di patria, di leggi, di focolare »: tale è per natura costui e, insieme, anche bramoso di guerra, giacché è isolato, come una pedina al gioco dei dadi. E’ chiaro quindi per quale ragione l’uomo è un essere socievole molto più di ogni ape e di ogni capo d’armento Perché la natura, come diciamo, non fa niente senza scopo e l’uomo, solo tra gli animali, ha la parola: la voce indica quel che è doloroso e gioioso e pertanto l’hanno anche gli altri animali (e, in effetti, fin qui giunge la loro natura, di avere la sensazione di quanto è doloroso e gioioso, e di indicarselo a vicenda), ma la parola è fatta per esprimere ciò che è giovevole e ciò che è nocivo e, di conseguenza, il giusto e l’ingiusto: questo è, infatti, proprio dell’uomo rispetto agli altri animali, di avere, egli solo, la percezione del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto e degli altri valori: il possesso comune di questi costituisce la famiglia e lo stato. E per natura lo stato è anteriore alla famiglia e a ciascuno di noi perché il tutto dev’essere necessariamente anteriore alla parte…
ARISTOTELE, Politica, 1252b, 28 – 1253a, 29; in Id. Opere, tr. it. di L. Laurenti, Roma-Bari 1983, vol. IX, Politica, Trattato sull’economia, 6-7.
Nel prosieguo della sua Politica, Aristotele si chiede, tra l’altro, quale costituzione consenta allo Stato di realizzare al meglio i propri scopi, cioè il bene dei cittadini. La menzione del concetto di bene mostra la contiguità della politica e dell’etica aristotelica. L’incipit della Politica, che abbiamo appena letto, e quello dell’Etica a Nicomaco richiamano, del resto, da diversi punti di vista, il medesimo tema della convertibilità delle nozioni di “fine” e di “bene”, mentre l’intera Politica di Aristotele (ma anche la Repubblica di Platone) potrebbe essere letta come la ricerca di un criterio di legittimazione etica delle classi destinate al comando.
Il momento più determinante per la fisionomia dell’etica nicomachea è appunto la scelta di inquadrare l’etica all’interno del discorso politico. Essendo per natura l’uomo animale politico, ogni suo atto, compiuto secondo virtù, determinato in base a saggezza e retta ragione, sarà anche un atto rettamente e saggiamente politico.
La virtù dunque riguarda le passioni e le azioni, nelle quali s’incontra l’errore dell’eccesso e il biasimo del difetto, mentre il mezzo è lodato e ha successo: e queste due cose sono proprie della virtù. Dunque la virtù è una certa medietà, che ha come scopo il giusto mezzo. Inoltre l’errore avviene in molti modi (infatti il male è proprio dell’infinito, come raffigurano i Pitagorici, mentre il bene è proprio del finito), mentre l’esser retti avviene in un sol modo; perciò da un lato è facile, dall’altro è difficile: facile prendere la mira, difficile giungere a segno. Anche per questo dunque l’eccesso e il difetto sono propri del vizio, la medietà è propria della virtù:
in un sol modo si è buoni, in molti modo cattivi
La virtù è quindi una disposizione del proponimento consistente nella medietà rispetto a noi stessi, definita dalla ragione e come l’uomo saggio la determinerebbe.
ARISTOTELE, Etica Nicomachea, 1106b, 25 – 37 in Id. Opere, tr. it. di A. Plebe, Roma-Bari 1985, vol. VII, Politica, 39-40
La questione che potrebbe sollevarsi, a questo punto, è, allora, in base a quale criterio l’uomo saggio possa esser detto tale. La sola risposta possibile sarebbe che saggio è chi è in grado di porre quegli atti socialmente approvati (1094a, 28-1094b, 10); questi, a loro volta, sono quelli determinati dal giudizio dell’uomo saggio. Non è difficile scorgere qui un circolo vizioso analogo a quello che traspare dalle pagine della politica e che possiamo abbozzare in questo modo: poiché la vita della polis è “misura”, carattere distintivo della vita umana “felice”, cioè compiuta, realizzata secondo natura, la città assume logicamente una precedenza sulla libertà e l’uguaglianza dei cittadini; d’altro canto, sono invece i rapporti tra cittadini liberi ed uguali a divenire il criterio in base al quale i poteri degli Stati modellano le proprie forme.
E’ la polis stessa ad apparire qui come un orizzonte onnicomprensivo all’interno del quale etica e politica sembrano rimanere come imprigionate.
2. Urbs-Orbs: il mondo come dimensione della città
2.1 Teologia e ideologia costantiniana
E’ noto che lo studio del pensiero politico cristiano dei primi quattro secoli rimarca il progressivo passaggio degli intellettuali cristiani da un atteggiamento di riserva critica nei confronti dell’istituzione imperiale alla collaborazione o addirittura ad una simbiosi con essa.
Questo processo è stato sorretto dal prolungamento di alcune categorie bibliche nel campo della riflessione politica. Presentiamo qui di seguito degli esempi riguardanti, anzitutto, la metafora anima-corpo, suggerita dall’idea di Roma caput. La similitudine si trova spesso impiegata nel processo di integrazione del ruolo provvidenziale svolto dall’universalismo imperiale all’interno di un tema particolarmente caro alla teologia dei primi secoli, quello del raduno escatologico, che avrebbe concluso, alla fine dei tempi, il disegno salvifico. Ma l’applicazione della metafora anima-corpo in teologia politica sembra anche voler indicare la raggiunta consapevolezza di una linea interpretativa della storia di Roma, il cui tratto caratteristico individua nella ricerca di un’adeguata “anima” di valori da infondere allo sterminato corpo dell’impero, per impedirne l’esplosione nella miriade delle sue componenti culturali, etniche, religiose…
Cristo nume unico… Tu che ponesti lo scettro universale sul vertice di Roma comandando che il mondo debba servire alla toga quirite e cedere alla sua forza, affinché tu potessi domare con l’unità di governo tutti i costumi, le leggi, le lingue, gli ingegni: ecco tutto il genere umano è ora sotto il regno di Roma. A questo fu destinato affinché tanto meglio la legge cristiana unisse con un solo vincolo il genere umano. Concedi, Cristo, ai tuoi romani che sia cristiano lo Stato per mezzo del quale hai concesso l’unità religiosa! Si colleghino tutte le membra sparse come a segno di unità; divenga mansueto l’orbe soggetto, divenga mansueto il sommo capo.
PRUDENZIO, Peristephanon, Passio S. Laurentii, 413-440, in Grande antologia filosofica, dir. Umberto Padovani, coord. A. M. Moschetti, Milano 1973, Il pensiero cristiano, vol. V, 766.
Un’altra categoria biblica che conobbe un uso politico è quella di “immagine di Dio”. Alla base dell’universalismo religioso ebraico-cristiano sta appunto la nozione teologica dell’immagine di Dio, intesa come sapienza divina, attiva nelle operazioni divine ad extra (creazione e rivelazione) e dunque impressa nella natura (in particolare nella natura umana) e più ancora manifesta nel provvidenziale governo di Dio sulla storia. L’applicazione di tale categoria si trova in svariati testi “politici” della letteratura cristiana dei primi secoli e permise l’assimilazione teorica dell’universalismo politico di Roma. all’interno di un’interpretazione teologica dell’universalismo biblico. Nella diversità del tono dell’utilizzazione della medesima idea, nei brani che seguono, l’uno del III secolo l’altro del V, si legge il cambio di atteggiamento degli intellettuali cristiani nei confronti del potere imperiale:
Né il dare a Cesare ciò che ad esso spetta, ci impedisce di dare a Dio ciò che è di Dio. Bisogna infatti distinguere tra cose corporali e cose spirituali. Cristo quando chiese ai farisei la moneta del censo: «di chi è, disse, questa figura e questa soprascritta?» Ed essi dissero: «di Cesare».
Non solo le monete hanno l’impronta di Cesare, bensì tutte le cose corporali mentre le cose spirituali hanno l’impronta di Dio.
Ora se Gesù disse: «Rendete a Cesare le cose che appartengono a Cessare e a Dio le cose che appartengono a Dio» intese dire che, essendo il dominio di Cesare su tutte le cose corporali, ad esso bisogna dare la spettanza di queste, mentre essendo il dominino di Dio cose spirituali, ad esso queste ai dovevano dare; né l’una cosa antitesi dell’altra.
Non si dovrà dare ai principe che le cose corporali, e qualora voglia alcunché di spirituale, non glielo daremo per non usurpare Dio e non tradirlo.
Bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare, pagare cioè i tributi, ma cercare di avere il meno possibile in noi delle cose terrene sì che, allorché il principe verrà da noi, poco o nulla potrà richiederci.
ORIGENE, Commentarium in Mathaeum, XVII, 26, in Grande antologia filosofica, cit, 755.
Voi siete in certo modo la copia e l’immagine terrena del regno celeste avendo conseguito da soli il comando su tutti e conservando col timore e con la bontà i sudditi vostri. Il culmine supremo della gloria umana, o cristianissimi imperatori, è di gran lunga superiore e più cospicuo di tutti gli altri. Una sorte preclara ed un ufficio sommamente illustre fu devoluto a voi dalla divina eccellenza e maestà, tale, cioè che vi fosse in terra un certo vestigio e quasi una copia di quella somma altezza e dignità che è in cielo. Dunque, come davanti a quel sommo Iddio ogni ginocchio si piega, così è lecito scorgere nella vostra serenità un’immagine illustre e pienamente fedele di quella cospicua luce superiore a tutti.
CIRILLO di ALESSANDRIA, De recta fide ad Theodosium imperatorem, in Grande antologia filosofica, cit., 764-765.
2.2 «Fecerunt civitates duae amores duo»: lo spazio politico come luogo teologico
L’elaborazione del pensiero politico cristiano dei primi quattro secoli trova il suo equilibrio nella complessa costruzione del capolavoro di Agostino, La città di Dio. Nella visione agostiniana la città terrena e la città di Dio non si sovrappongono semplicemente alla Roma dei Cesari ed alla comunità ecclesiale. I loro confini non sono spaziali, ma si tratta piuttosto di realtà metastoriche, nel senso che, pur possedendo un loro radicamento materiale nella storia umana, esse dipendono, in ultima analisi, da principi sovrasensibili. Così la città di Dio ha una componente terrena ma le forme assunte storicamente, nelle strutture del popolo d’Israele, prima e, successivamente, nelle istituzioni ecclesiali, non ne rappresentano che un’immagine temporale, il cui compito è di tenere costantemente presente nel mondo il suo fine sovrannaturale. Allo stesso modo la città terrena non è identificabile con Roma o Babilonia, quanto, semmai, con l’universo di credenze e valori del paganesimo. In questo quadro, Roma e la sua storia, la società romana e l’impero partecipano piuttosto della storia della città di Dio, secondo l’economia che è loro propria, vale a dire perseguendo i loro fini di giustizia terrena e fintantoché questi rimangono ordinati ai fini superiori della città di Dio.
Due amori fecero le due Città: l’amore di sé, portato fino al disprezzo di Dio generò la città terrena; l’amore di Dio, portato fino al disprezzo di se stesso generò la Città celeste. Quella pone la sua gloria in se stessa: questa nel Signore: l’una cerca la gloria dagli uomini’ l’altra pone la sua gloria più cara in Dio. testimone della sua coscienza; l’una. nell’orgoglio della propria gloria, procede a testa alta; l’altra dice al suo Dio : « Tu sei la mia gloria e Tu elevi il mio capo » (Salmi 3, 3). Quella, nei suoi principi, nelle sue vittorie sulle altre nazioni che conquista, si lascia comandare dalla passione di dominio; questa ci presenta i suoi cittadini uniti nella carità; servitori gli uni agli altri, gover-nanti che consigliano, sudditi che ubbidiscono. Quella, nei prìncipi, ama la sua forza stessa; questa dice al suo Dio: «Signore, mia sola forza. io ti amerò » (Salmi 17,1). E i sapienti della prima città, vivendo secondo l’uomo, non hanno cercato il bene che in se stessi, bene del corpo, bene dell’anima, bene del corpo e dell’anima e quelli tra essi che sono giunti a conoscere Dio, «lo hanno conosciuto senza glorificarlo come Dio, senza ringraziarlo: essi si sono dissipati nel niente dei propri divisamenti; e il loro cuore in delirio si è colmato di tenebre; proclamandosi sapienti», cioè dominati dall’orgoglio che li esalta nella loro sapienza, «essi sono diventati stolti; e questa gloria spettante al Dio incorruttibile essi l’hanno prostituita all’immagine dell’uomo corruttibile, a figure di uccelli, e di quadrupedi, e di rettili» (perché essi hanno trascinato o seguito i popoli all’altare dell’idolatria); «… ed essi hanno preferito rendere il culto e l’omaggio alla creatura piuttosto che al Creatore che è benedetto per tutti i secoli» (Romani 1, 21ss)
A. AGOSTINO, De civitate Dei, XIV, 28; tr. it. La città di Dio, a cura di U. Pucci, Torino 1945, 220-221.
Nella città degli uomini, in cui convivono la città di Dio e la città terrena, il fine ultimo, quello che oggi diremmo “il senso”, sta dunque, secondo Agostino, al di sopra e al di là essa, ed il bene comune non si lascerà identificare del tutto con le strutture terrene della vita associata.
Così come nella visione cristiana la natura si presenta come un sistema in sé compiuto, ma al tempo stesso capace di accogliere in sé un ordine ulteriore di valori trascendenti, così la città, nel pensiero agostiniano, è un sistema aperto, nel tempo e nello spazio, proprio perché ha fuori di sé la sua ragion d’essere.
3. L’esperienza repubblicana a Firenze: una nuova Atene o nuova Gerusalemme?
Prima che una realtà di diritto, il comune fu una realtà di fatto, che solo successivamente venne riconosciuta tematicamente come qualcosa di davvero inedito. Lo stesso può dirsi delle nuove concezioni antropologiche che vanno modellandosi e che trovano espressione nei nuovi ruoli, nuove funzioni, nuovi soggetti politici (arti, corporazioni) e finalmente in nuove strutture visibili della città. Poiché le forme politiche storicamente assunte dalla città rispecchiano le soggiacenti concezioni antropologiche, possiamo dire che i comuni nel XIII e del XIV secolo rappresentano un passo avanti verso il modo in cui l’uomo si concepisce, oggi, nella città. Produciamo qui di seguito un testo che documenta lucidamente uno dei più singolari aspetti della città così come oggi la concepiamo, vale a dire il suo dinamismo, la sua duttilità sociale. Se confrontato con le democrazie dell’antichità, le cui strutture e classi sociali erano rigidamente fondate sulle rispettive costituzioni, il comune medievale appare una realtà assai meno immobile proprio perché tende a identificarsi piuttosto con la propria storia, la propria cultura, il proprio popolo.
Se di niuna repubblica furono mai le divisioni notabili di quella di Firenze sono notabilissime, perché la maggior parte delle altre repubbliche delle quali si ha qualche notizia sono state contente d’una divisione, con la quale, secondo gli accidenti, hanno ora accresciuta, ora rovinata la città loro; ma Firenze, non contenta d’una ne ha fatte molte. In Roma, come ciascuno sa, poi che i re ne furono cacciati, nacque la disunione intra i nobili e la plebe, e con quella infino alla rovina sua si mantenne; così fece Atene, così tutte le altre repubbliche che in quelli tempi fiorirono. Ma di Firenze in prima si divisono infra loro i nobili, dipoi i nobili e il popolo e in ultimo il popolo e la plebe; e molte volte occorse che una di queste parti rimasa superiore, si divise in due: dalle quali divisioni ne nacquero tante morti, tanti esili, tante destruzioni di famiglie, quante mai ne nascessero in alcuna città della quale si abbia memoria. E veramente, secondo il giudicio mio, mi pare che niuno altro esemplo tanto la potenza della nostra città dimostri, quanto quello che da queste divisioni depende, le quali arieno avuto forza di annullare ogni grande e potentissima città. Nondimeno la nostra pareva che sempre ne diventasse maggiore: tanta era la virtù di quelli cittadini e la potenza dello ingegno e animo loro a fare sé e la loro patria grande, che quelli tanti che rimanevono liberi da tanti mali potevano più con la virtù loro esaltarla, che non aveva potuto la malignità di quelli accidenti che gli avieno diminuiti opprimerla.
N. MACHIAVELLI, Istorie fiorentine, proemio; in Letteratura italiana Zanichelli. I classici della letteratura italiana su CD-Rom: da S. Francesco a Italo Svevo, a cura di P. Stoppelli e E. Picchi.
Machiavelli è stato spesso bollato come fautore di un’ideologia amorale, quando non addirittura immorale. In realtà, in stretta coerenza con quello che abbiamo visto essere il suo modo di concepire la città, Machiavelli ritiene che la principale virtù dell’uomo politico sia la capacità di dare la giusta interpretazione del momento storico e di rinvenire i significati pratici del bene in rapporto alle diverse situazioni concrete dell’agire. Si tratta di un modo di pensare che, se appariva decisamente scandaloso nell’ottica delle morali tradizionalistiche, anticipa temi e tipici modi di sentire dell’etica e persino della spiritualità moderna.
Io ho considerato più volte come la cagione della trista e della buona fortuna degli uomini è riscontrare il modo del procedere suo con i tempi: perché e’ si vede che gli uomini nelle opere loro procedono, alcuni con impeto, alcuni con rispetto e con cauzione. E perché nell’uno e nell’altro di questi modi si passano e’ termini convenienti, non si potendo osservare la vera via, nell’uno e nell’altro si erra. Ma quello viene ad errare meno, ed avere la fortuna prospera, che riscontra, come ho detto, con il suo modo il tempo, e sempre mai si procede, secondo ti sforza la natura. […]
Quinci nasce che una republica ha maggiore vita, ed ha più lungamente buona fortuna, che uno principato, perché la può meglio accomodarsi alla diversità de’ temporali, per la diversità de’ cittadini che sono in quella, che non può uno principe. Perché un uomo che sia consueto a procedere in uno modo, non si muta mai, come è detto; e conviene di necessità che, quando e’ si mutano i tempi disformi a quel suo modo, che rovini. Piero Soderini, altre volte preallegato, procedeva in tutte le cose sue con umanità e pazienza. Prosperò egli e la sua patria, mentre che i tempi furono conformi al modo del procedere suo: ma come e’ vennero dipoi tempi dove e’ bisognava rompere la pazienza e la umiltà, non lo seppe fare; talché insieme con la sua patria rovinò. Papa Iulio II procedette in tutto il tempo del suo pontificato con impeto e con furia; e perché gli tempi l’accompagnarono bene gli riuscirono le sua imprese tutte. Ma se fossero venuti altri tempi che avessono ricerco altro consiglio, di necessità rovinava; perché no arebbe mutato né modo né ordine nel maneggiarsi. E che noi non ci possiamo mutare, ne sono cagioni due cose: l’una, che noi non ci possiamo opporre a quello che ci inclina la natura; l’altra, che, avendo uno con uno modo di procedere prosperato assai, non è possibile persuadergli che possa fare bene a procedere altrimenti: donde ne nasce che in uno uomo la fortuna varia, perché ella varia i tempi, ed elli non varia i modi. Nascene ancora le rovine delle cittadi, per non si variare gli ordini delle republiche co’ tempi; come lungamente di sopra discorremo: ma sono più tarde, perché le penono più a variare, perché bisogna che venghino tempi che commuovino tutta la republica, a che uno solo, col variare il modo del procedere, non basta.
N. MACHIAVELLI, Discorsi su T. Livio, Lib.3, cap.9, in Letteratura italiana Zanichelli, cit.
4. La città senza luogo: utopia e tecnologia
Il pensiero politico tra cinquecento e seicento ha la peculiarità di essersi espresso soprattutto nell’elaborazione di teorie utopistiche. Questo fatto, insieme al neoplatonismo che le ispira, sembrerebbe a tutta prima suggerire l’idea di un mero ritorno al passato.
Occorre tuttavia osservare, anzitutto, che la “natura”, pensata da Moro, Campanella, Bacone, non è più la physis aristotelica, ma ha subito un profondo ripensamento teoretico ed è concepita adesso quale natura “empirica”, aperta alle possibilità conoscitive dell’uomo ed alla sua operatività. “Naturale” è pertanto anche ogni forma di agire guidato dalla conoscenza, come il buon governo, ed anche le arti e le applicazioni tecnologiche.
Nel “non-luogo” in cui vengono a collocarsi tali costruzioni teoriche comincia a farsi strada l’idea dell’attività di governo come attività tecnica e progettuale. Si tratta dunque di una produzione che anticipa temi che saranno compiutamente sviluppati nel XVIII secolo.
È un Principe Sacerdote tra loro, che s’appella Sole, e in lingua nostra si dice Metafisico: questo è capo di tutti in spirituale e temporale, e tutti li negozi in lui si terminano. Ha tre Principi collaterali: Pon, Sin, Mor, che vuol dir: Potestà, Sapienza e Amore. Il Potestà ha cura delle guerre e delle paci e dell’arte militare; è supremo nella guerra, ma non sopra Sole; ha cura dell’offiziali, guerrieri, soldati, munizioni, fortificazioni ed espugnazioni. Il Sapienza ha cura di tutte le scienze e delli dottori e magistrati dell’arti liberali e meccaniche, e tiene sotto di sé tanti ofiziali quante son le scienze: ci è l’Astrologo, il Cosmografo, il Geometra, il Loico, il Rettorico, il Grammatico, il Medico, il Fisico, il Politico, il Morale; e tiene un libro solo, dove stan tutte le scienze, che fa leggere a tutto il popolo ad usanza di Pitagorici. E questo ha fatto pingere in tutte le muraglie, su li rivellini, dentro e di fuori, tutte le scienze. Il Amore ha cura della generazione, con unir li maschi e le femine in modo che faccin buona razza; e si riden di noi che attendemo alla razza de cani e cavalli, e trascuramo la nostra. Tien cura dell’educazione, delle medicine, spezierie, del seminare e raccogliere li frutti, delle biade, delle mense e d’ogni altra cosa pertinente al vitto e vestito e coito, ed ha molti maestri e maestre dedicate a queste arti.
T. CAMPANELLA, La Città del sole, 18-21; 29; in Letteratura italiana Zanichelli, cit.
5. Uomo e città nell’età della ragione: mitologia della rivoluzione.
5.1 La natura e i diritti:
Agli inizi del ‘600 si innesca un processo di profonda trasformazione del pensiero politico occidentale; una trasformazione che condurrà all’attuale concezione generale della politica come pratica dei diritti.
Nel trattato filosofico, politico e giuridico De jure belli ac pacis (1625) Ugo Grozio, considerato il fondatore del giusnaturalismo, difende l’esistenza di un diritto naturale delle genti, che non può venire leso da nessuna condizione storica, politica o militare. L’opera esibisce, già nelle sue prime pagine, l’avvenuto trasferimento della concezione latina del diritto come “rapporto” oggettivo, che si instaura tra la persona, i beni e gli altri uomini, a “qualità” inerente alla persona.
Nell’uomo adulto, che sa coordinare le proprie azioni così da comportarsi in modo analogo in circostanze analoghe, è il caso di riconoscere, oltre che una spiccatissima tendenza alla vita sociale – per realizzare la quale egli, unico fra gli esseri animati, possiede il mezzo appropriato, ossia il linguaggio – anche la facoltà di conoscere e di agire secondo principi generali: e quanto si riferisce a tale facoltà non è certo comune a tutti gli animali, ma è proprio della natura umana.
Questa attività, conforme alla ragione umana, rivolta a conservare la società, che abbiamo testé grossolanamente delineata, è la fonte del diritto propriamente detto, il quale comprende l’astenersi dalle cose altrui, la restituzione dei beni altrui e del lucro da essi derivato, l’obbligo di mantenere le promesse, il risarcimento del danno arrecato per colpa propria e il poter essere soggetti a pene tra gli uomini
Da questa nozione del diritto ne è discesa un’altra più ampia poiché infatti l’uomo possiede, al di sopra degli altri animali, non soltanto l’impulso all’associazione di cui si è detto, ma anche il criterio per valutare le cose – future oltre che presenti – piacevoli o nocive, e quelle che possono produrre l’uno e l’altro effetto, appare evidente essere conforme all’umana natura il seguire anche in ciò un giudizio rettamente conformato secondo la norma della ragione umana, senza farsi traviare dal timore, o dalla lusinga di un piacere attuale, e senza farsi trascinare da impulsi inconsiderati, ed è chiaro che ciò che palesemente contraddice a un tale giudizio è contrario al diritto di natura: della natura, s’intende, umana».
U. GROZIO, Prolegomeni al diritto di guerra e di pace, a cura di G. FASSÒ, Bologna 19612, in VEGETTI e AA., Filosofie e società, Bologna 1981, vol. II, 244.
Nella visione del caposcuola olandese il diritto definisce innanzi tutto le relazioni tra l’io ed i suoi beni interni: la vita, il corpo, la libertà. Questi beni costituiscono il suum dell’individuo, la sua proprietà naturale, appunto. Il diritto alla libertà ed alla vita è intesa come dominium, potere. In tal modo il rapporto tra giustizia e diritto risulta rovesciato rispetto a tutta la tradizione precedente; esso è ora misurato dalla giustizia e non più sua misura. Ma poiché diritto e giustizia coincidono solo nella sfera interna dell’io, si apre la difficile questione del coordinamento dei diversi soggetti che si muovono ed interagiscono all’interno del raggio operativo definito dai rispettivi domini. Perché ciò sia possibile, in altri termini, perché sia possibile la vita associata, i soggetti, secondo Grozio – in ciò seguito da Hobbes – dovranno alienare, cioè attribuire a qualcun altro o qualcos’altro, una parte dei loro diritti e della loro libertà.
5.2 L’odissea del soggetto
All’inizio di questo nuovo modo col quale la razionalità occidentale comincia a ripensare se stessa, sembra svolgere un ruolo particolare il progetto cartesiano di una radicale rifondazione delle scienze, ed in particolare l’approdo cui giunge l’applicazione metodica del dubbio, non solo agli oggetti della conoscenza, ma allo stesso soggetto conoscente:
Questa proposizione: Io sono, io esisto, è necessariamente vera, ogni volta che la pronuncio o la concepisco nel mio spirito. Non capisco ancora abbastanza bene chi sono io, io che pure esisto necessariamente: sicché è necessario ormai che faccia estrema attenzione a non scambiare imprudentemente per me qualcosa d’altro […] Ma ora chi sono io, dato che suppongo l’esistenza di un ingannatore estremamente potente […] che abbia impiegato tutte le sue forze e la sua abilità per ingannarmi? Posso essere sicuro di avere la sia pure la più piccola cosa di tutte quelle che prima ho attribuito alla natura corporea? […] Quale degli attributi dell’anima posso affermare con certezza? Il nutrirmi o il camminare? Ma se non ho corpo, questi pure sono una pura illusione. Il sentire? Infatti anche questo non si fa senza il corpo […] Il pensare? Ecco che scopro: il pensiero è l’unico che posso affermare con certezza; esso solo non si lascia distaccare da me […] io non sono dunque, a parlar con rigore che una cosa che pensa [sum igitur praecise tantum res cogitans] cioè una mente, o uno spirito, o un intelletto, o una ragione…
R. CARTESIUS, Meditationes de Prima Philosophia, med. II.; tr. it. B. Widmar, Utet.
E’ chiaro che in questo modo si pongono le basi di un’inconciliabilità tra la costituzione naturale dell’uomo e le esigenze della vita associata e questa frattura non si pone fuori dell’individuo o nel rapporto tra questi ed il mondo, ma precisamente all’interno del soggetto. Così, in Rousseau, l’io vagante alla ricerca della propria autenticità, riconoscendo la “doppiezza” che si annida nella propria biografia, smaschera l’impostura rappresentata dalla certezza razionalistica di sé, caratteristica di una soggettività di tipo cartesiano, vale a dire ottenuta a prezzo dell’estraniazione dal proprio corpo e dell’indifferenza nei confronti della propria storia. Si pensi, ad esempio, a quelli che Rousseau chiama, nelle Confessioni, “i nostri abitanti” – i suoi fantasmi interiori – o il “processo” che Rousseau intenta… a se stesso!
Anche questo modo nuovo di concepire il soggetto (che avrà grande fortuna) come una realtà in sé molteplice e sovente conflittuale, ha i suoi riflessi sulla sfera politica. Sebbene per Rousseau, a differenza di quanto affermato da Grozio, non esistano diritti naturali (tutti i diritti, infatti, sono artificiali, sono cioè il prodotto dell’alienazione a favore della società di tutte le prerogative “naturali” – vale a dire native, primitive – dell’individuo) a causa di uno dei tipici paradossi del pensiero roussoviano vi troveremo curiose analogie con le conclusioni di Grozio ed Hobbes, per esempio negli esiti autodistruttivi della libertà individuale.
Colui che osa cominciare a formare un popolo deve sentirsi in istato di cambiare per così dire la natura umana, di trasformare ogni individuo, che, per se stesso, è un tutto perfetto e solitario, in una parte d’un più grande tutto di cui questo individuo riceva in qu4che maniera la. vita e l’essere; di alterare la costituzione dell’uomo per rin-forzarla… Bisogna, in una parola, ch’egli tolga all’uomo le forze sue proprie per dar-gliene altre che gli sono estranee e di cui non possa far uso senza l’altrui soccorso. Più que-ste forze naturali sono morte e annientate, più quelle acquistate sono grandi e durevoli, e più anche l’istituzione è solida è perfetta; di modo che se ogni cittadino è nulla, non può nulla se non mediante gli altri, e se la forza acquistata dal tutto è uguale o su-periore alla somma delle forze naturali di tutti gli individui, si può dire che la legislazione è al più alto grado di perfezione ch’essa possa raggiungere.
J.-J. ROUSSEAU, Il contratto sociale, cit. in J. MARITAIN, Tre riformatori. Lutero, Cartesio, Rousseau, trad. it., Brescia 1928, 194.
Certezza di sé del soggetto in Cartesio, debolezza dell’io in Rousseau (cfr. Confessioni). Vediamo sorgere questo conflitto, che si instaura nelle fondamenta stesse del pensiero moderno, osservandone le conseguenze sul piano politico, dal momento che va a costituire una delle premesse ideologiche più importanti soggiacenti alla rivoluzione francese.
Il tentativo di rigenerare la convivenza umana sulle basi radicalmente nuove della rifondazione del soggetto avrà esiti storici controversi a causa del suo carattere mitologico. Tale palingenesi potrà risolversi tanto in una reale emancipazione che in una alienazione, una totale remissione dell’individuo alla collettività massificante, anonima, spersonalizzata.
6. Il bel mondo nuovo: la città inquietante
Se un tratto comune a tutto il pensiero politico contemporaneo si può rinvenire (da Marx, a Nietzsche, Freud, Horkheimer, Marcuse e Foucault, e persino, per certi versi, ad un persatore “non-politico” come Heidegger, e poi ancora, alle teorie neoeugenetiche, all’ingegneria sociale e a quella genetica fino alla nascita di fenomeni culturali come la bioetica) esso è da cercare nella consapevolezza che la suggestione dell’autopoiesi umana entra, con la contemporaneità, in una fase cruciale, dal momento che le possibilità tecnologiche sono in grado di portare ad esiti estremi l’idea di homo, letteralmente, faber sui, vale a dire assoggettato alla sua sola dimensione produttiva ed egli stesso effetto dell’organizzazione sociale e dei sistemi di produzione.
Per il resto è impossibile, in questa sede, seguire il soggetto in tutte le sue peregrinazioni nella filosofia politica contemporanea ed arduo persino semplicemente accennarvi. Pertanto si segnalano di seguito, senza alcun commento, alcuni testi che contrassegnano alcuni passaggi-chiave degli esiti del percorso, con la sola eccezione di un passaggio della carta internazionale dei diritti dell’uomo proprio perché questi ultimi sembrano porsi in controtendenza rispetto a tali esiti. Il linguaggio dei diritti che diviene linguaggio politico mondiale conferma l’esistenza di una consapevolezza diffusa dei diritti. Un primo passo verso la conquista dei diritti come pratica sociale universale.
Fin qui abbiamo visto la servitù soltanto in rapporto alla si-gnoria. Poiché però è anch’essa autocoscienza, adesso bisogna considerare la servitù così come essa è in sé e per sé.
Per la servitù, inizialmente, l’essenza è il signore. Ai suoi occhi, dunque, la verità è la coscienza autonoma essere per sé, ma tale verità, per la servitù, non è ancora nella servitù stessa. In effetti, invece, la servitù ha in se stessa la verità della pura negatività dell’essere-per-sé, in quanto ha fatto in sé esperienza di questa senza.
In altre parole, tale coscienza non ha tremato per questa o per quella circostanza, né in questo o in quell’istante: essa ha provato angoscia dinanzi alla totalità della propria essenza perché ha avu-to paura della morte, cioè del signore assoluto. In questa angoscia, la coscienza è stata intimamente dissolta, ha tremato fin nel suo più remoto recesso, e tutto quanto c’era in essa di fisso è sta-to scosso. Questo puro movimento universale, questo assoluto div-enire-fluida di ogni sussistenza, però, è appunto l’essenza sem-plice dell’autocoscienza, la negatività assoluta, del puro essere-per-s-é: ecco perché la coscienza servile ha tutto ciò in se stessa.
D’altra parte, come abbiamo visto, il momento del puro essere-per-sé è anche per la stessa coscienza servile, in quanto essa lo a come oggetto nel signore. La coscienza servile, inoltre, non è soltanto dissoluzione universale in generale, ma lo è anche real-mente, in quanto il suo servizio compie effettivamente tale disso-luzione. Il servo rimuove in tutti i singoli momenti il proprio at-taccamento all’esistenza naturale, e, lavorandola, la trasforma e l’elimina.
Il sentimento della potenza assoluta in generale, e in particolare il sentimento del servizio, è invece solo la dissoluzione in sé. An-che se la paura dinanzi al signore costituisce l’inizio della saggez-za la coscienza è qui per essa stessa, ma non è ancora l’essere–per-sé. In realtà, la coscienza giunge a se stessa mediante il lavoro […]
Il rapporto negativo verso l’oggetto diviene adesso forma dell’oggetto stesso, e diviene qualcosa di permanente, proprio per-ché l’oggetto ha autonomia agli occhi di chi lo elabora. Questo termine medio negativo, cioè l’attività formatrice, costituisce nel-lo stesso tempo la singolarità, il puro essere-per-sé della coscien-za: con il lavoro, la coscienza esce fuori di sé per passare nell’ele-mento della permanenza. In tal modo, dunque, la coscienza che lavora giunge a intuire l’essere autonomo come se stessa.
G. W. F. HEGEL, Fenomenologia dello Spirito, a cura di V. Cicero, Milano 2000, 287-289.
L’elemento borghese-illuministico di Omero è stato sot-tolineato dall’interpretazione tardoromantica tedesca dell’antichità classica, che segui le orme dei primi scritti di Nietz-sche. Nietzsche ha compreso, come pochi dopo Hegel, la dialettica dell’illuminismo; e ha enunciato il rapporto con-traddittorio che lo lega al dominio. Bisogna «diffondere l’il-luminismo nel popolo, perché i preti diventino tutti preti in cattiva coscienza, e lo stesso bisogna fare con lo stato. Il compito dell’illuminismo è di fate, di tutto il contegno dei principi e dei governanti, una menzogna intenzionale». D’altro canto l’illuminismo è sempre stato uno strumento dei «grandi artisti di governo (Confucio in Cina, l’impero romano, Napoleone, il papato, al tempo in cui mirava alla potenza e non solo al mondo)… L’inganno a cui la folla va soggetta a questo proposito, ad esempio in ogni democra-zia, è estremamente prezioso: l’impicciolimento degli uo-mini, che si lasciano governare sempre più facilmente, è perseguito come un «”progresso”!». Mentre questa duplicità dell’illuminismo emerge come motivo storico fondamentale, il concetto di illuminismo, o del pensiero in costante pro-gresso, viene esteso fino all’inizio della storia tramandata […]
Il lungo errare da Troia ad Itaca è l’itinerario del sog-getto – infinitamente debole, dal punto di vista fisico, ri-spetto alle forze della natura, e che è solo in atto di formarsi come autocoscienza -, l’itinerario del Sé attraverso i miti.
Il mondo mitico è secolarizzato nello spazio che egli per-corre, i vecchi demoni popolano i margini estremi e le isole del Mediterraneo civilizzato, ricacciati nelle rocce e ne]le ca-verne da cui uscirono un giorno nel brivido dei primordi. Ma le avventure danno a ciascun luogo il suo nome; e il loro risultato è il controllo razionale dello spazio. Il naufrago tre-mebondo anticipa il lavoro della bussola. La sua impoten-za, a cui nessun posto del mare è più ignoto, tende insieme a destituire le potenze. Dove la semplice falsità dei miti (il fatto che terra e mare, in realtà, non sono abitati da de-moni), la fantasmagoria diffusa della religione popolare tra-mandata, diventa, agli occhi dell’eroe maturo, «errore», peripezia, rispetto alla chiara univocità del fine della propria conservazione, del ritorno alla patria e alla proprietà sta-bile.
M. HORKHEIMER, TH. ADORNO, Dialettica dell’illuminismo, tr. it. di R. Solmi, Torino 19974, 53-54
Articolo 21
1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo dei proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di egua-glianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3) La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo na-zionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organiz-zazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Carta internazionale dei diritti dell’uomo. Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, a cura del Centro d’informazione delle N.U. per l’Italia e Malta.
La società ha riprodotto se stessa in un crescente insie-me tecnico di oggetti e di relazioni che ha incluso l’utiliz-zazione tecnica di uomini; in altre parole, la lotta per l’esi-stenza e lo sfruttamento dell’uomo e della natura è diven-tata sempre più scientifica e razionale. Il doppio significa-to di «razionalizzazione» è rilevante in questo contesto. La gestione scientifica e la divisione scientifica del lavoro hanno largamente aumentato la produttività delle inizia-tive economiche, politiche e culturali. Risultato: un più alto tenore di vita. Nello stesso tempo e per le stesse ra-gioni, questa impresa razionale ha prodotto un modo di pensare e di comportarsi che ha giustificato ed assolto an-che le più funeste ed oppressive caratteristiche da essa palesate. La razionalità scientifico-tecnica e la manipolazione sono saldate insieme in nuove forme di controllo sociale. Si può restare paghi della supposizione che tale esito poco scientifico è il risultato di una specifica applicazione della scienza da parte della società? Io ritengo che la direzione in cui essa è stata generalmente applicata fosse inerente nella scienza pura anche là dove non ci si poneva fini pratici, e che il punto di volta va visto nel momento in cui la Ragione teorica si trasforma in pratica sociale. […]
La quantificazione della natura, che ha portato a fornire di essa una spiegazione in termini di strutture matemati-che, ha separato la realtà da ogni scopo inerente e, di con-seguenza, ha separato la verità dal bene, la scienza dall’eti-ca. Poco importa come la scienza possa ora definire l’og-gettività della natura e le relazioni tra le sue parti, essa non può concepirla scientificamente in termini di «cause finali». Né ha più importanza che il soggetto possa svol-gere un ruolo costitutivo più o meno ampio come punto d’osservazione, di misura e di calcolo, visto che egli non può svolgere il suo ruolo scientifico come agente etico, estetico o politico.
H. MARCUSE, L’uomo a una dimensione. L’ideologia della società industriale avanzata, tr. it. di L. Gallino e T. Giani Gallino, Torino 19993, 154-155.
La terra vergine della prassi collettiva, in cui ci siamo addentrati con l’alta tecnologia, è per la teoria etica ancora terra di nessuno. In questo vuoto (che è nel contempo anche il vuoto dell’odierno relativismo dei valori) si col-loca l’indagine qui presentata. Che cosa può fornire un criterio? Lo stesso pe-ricolo prefigurato dal pensiero! In questo suo balenarci incontro dal futuro, nella prefigurazione delle sue estensioni planetarie e delle sue durevoli con-seguenze sull’uomo, è possibile scoprire alfine i principi etici da cui sono de-sumibili i nuovi doveri del nuovo potere. Definisco ciò «euristica della paura». Soltanto il previsto stravolgimento dell’uomo ci aiuta a cogliere il concetto di umanità che va preservato da quel pericolo. Sappiamo ciò che è in gioco soltanto se sappiamo che esso è in gioco. Poiché qui non si tratta soltanto del destino umano ma anche dell’immagine dell’uomo, non soltanto di sopravvi. venza fisica, ma anche di integrità dell’essere, l’etica che ha la funzione di sal-vaguardarle entrambe dev’essere, al di là della dimensione della prudenza, quella del rispetto.
Tuttavia il tema vero e proprio è costituito dalla comparsa di questo nuovo obbligo, sintetizzato nel concetto di responsabilità. Pur non essendo certo un fenomeno nuovo in ambito morale, la responsabilità non ha mai avuto un tale oggetto e finora anche la teoria etica se ne è occupata poco. Sia il sapere che il potere erano troppo limitati per includere il futuro più lontano nelle previ-sioni e addirittura il globo terrestre nella coscienza della propria causalità. Anziché interrogarsi oziosamente sulle remote conseguenze in un destino ignoto, l’etica si è concentrata sulla qualità morale dell’atto momentaneo stesso, nel quale il diritto del prossimo che condivide la nostra sorte ha da essere ri-spettato. Nel segno della tecnologia, però l’etica ha a che vedere con azioni (sia pure non più del soggetto singolo) che hanno una portata causale senza eguali, accompagnate da una conoscenza del futuro che, per quanto incom-pleta, va egualmente al di là di ogni sapere precedente. A ciò si aggiunge la scala delle conseguenze a lungo termine e spesso anche la loro irreversibilità. Tutto ciò pone la responsabilità al centro dell’etica, con orizzonti temporali e spaziali corrispondenti appunto a quelli delle azioni. Per questo la teoria della responsabilità, a tutt’oggi una lacuna, costituisce il centro dell’opera.
Dall’ampliamento della dimensione futura della responsabilità attuale con-segue il tema conclusivo: l’utopia. La dinamica del progresso tecnologico mon-diale in quanto tale racchiude in sé, tendenzialmente se non programmaticamente, un utopismo implicito. E la sola etica caratterizzata da una visione globale del futuro che già esista, il marxismo, ha elevato appunto, nel suo legame con la tecnica, l’utopia a fine esplicito. Questo impone una critica approfondita dell’ideale utopico. Poiché esso ha dalla sua i più antichi sogni dell’umanità e ora sembra trovare nella tecnica anche i mezzi per tradurre in pratica il sogno, l’utopismo un tempo innocuo è diventato la tentazione più pericolosa – proprio perché idealistica – per l’umanità odierna.
H. JONAS, Il principio di responsabilità, tr. it. di P. Rinaudo, Torino 1990.
-
12 aprile 2007 alle 11:44Pace e guerra come problema ecologico « terra di nessuno
-
12 aprile 2007 alle 11:45Ecologia e psicologia. Profezie che si autoavverano: la sindrome di Cassandra « terra di nessuno
-
12 aprile 2007 alle 11:51La doppia sconfitta della democrazia « terra di nessuno
-
12 aprile 2007 alle 11:52Pensare la crisi ecologica « terra di nessuno









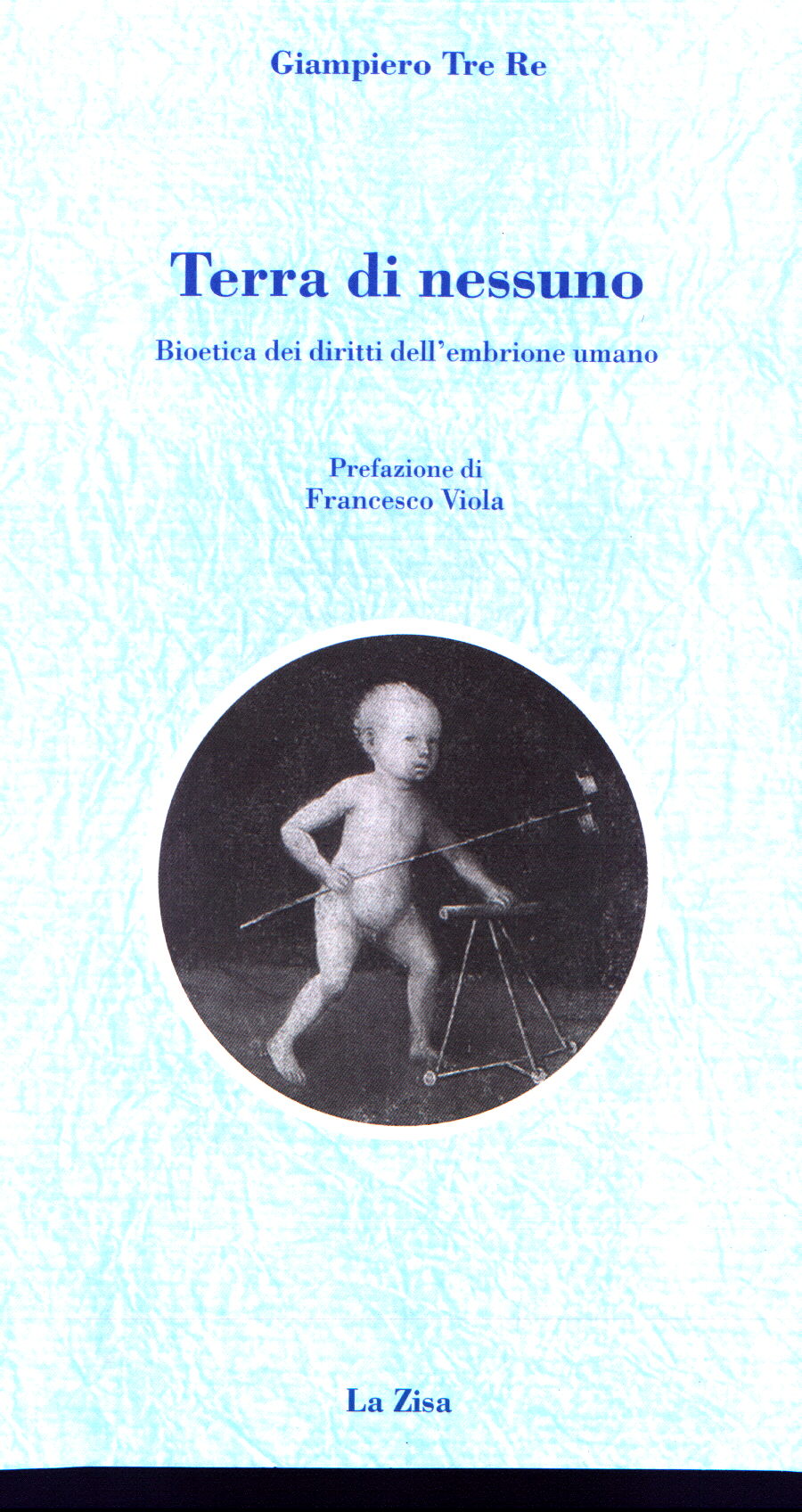
Hanno scritto