Michele Vilardo, “Santità e Legalità”. Il progetto
ARCIDIOCESI DI MONREALE CONSORZIO SVILUPPO E LEGALITÀ
«SANTITÁ E LEGALITÁ»
Per un discorso cristiano di resistenza alla mafia
nel territorio della Chiesa di Monreale
di Michele Vilardo
Il progetto denominato “Santità e Legalità”, presentato a Camporeale (Pa) il 5.6.05, fu voluto da Mons. Cataldo Naro, in collaborazione con il Consorzio Sviluppo e Legalità, che raggruppa alcuni comuni dell’alto Belice-Corleonese, per opporre una forte resistenza, per mezzo di una evangelizzazione delle coscienze credenti, al fenomeno mafioso in un territorio fortemente segnato da esso.
L’Autore, Michele Vilardo, insegnante e giornalista, è il referente per la diocesi di Monreale del Progetto culturale della Chiesa italiana.
L’arcidiocesi di Monreale e il Consorzio Sviluppo e legalità, hanno pensato di dare vita ad un progetto mirante a porre in essere una riflessione che aiuti a scoprire alcune figure di santità vissute in questo territorio, unitamente ad alcuni martiri della giustizia, come antidoto ad ogni forma di illegalità. Il progetto ha l’ambizione di voler comunicare una grande verità della fede cattolica:ossia il cammino di santità cui sono chiamati tutti i battezzati,qualora autentico,ha delle forti ricadute anche a livello sociale poiché i Santi si sono spesi anche per il bene delle comunità dove hanno vissuto arrecando sollie-vo,aiuto,conforto alle popolazioni in mezzo alle quali sono vissuti.
Questo progetto pertanto si prefigge di raggiungere i seguenti obbiettivi:
1. fare conoscere a una pluralità di soggetti che vivono in alcuni comuni dell’Arcidiocesi e fanno parte del Consorzio Sviluppo e Legalità alcune figure di Santi espressione della vita di fede e dei valori evangelici incarnati in questo ter-ritorio unitamente ad alcuni martiri della giustizia che hanno trovato la morte,per mano mafiosa,in questo territorio come figure da imitare;
2. portare ad una riflessione circa il concetto cristiano di Perdono e come cammino della vita di fede dei credenti e come medicina per lenire,nella società civile, l’odio e la vendetta scaturenti da fatti criminosi;
3. porre l’attenzione su un corretto uso dei beni materiali e del denaro alla luce del Vangelo e alla luce di ciò dare una lettura etica,morale,ecclesiale e sociale della triste piaga dell’usura.
4. proporre la riflessione su alcuni scritti,di notevole interesse.
Pertanto esso è composto dalle seguenti parti:
-Introduzione
-Parte I: alcune figure di santità della chiesa locale e alcune figure di
“martiri della giustizia e indirettamente della fede”.
-Parte II: Gesù e Mammona.
-Parte III: Il Perdono cristiano.
-Parte IV: L’usura.
-Parte V: Testimonianze per una riflessione comune.
-Conclusione.
INTRODUZIONE
Chi più dei Santi onora la propria terra? E quale altra gloria e’ più vera e più duratura di quella dei Santi? Meritevole di ogni elogio è lo scrittore, il poeta o l’ artista che educa la fantasia e conforta gli animi dei sui simili, ma più ancora il Santo, che possiede il segreto di rassicurare le coscienze e le menti, di addolcire con l’amore le sofferenze, e di ispirarsi, nella vita di ogni giorno, alla fede nel Padre Celeste. Nella Sicilia i Santi sono una schiera sterminata; e non si esagera affatto, affermando che, in fatto di santità, l’isola detiene il primato fra tutte le regioni.
L’ Isola sin dal primo momento del Cristianesimo diede i suoi figli alla nuova fede, i suoi martiri a Cristo, i suoi vescovi santi e confessori alla Chiesa. Anche gli ordini reli-giosi,presenti in questo territorio, come i Cappuccini e i Carmelitani, ebbero uomini di santa vita. Inserire in un progetto sulla legalità,che interesserà alcuni comuni dell’Arcidiocesi di Monreale,alcune figure di santità,espressione della fede cattolica tramandata e vissuta in questo territorio,a prima vista potrebbe suscitare qualche per-plessità. Qualcuno potrebbe chiedersi che cosa hanno da spartire santità e legalità. La risposta è semplice,anche se non se ne coglie immediatamente l’evidenza,il cammino di santità è un antidoto efficace contro ogni forma di illegalità ivi compresa una falsa cultura dell’onore. Il santo,infatti, è colui che, conformando la sua vita al Vangelo,dice amore e rispetto per Dio ma anche per Cesare in ottemperanza al detto evangelico “date a Dio ciò che è di Dio e a Cesare ciò che è di Cesare”. Il cammino di santità,oltre a produrre un beneficio alla persona santa e alla comunità credente produce anche un miglioramento della vita sociale e della vita quotidiana delle nostre comunità ormai da troppo tempo afflitte dal triste flagello della illegalità e in particolar modo dell’arroganza mafiosa. Tanta letteratura e cinematografia in questi anni si sono premurati,con dovizia di particolari, di far conoscere al mondo intero città come Corleone, San Giuseppe Jato, Monreale, Partinico come territori della lupara e della violenza mafiosa. In pochi hanno scritto e scrivono,però, che questi territori hanno dato i natali a delle grandi figure di santità. A Corleone è nato il santo cappuccino frate Bernardo,a San Giuseppe Jato il Beato Giacomo Cusmano,a Partinico la Beata Pina Suriano. Inoltre questa diocesi è stata governata,agli inizi del ‘900 da un Vescovo, carmelitano, morto in fama di santità: Mons. Augusto Intreccialagli. In questi ultimi anni questo territorio, ricadente sotto la giurisdizione canonica della Diocesi di Monreale, sta vivendo una straordinaria stagione di impegno civile in cui forte è la voglia di riscatto che pervade tanti uomini e donne di buona volontà che prendono in maniera consapevole e pubblica le distanze da mentalità e comportamenti ormai decisamente perdenti nella loro inseità ma che purtroppo conti-nuano a permanere. Conoscere e far conoscere alcune figure di uomini e donne santi può aiutare non poco all’affermazione della “cultura della legalità” nell’ambito di un ri-nascimento di queste terre segnate per secoli dalla fede cattolica che ha plasmato l’identità di queste popolazioni. La mafia si pone come elemento sovrastrutturale e nulla ha a che spartire con la vera identità di queste popolazioni. Dal punto di vista morale la mafia e ogni forma di illegalità sono strutture di peccato che vanno combattu-te,innanzitutto, cambiando la vita delle persone,attraverso un cammino di conversione e di santità. La Chiesa pur non avendo una comprensione sua propria della mafia ma la mutua dalla cultura in cui essa vive, è chiamata a dare il suo apporto alla comprensione del fenomeno dalla prospettiva della sua testimonianza di fede. Nella costruzione di un cammino della società siciliana alternativo alla mafia e fondato sui valori civile e religiosi ,la chiesa,non sempre esente nel passato da responsabilità, derivanti da una carenza di comprensione del fenomeno mafioso che, hanno favorito il silenzio sul fenomeno mafioso, deve dare un contributo in termini di ministerialità basando il suo cammino quotidiano di inculturazione del Vangelo sulla chiamata universale alla santità così come ci ricorda,in armonia con lo stesso messaggio evangelico,il documento conciliare “Lumen Gentiun”.Nella storia della inculturazione della fede cattolica in questo territorio dell’Arcidiocesi di Monreale,poiché ogni fede se non è inculturata è morta, emergono alcune figure di forte spessore spirituale, o già elevate agli onori degli altari o in cammino versi il riconoscimento ufficiale della loro santità di vita,che hanno detto di no con la loro vita ad ogni forma di male morale e sociale o che si sono convertiti dopo averlo fatto e che oggi devono essere additate come figure di riferimento,da venerare ma soprattutto da imitare. Queste figure,così come tutti i santi,dicono una grande verità anche all’uomo di oggi:la cultura del vangelo,la vita cristiana se vissuta autenticamente senza essere ridotta a devozionalismi e pietismi,nulla ha a che spartire con il male,il malaffare e l’illegalità. Dunque aut-aut, o il Vangelo e il suo messaggio di salvezza o la lupara. Non si può avere al pretesa di servire in contemporanea, Gesù-Cristo e il capo mafia di turno sol perché ostenta una presunta fede. Tre figure mi sembrano,pur nella diversità del loro cammino di santità e vissute in epoche diverse,eminentemente significative da inserire nel nostro progetto: San Bernardo da Corleone, il Vescovo Venerabile Mons. Augusto Intreccialagli e la Beata partinicese Pina Suriano. Proverò a tracciare un profilo essenziale della loro vita insieme ad alcune figure di servitori dello stato uccisi dalla mafia e dunque “martiri per la giustizia”. Nella seconda parte viene trattato il concetto fondamentale della fede cristiana del perdono che Dio ci da affinché anche noi possiamo perdonare chi ci ha fatto del male non come capacità umana ma, appunto per-dono di Dio. Dunque il rapporto tra la di ricchezza e la visione evangelica della stessa. Infine una breve storia dell’usura e una testimonianza pastorale sulle conseguenze dell’usura. Come epilogo ho inserito tre brani:uno del giudice Rocco Chinnici, uno di Giovanni Falcone e uno di Paolo Borsellino.
PARTE I
ALCUNE FIGURE DI SANTITA’
BERNARDO DA CORLEONE (1605 – 1667)
Religioso dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini
Nella “animosa civitas” di Corleone ebbe i natali Filippo Latino, in un secolo, il’600, pieno di aspri conflitti e di profonde trasformazioni sul piano delle strutture politiche, sociali, economiche e culturali. Il ‘600 fu il secolo in cui Filippo Latino, poi divenuto frate Bernardo da Corleone,visse la sua vicenda umana e spirituale,in un periodo storico connotato da guerre,carestie,pestilenze e dal dominio spagnolo dei Vicerè. Dal punto di vista religioso imperversava la controriforma cattolica e un grande ruolo nella predica-zione al popolo cristiano hanno avuto i frati cappuccini, fondati da Matteo da Bascio ai primi del ‘500 e che aprirono il loro primo convento a Corleone nel 1570 mentre nel 1644 iniziò la costruzione di un secondo convento dove visse anche San Bernardo da Corleone e un altro frate,morto anch’egli in fama di santità:fra Girolamo da Corleone(n. il 22-12-1639). È rimasta nell’immaginario comune, diffusa da una vecchia biografia di maniera, la figura deformata di Bernardo da Corleone come di un attaccabrighe di piazza, simile allo spadaccino Lodovico del romanzo manzoniano. Ma Filippo Latino non era così. Nato il 6 febbraio 1605 a Corleone, la sua casa era, a detta di popolo,”casa di santi”, poiché il padre, Leonardo, un bravo calzolaio e artigiano in pelletteria, era misericordioso coi miserabili fino a portarseli a casa, lavarli, rivestirli e rifocillarli con squisita carità. Molto virtuosi erano anche i fratelli e le sorelle. Su questo terreno così fertile il giovane Filippo imparò presto ad esercitare la carità e ad essere devoto del Crocifisso e della Vergine. Gestendo una bottega di calzolaio, sapeva trattare bene i suoi dipendenti e non si vergognava di cercare elemosina «per la città in tempo d’inverno per li poveri carcerati». Un solo difetto, al dire di due testimoni durante i processi, lo caratterizzava: «la caldizza ch’avia in mettiri manu a la spata quandu era provocatu». Questa «caldizza» metteva in ansia i suoi genitori, specie dopo che Filippo aveva ferito alla mano un superbo provocatore. Il fatto era avvenuto sotto gli occhi di molti nel 1624, quando Filippo aveva 19 anni, e fece grande rumore. Quel sicario prezzolato ci lasciò un braccio e Filippo, considerato la «prima spada di Sicilia», ne restò scosso nel profondo, chiese perdono al ferito, col quale diventerà in seguito amico, e maturò la sua vocazione religiosa finché, a circa 27 anni, il 13 dicembre 1631, vestì nel noviziato di Caltanissetta la tonaca dei cappuccini, i frati più inseriti nelle classi popolari, e volle chiamarsi frate Bernardo. La sua vita è semplice. Egli passa nei diversi conventi della provincia religiosa cappuccina, a Bisacquino, Bivona, Castelvetrano, Burgio, Partinico Agrigento, Chiusa, Caltabellotta, Polizzi e forse a Salemi e Monreale, ma è difficile delineare un quadro cronologicamente esatto. Si sa che trascorse gli ultimi quindici anni di vita a Palermo, dove incontrò sorella morte il 12 gennaio 1667. Il suo ufficio quasi esclusivo fu quello di cuciniere o di aiutante cuciniere. Ma egli sapeva aggiungere la cura degli ammalati e una quantità di lavori supplementari per essere utile a tutti, ai confratelli sovraccarichi di lavoro e ai sacerdoti lavando loro i panni. Era diventato il lavandaio di quasi tutti i suoi confratelli. Un intarsio di fatti e di detti, profumato da eroiche, per non dire incredibili, penitenze e mortificazioni formano la trama oggettiva e rilevante della sua fisionomia spirituale. Le testimonianze dei processi diventano un racconto splendido di caratteriz-zazioni particolari della sua personalità dolce e forte come la sua patria: «Sempre ci e-sortava ad amare Dio e a fare penitenza dei nostri peccati» .«Sempre stava intento nell’orazione… Quando andava alla chiesa, banchettava lautamente nell’orazione e unione divina». Allora il tempo spariva e spesso rimaneva astratto ed estatico. Si fermava volentieri di notte in chiesa perché – come egli spiegava – «non era bene lasciare il Santissimo Sacramento solo; egli li teneva compagnia finché fossero venuti altri frati». Trovava tempo per aiutare il sacrestano, per restare più vicino possibile al tabernacolo. Contro il costume del tempo egli usava fare la comunione quotidiana. Tanto che i supe-riori negli ultimi anni di vita, prostrato per le continue penitenze, gli affidarono il com-pito di stare solo a servizio dell’altare. La solidarietà con i suoi confratelli si apriva ad assumere una dimensione sociale. A Palermo, in circostanze di calamità naturali, come terremoti e uragani, si fece mediatore davanti al tabernacolo, lottando come Mosè: «Piano, Signore, piano! Usateci misericordia! Signore, la voglio questa grazia, la voglio!». Il flagello cessò, la catastrofe fu alleviata. Sul letto di morte, ricevuta l’ultima benedizione, con gioia ripeté: «Andiamo, andiamo», e spirò. Erano le ore 14 di mercoledì 12 gennaio 1667. Un suo intimo confratello, fra Antonino da Partanna, lo vide in spirito tutto luminoso che ripeteva con ineffabile gioia: «Paradiso! Paradiso! Paradiso! Benedette le discipline! Benedette le veglie! Benedette le penitenze! Benedette le rinne-gazioni della volontà! Benedetti gli atti di ubbidienza! Benedetti i digiuni! Benedetto l’esercizio di tutte le perfezioni religiose!».(Giovanni Spagnolo, L’onore e L’Amore, Bernardo da Corleone cappuccino e santo).
Venerabile Mons. Augusto Intrecciatagli (1852-1924)
Vescovo, dell’ordine dei Frati Carmelitani
In seguito alla prima guerra mondiale si operò in Sicilia una svolta epocale che segnò il passaggio dal modello di prete democratico cristiano a quello nuovo di sacerdote pio, devoto e pastore di anime. I fattori furono diversi: la percezione di una nuova sensibilità pastorale, gli influssi spirituali sui giovani sacerdoti nei seminari e nei collegi romani, la fine del partito popolare e il crollo di parecchie opere economico-sociali. Innanzitutto la nuova sensibilità pastorale per la tradizione cattolica, che era minacciata al suo interno dal modernismo e dai nuovi processi di secolarizzazione del costume e della mentalità, indusse Pio X alla diffidenza verso il modello di prete «sociale» e impegnato in politica e lo orientò alla proposta di un ideale sacerdotale con un più esclusivo impegno pastorale di tipo sacramentale e catechetico. Nell’arcidiocesi di Monreale fu mons. Antonio Augusto Intreccialagli a percepire la nuova sensibilità pastorale, ad accogliere gli influssi romani e ad applicare fedelmente le direttive pontificie, ridimensionando la partecipa-zione del clero alle lotte politiche e sociali, e introducendo più chiare distinzioni tra il ministero sacerdotale e la funzione di guida nel movimento cattolico. Augusto fu il primi di dieci figli, nato a Montecompatri (Roma) il 18 febbraio 1852 da Giuseppe e An-nunziata Raffaelli. A dieci anni fa la sua prima Comunione, mentre, come si usava allora, appena a sei anni aveva ricevuto il sacramento della Cresima. A quindici anni e mezzo entra al noviziato dei Padri carmelitani Scalzi in Santa Maria della Scala a Roma, prendendo il nome di fra Antonio di Gesù e l’anno seguente emette la professione sem-plice con i voti di obbedienza, povertà e castità. Dopo l’anno regolare di noviziato, pas-sò a Caprarola (VT) per gli studi di filosofia e teologia, anche se, essendo stato confi-scato il Convento (1872) dovette, con i suoi compagni, essere alloggiato alla meglio nel soffitto del Palazzo Farnese. Non mancarono fame, stenti e difficoltà. Tra le caratteristi-che particolari oltre la sua “condotta lodevole e irreprensibile”, spiccava il buonumore. Diventa sacerdote il 22 maggio 1875, nella cattedrale di Civita Castellana, a ventitre anni. Dopo una breve permanenza nel Convento di Santa Maria della Vittoria in Roma per terminare gli studi alla Gregoriana, e del tempo passato di nuovo a Caprarola e a Mon-tecompatri, è nominato Priore di Santa Maria della Scala e sei anni dopo, a soli trenta-nove anni è eletto Provinciale della Provincia Romana dei Carmelitani Scalzi. Dopo il terzo triennio da Provinciale, intervallato dopo il secondo da tre anni, cominciò a ricevere incarichi nell’ambito della Chiesa universale, prima come Consultore della Congregazione dei Vescovi e dei Regolari e poi quello di Consultore della Sacra Congregazione dei Riti e membro della commissione per l’approvazione dei nuovi Istituti Religiosi femminili e Visitatore Apostolico di vari seminari e Diocesi. Ricordiamo gli Istituti che hanno beneficiato del suo aiuto e sostegno: la Congregazione dei Salvatoriani, l’Istituto dei Pallottini, le Figlie della Misericordia e della Croce fondata dalla partinicese Madre Rosa Zangara, le Suore cappuccine dell’Immacolata di Lourdes, ordine fondato dalla SERVA DI DIO MARIA DI GESU’ SANTOCANALE nata a Palermo ma vissuta,morta e sepolta a Cinisi, l’Istituto delle Oblate del Divino Amore, l’Istituto delle Orsoline di Famiglia e infine l’Istituto delle Suore della Carità di Maria immacolata d’Ivrea. Nell’aprile 1907 i Carmelitani Scalzi tennero a Roma il Capitolo per l’elezione del nuovo Superiore Generale. Papa Pio X, conoscendo le doti del P. Antonio di Gesù, ed il suo attaccamento alla Santa Sede, espresse ai Padri Capitolari il desiderio che a questa carica venisse eletto lui, che tante prove aveva offerto di capacità e di saggezza. Ma i disegni di Dio, in quel caso, non coincisero con quelli del Papa e P. Antonio non fu eletto Superiore Generale. «Non l’hanno voluto loro – disse Pio X – allora me lo prendo io e lo nominò Vescovo di Caltanissetta». Alla delegazione nissena, recatasi l’indomani della sua Consacrazione a ringraziare il Papa, per aver loro dato Mons. Intreccialagli come Vescovo, S. Pio X rispose: «Non vi ho dato un Vescovo, ma un Santo» E aggiunse che dovevano ringraziare «Iddio e ricevere il prezioso dono come dal Cielo. E, però, doversi da tutti i fedeli diocesani ritenersi come tale e tutelarlo come cosa di inestimabile valore…». Nel suo primo messaggio alla sua Diocesi Mons. Intreccialagli diceva: «Vengo a voi, per vivere della vostra vita, per partecipare alle vostre gioie e ai vostri dolori, per guidarvi nella via della Verità, della Giustizia e della Pace…». E al clero: «Cammineremo secondo la nostra vocazione, quando saremo tutti intenti a santificare noi stessi e a renderci istruiti ed atti a zelare efficacemente il bene spirituale del prossimo…». C’è in queste parole tutto un programma di vita e di santificazione che il Vescovo vuole realizzare per il bene delle anime. Il clero rispose generosamente ai suoi inviti e alle sue sollecitazioni. Pur avendo trovato tra i preti dolorose divisioni, egli si adoperò, perché i suoi sacerdoti dimostrassero ai fedeli «quanto è bello e giocondo che i fratelli stiano uniti» nella carità. «Il mio nome è Intreccialagli, soleva ripetere, ma il mio desiderio ardente è di intrecciare i cuori dei miei Sacerdoti!». Si dimostrò così un padre provvido, che curava innanzitutto la formazione spirituale e provvedeva alla vita materiale e preveniva i bisogni dei Sacerdoti in necessità. Volle la Lega Pro Clero, perché i fedeli collaborassero con la preghiera, il sacrificio e l’offerta alla santificazione dei Sacerdoti e curò l’Unione Missionaria del Clero. Le sue «attenzioni per le opere cattoliche e per le altre istituzioni diocesane furono grandissime, curò anche il finanziamento degli orfanotrofi e degli istituti femminili della Diocesi e non lasciò mai nulla di intentato, perché l’Azione Cattolica nella sua diocesi si sviluppasse e si consolidasse sempre più. Si distinse anche per il suo impegno in campo sociale. Curò che le Casse Rurali e le Cooperative si mantenessero nello spirito nel quale erano sorte: come mezzo cioè di e-levazione economica e sociale, ma sempre nello spirito cristiano.
Si recava spesso a visitare le solfatare, dove tanti suoi figli, anche assai giovani, lavora-vano duramente, per un tozzo di pane. Si intratteneva con essi sulle condizioni delle loro famiglie , e ogni volta elargiva l’offerta di almeno 10 lire a ciascuno degli operai più poveri.
Si interessò perché sorgessero nelle predette miniere cappelle, per dare la possibilità ai minatori di adempiere il precetto della Messa domenicale.
Dopo il catastrofico terremoto di Messina e Reggio fece accogliere diverse famiglie ter-remotate nella sua diocesi e da parte sua cercò di aiutarle con tutti i mezzi a sua disposi-zione. In quegli anni molte famiglie siciliane, data la grande miseria che incombeva sull’isola, furono costrette ad emigrare in America, per cercare lavoro. Anche a molte di esse la sua carità venne incontro, pagando di tasca sua il viaggio per tutta la famiglia. Papa Pio X non dimenticava quel Carmelitano che nel cuore della Sicilia faceva rifiorire il deserto.
E il 24 Luglio del 1911 fu nominato Amministratore Apostolico di Monreale, dato che l’Arcivescovo della cittadina normanna mons. Domenico Gaspare Lancia di Brolo, aveva raggiunto la veneranda età di 92 anni e non era più in grado di reggere l’Archidiocesi.
Per mons. Intreccialagli ubbidire era come respirare e, davanti alla nomina del Papa, disse ancora una volta di sì.
La sua resistenza fisica , fu scritto di lui , corroborata da una volontà decisa, da una a-bitudine ferma, dal rigido ascetismo del Carmelo, gli permetteva il riposo di poche ore notturne. Di regola era in piedi in tutte le stagioni alle ore quattro attendeva alla preghie-ra, alle cinque celebrava il santo Sacrificio nella cappella privata, impiegava le prime ore del giorno a sbrigare la corrispondenza. Poi iniziava le udienze, affrontando con serenità e sagacia i problemi che gli venivano presentati. Si svolgeva così la giornata attiva di questo Vescovo contemplativo, tutto proteso all’unione con Dio, che realizzava senza soste nell’incontro e nel servizio dei suoi figli.
Il 16 Marzo del 1914 veniva eletto Arcivescovo Titolare di Sardica e Coadiutore con diritto di successione a Monreale.
Al suo arrivo a Monreale come Coadiutore, la situazione era alquanto scossa e difficile, a causa sia della tarda età del precedente Arcivescovo, sia per gli effetti della dottrina modernistica che, sia pure limitatamente, aveva procurato nel Clero incomprensioni ed abusi. Inoltre, dovette usare molta prudenza, data la particolare situazione del capoluogo dell’ Archidiocesi, in cui erano contemporaneamente presenti tre Arcivescovi: lui, mons. Lancia di Brolo e mons. Fiorenza, già Arcivescovo di Siracusa e allora rettore del Seminario. Circondò di sommo rispetto e di venerazione il vecchio Arcivescovo mons. Domenico Gaspare Lancia di Brolo. E quando seppe che si pensava da parte del potere civile di interdirlo per la tarda età di 92 anni, intervenne energicamente con una vigorosa lettera al Procuratore del Re, per impedire tanta ed immeritata umiliazione ad un Ve-nerando Pastore.
Per oltre dieci anni egli attese al governo delle due Diocesi con grande impegno e am-mirabile spirito di sacrificio. Il 31 Luglio 1919 morì all’età di 94 anni l’Arcivescovo di Monreale mons. Gaspare Lancia di Brolo ed Egli fu promosso a quella sede Metropoli-tana. Soddisfazione a Monreale, sgomento e pena a Caltanissetta.
Cosa passava nell’animo dell’interessato? Così si esprimeva in una lettera:
«Il mio desiderio sarebbe di tornare al chiostro… Il Santo Padre lo sa; non so se egli mi esaudirà. Se non mi esaudirà, farò la volontà di lui, riconoscendo in essa la volontà del Signore…». Certo, non è indifferente dinanzi alla nuova situazione, se nella stessa lettera scrive: «… non sono io che vado, ma è il Signore che vuole che colà mi sacrifichi… La mia povera umanità soffre al cambiamento tanto sensibile da Caltanissetta a Monreale. Ma bisogna soffrire, per meritare qualche cosa…».Provò non poche difficoltà con il clero. «Voi meritereste di essere preso a calci!» disse un giorno ad un prete che faceva da capomafia, dopo averlo paternamente, ma alquanto duramente posto di fronte alle sue responsabilità. Quelle parole dure, ma temperate dalla sua bontà, scossero profonda-mente quel sacerdote, spingendolo ad una conversione sincera. Dopo qualche tempo, lo stesso Arcivescovo, accertatone il cambiamento di vita, lo nominò parroco. Un altro sa-cerdote che era stato sospeso «a divinis» per alcuni giorni, presentatosi all’ Arcivescovo, per chiedergli scusa, si vide consegnare una busta con denaro dal suo Pastore che gli disse paternamente: «Questa è la elemosina delle Sante Messe che avreste dovuto celebrare durante i giorni della sospensione». Ancora un’altra volta che aveva minacciato una sospensione ad un sacerdote, ad un confratello che si era presentato a lui, per intercedere per il colpevole, l’Arcivescovo rispose: «Figlio mio, è da tre notti che non dormo, pensando che debbo dare una punizione ad un sacerdote!» E desistette dal prendere quel provvedimento.
Questi suoi modi di fare gli conquistarono poco a poco i cuori dei Sacerdoti e dei fedeli. Il grave problema della mafia fu combattuto da mons. Intreccialagli a modo suo, senza cioè troppi strombazzamenti, ma affrontando direttamente uomini e situazioni. E quan-do la mafia, voleva costringerlo ad affidare l’arcipretura di un paese ad un sacerdote as-solutamente non idoneo, l’Arcivescovo fu irremovibile con stupore e ammirazione della stessa mafia. «Costoro, diceva, non sanno cosa voglia dire Vescovo; nessuno mi farà mai piegare a detrimento dei miei doveri e da me si viene, per farmi capitolare dinanzi ai doveri della giustizia e della carità. La vita sì, se la vogliono, l’anima no!». «Giustizia e Pace» era il suo motto episcopale e non venne mai meno ai suoi doveri e impegni pa-storali.
Fu veramente il padre amorevole di tutti, che si impegnò costantemente a riabilitare e valorizzare opere e persone, a ricercare laboriosamente la verità e a interpretare beni-gnamente ogni azione.
La gente guardava ammirata il suo Arcivescovo che usava i mezzi pubblici, che cammi-nava per le strade, salutando per primo.
A chi faceva notare che non si confaceva ad un Arcivescovo «andare in tram» aggiun-gendo che il suo predecessore di carrozze ne aveva più di una, egli rispondeva che il de-naro serviva per i poveri e per il seminario.
E per i poveri ebbe un amore quasi di venerazione. A chi aveva l’incarico di annunziarne le visite, proibì di licenziarli, e se fossero stati in molti, li introducesse tutti in una volta. Si può dire che visse sempre in maniera autentica il suo voto di povertà, e questo lo faceva sentire ancor più vicino ai «suoi poveri». La forza di questa sublime testimo-nianza la prendeva dalla preghiera. Il custode della Cattedrale testimoniò che l’Arcivescovo spesso, attraverso la porta interna dell’Episcopio, scendeva in Cattedrale, dopo la chiusura, solo, con i sandali e qualche volta a piedi nudi, e si intratteneva per parecchio tempo davanti al Santissimo Sacramento.
Questa figura, prostrata davanti al Tabernacolo in preghiera è l’immagine più vera del grande Arcivescovo di Monreale. «Ci riposeremo in Cielo» era solito ripetere a chi lo invitava a «moderarsi nel lavoro». Egli «aveva dimenticato se stesso, per servire gli altri» e adesso avvertiva il peso degli anni. «lo mi trovo bene,scriveva nel 1921, ma con 70 anni sulle spalle. Di malanni ne aveva parecchi che nelle lettere chiamava “passeggeri”. Ma è evidente che questi disturbi, col passare degli anni e non sempre debitamente curati, si fecero sempre più pesanti. I medici gli consigliavano riposo e aria salubre. Si fermò, ai primi di Giugno 1924 nella sua Montecompatri, ma in occasione del Congresso Eucaristico Nazionale, nel Settembre del 1924, tornò a Palermo. Ormai allettato volle ugualmente partecipare alla solenne Ora di adorazione in ginocchio dinanzi al Santissimo Sacramento. Aveva voluto anche tenere i Vespri Pontificali la vigilia dell’ 8 Settembre, festa della Natività di Maria, nonostante il divieto dei medici.
Ormai stremato dalle sofferenze, faceva fatica persino ad ingoiare, tanto che alla suora che gli chiedeva se soffrisse molto, rispose con un filo di voce: «soffro: è terribile!» e ripeteva senza sosta: «mio Dio, mio Dio…» A chi delicatamente gli faceva notare che non sempre si era curato della sua salute, rispose: «È vero, mi sono trascurato, ma che volete? Un Vescovo ha dei doveri molto superiori alla sua salute…».
Volle ricevere, il 12 Settembre, il Santo Viatico, seduto sulla sponda del letto, vestito dall’ abito religioso. Prima di ricevere l’Ostia Santa dal suo Vicario Generale, chiese perdono agli astanti, quasi non avesse saputo compiere bene i suoi doveri pastorali. La sera del 18 Settembre rinnovò i suoi voti religiosi, ripetendo mentalmente la formula re-citata dal confratello P. Guglielmo di S. Alberto, giunto al suo capezzale. L’indomani, venerdì, 19 Settembre 1924, alle 16 pomeridiane, spirò serenamente, incontrandosi con il Signore che tanto aveva amato.
PINA SURIANO (1915-1950)
Laica dell’Azione Cattolica
A Partinico, centro agricolo della provincia di Palermo, che fa parte dell’arcidiocesi di Monreale, il 18 febbraio 1915 nacque Giuseppina Suriano, la quale sarà poi sempre co-nosciuta con il diminutivo di Pina. Era il primo frutto dei giovani sposi Giuseppe e Gra-ziella Costantino i quali vivevano dei modesti, ma pur sicuri, proventi che derivavano loro dal lavoro dei campi. Il 6 marzo 1915, Pina ricevette il Battesimo in quella che allora era l’unica chiesa parrocchiale di Partinico, Maria SS. Annunziata. A Pina la natura aveva concesso un’indole docile e sottomessa, particolarmente sensibile allo spirito religioso che aleggiava in famiglia. La sua serenità d’animo la portava ad interessarsi delle cose semplici della vita, cose che ruotavano intorno ad un senso del religioso fin d’allora acceso e che, lungo l’arco della sua vita, sarà in cima ai suoi interessi. Circondata dall’affetto dei suoi parenti , Pina viveva allora nella grande casa dei nonni con tutti i familiari che la colmavano d’affetto, essendo la prima nipote e da loro ricevette la prima educazione morale e religiosa, che fu poi perfezionata, a partire dall’età di quattro anni, presso l’asilo delle Suore Collegine di San Antonio. Nel 1921, a sei anni, Pina fu iscritta alla scuola comunale di Partitico e per tutto il quinquennio elementare, ebbe come maestra la Sig.na Margherita Drago, la prima vera ammiratrice delle sue singolari virtù. L’amore che Pina aveva per la scuola era grande: tutte le materie la interessavano e la riempivano di gioia. Il 1922 a pochi giorni l’uno dall’altro, ricevette i Sacramenti della Penitenza, della Prima Comunione e della Cresima. E’ proprio dello stesso anno il suo ingresso nell’ Azione Cattolica (A.C.) come beniamina prima, poi aspirante e quindi giovane. Era ancora una bambina dodicenne o poco più quando Pina iniziò a partecipare, con profondo spirito ecclesiale, alla vita parrocchiale e diocesana, prendendo parte attiva a tutte le iniziative di A.C. e a quelle che erano dettate dal bisogno dei problemi locali. Fece della parrocchia il centro motore delle sue azioni, in totale cooperazione delle disposizioni del parroco Don Antonio Cataldo, che era su direttore spirituale e confessore. Nel 1937 essendo stata eretta la nuova parrocchia di Maria SS. del Rosario Pina continuò la sua attività nella nuova parrocchia perché come territorio apparteneva ad essa, cui fu primo parroco Don Andrea Soresi; prima confessore e direttore spirituale poi biografo di Pina. Nel 1938 fu nominata delegata delle sezioni minori: angioletti, piccolissime, beniamine, aspiranti. Dal 1939 al 1948 fu segretaria della stessa A.C. e dal 1945 al 1948, pur facendo parte del gruppo Donne, fu nominata Presidente delle giovani dietro pressante richiesta delle stesse giovani; continuò a fare la segretaria. Nel 1948 fondò l’associazione Figlie di Maria e fu presidente di questa nuova associazione fino alla morte. L’adesione di Pina all’A.C. è una realtà da tenere ben presente, giacché gli interessi che lei da allora coltivò, le aspirazioni e gli atti religiosi propri della sua vita, erano motivati proprio dalla sua compenetrazione d’essere un membro dì questa organizzazione. Ciò spiega, tra l’altro, come abbia potuto, con gli anni, diventare un’esperta della vita e del messaggio di Gesù, della missione della Chiesa e della vocazione degli uomini alla santità. La Beata pose a fondamento del suo apostolato la preghiera, i sacrifici, la S. Messa, comunione e meditazione quotidiana; studiando la parola dì Dio e seguendo il magistero ecclesiastico. Una menzione merita il rapporto tra Pina e la propria famiglia giacché, malgrado ella in quest’ambito si comportasse come figlia perfetta nei servizi che le imponevano e nella sottomissione ai genitori, dovette scontrarsi con un ostracismo totale della mamma verso le sue pratiche religiose: questa, in particolare, non voleva che trascorresse tanto tempo in chiesa, poiché i propositi matrimoniali che nutriva per lei venivano in tal modo ad essere vanificati. A dimo-strazione che l’impegno religioso di Pina scaturiva da una precisa e convintissima scelta di vita, si pone il voto dì castità che ella fece il 29 aprile 1932 nella chiesetta delle Figlie della Misericordia e della Croce, che era la sede sociale della G.F. Le parole che ella pronunciò e volle scrivere sul suo diario in quel giorno sono le seguenti: «In questo giorno solenne, Gesù mio, io voglio unirmi più a te e prometto di mantenermi sempre più pura, più casta per essere un giglio candido degno del Tuo giardino» La serietà del voto emesso si deduce anche dal fatto che Pina lo rinnovava mensilmente, con il permesso del direttore spirituale e coerente al voto emesso, con garbo ma fermamente, respinse le diverse proposte di matrimonio che più di un giovane, conquistato dalla sua grazia ed anche dalla sua avvenenza, le rivolse. Diversi furono i tentativi fatti da Pina per realizzare il suo desiderio di farsi suora, ma si trovò dinanzi a insormontabili difficoltà. Intanto, che Pina pregava, sperando di ottenere la benedizione dei suoi genitori, per entrare nella vita religiosa, partecipava con spirito ecclesiale, alla vita della parrocchia e della diocesi; ciò sia come socia e dirigente dell’A.C., sia come presidente della Pia Unione delle Figlie di Maria. Vistasi preclusa ogni via alla vita religiosa, Pina volle dare a Gesù l’ultima prova del suo immenso amore ed il 30 marzo 1948, insieme ad altre tre compagne, si offriva come vittima per la santificazione dei sacerdoti. Prima di imboccare il doloroso tunnel della malattia, nel settembre 1948, ebbe la soddisfazione grandissima di recarsi in pellegrinaggio a Roma, in occasione del XXX della G.F. Davvero straordinaria la coincidenza tra l’offerta di vittima, fatta dalla beata Pina nel marzo 1948, e l’affacciarsi di una forma di artrite reumatica così violenta da causare quel difetto cardiaco che l’avrebbe portata alla morte. Fino all’ultimo infatti continuò a spandere sublimi esempi di perfezione, lieta che la sua offerta di vittima per la santificazione dei sacerdoti fosse stata accettata morì improvvisamente per infarto il 19 maggio 1950. Per la partecipazione della gente alla camera ardente e ai funerali si vide chiaramente come l’opinione comune era che fosse morta una santa. Il giorno seguente, dopo i funerali, celebrati nella parrocchia del Rosario, alla salma di Pina fu data sepoltura nel cimitero comunale di Partinico nella tomba di famiglia. Il 18 maggio 1969 avvenne la definitiva traslazione del corpo dal cimitero comunale alla Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore in Partinico.
ALCUNE FIGURE DI MARTIRI DELLA GIUSTIZIA
Giovanni Paolo II, nella sua visita in Sicilia, ad Agrigento, nel 1993, pronunciò una e-spressione riferita a persone uccise dalla mafia: “Martiri della giustizia e indirettamente della fede”. Questa espressione apre ad una nuova concezione del martirio legato non direttamente alla testimonianza della fede ma alle perenni questioni dell’uomo e quindi ad essere segno che illumina chi si pone nella ricerca di un senso dell’esistenza. Nella storia della fede cristiana il martire è colui che muore a causa di un odio contro la fede,nella misura in cui la fede viene concepita e vissuta come una realtà dinamicamente aperta e inglobante la carità,si potrà operare una equilibrata dilatazione del concetto di martirio. Il Papa ha operato un forte e convinto rilancio del martirio,inteso non come qualcosa di straordinario ma inserito in un contesto di vita ordinaria illuminata dai valori profondamente umani e dunque profondamente cristiani che scontrandosi con le potenze del male può comportare anche la donazione della vita. Il proporre come martiri uomini per la giustizia diventa una realtà meno sorprendente di quanto si possa immaginare. Alle figure di santità vanno unite alcune figure di Martiri per la Giustizia,cioè alcune personalità delle istituzioni che hanno versato il loro sangue,per mano mafiosa, per l’affermazione della legalità e della giustizia e del senso dello stato. La giustizia intesa come regolazione storica del rapporto tra soggetti è misurata dalla verità antropologica nel senso che il rapporto tra le persone sarà tanto più vero quanto più sarà vera la com-prensione del mistero della persona umana e,di conseguenza,la comprensione del suo rapporto con l’alterità. Ricordiamo tre di loro che hanno operato e/o che sono morti nel territorio dell’Arcidiocesi di Monreale:Il tenente colonnello dei Carabinieri Giuseppe Russo,il capitano dei Carabinieri Emanuele Basile e il suo successore il capitano Mario D’Aleo che hanno comandato entrambi la compagnia di Monreale. Giuseppe Russo era il comandante del gruppo investigativo di Palermo. La sera del 20 agosto del 1977 dai boschi di Ficuzza s’irradia un bel fresco fino alle masserie, alle abitazioni di campagna trasformate dai palermitani in case di villeggiatura. Il tenente colonnello dei carabinieri Russo passeggia assieme a un amico, l’insegnante Costa. Russo è in borghese, non è armato. E’ la memoria storica dell’Arma, un nemico irriducibile dei mafiosi, ma sta sulle croste a tanti. I suoi detrattori l’accusano di aver bazzicato troppe situazioni opache, di essere stato bene addentro al golpe Borghese. Russo attraversa un periodo controverso: ha rotto con alcuni ufficiali superiori, reputa la propria carriera bloccata, si è messo a riposo per malattia, medita le dimissioni. Ha confidato agli intimi che si occuperà di appalti, che farà l’imprenditore. I killer si materializzano all’improvviso. Sparano sfruttando la luce di un lampione stradale. Russo e Costa muoiono all’istante. Gli assassini fuggono in auto. Li guida Riina. Con lui suo cognato Bagarella e due giova-nissimi al battesimo dei fuoco, Giovanni Brusca, il figlio di Bemardo, e Giuseppe Greco detto Pino “scarpuzzedda” . Emanuele Basile, comandava la compagnia dei carabinieri di Monreale. Le mosse del capitano Basile, inquietano le cosche. Basile ha ereditato le carte rinvenute da Giuliano nel covo di via Pecori Giraldi. Sono una miniera, si integrano con le sue indagini sulla mafia di provincia. Basile ha individuato l’intera struttura della «famiglia» di Altofonte. In febbraio ha denunciato Francesco Di Carlo e i suoi fratelli, ha capito il loro legame con Riina, le intese con Michele Greco, con Ciccio Madonia. Da Altofonte le indagini del capitano si sono estese a San Giuseppe Jato, ai movimenti dei Brusca, dei quali intuisce la vicinanza ai corleonesi. Per questa strada anche Basile arriva a Siino, l’effervescente personaggio su cui puntava Russo per catturare Provenzano o Riina. L’ufficiale indaga a lungo sulla Litomix, l’immancabile società di calcestruzzi proprietà di “Bronson”», ma della quale è socio occulto Giovanni Brusca. Il calcestruzzo continua a essere la grande passione di Cosa Nostra e Basile comprende che queste società sono importanti perché consentono d’inserirsi nella costruzione dei palazzi e negli appalti pubblici. Il 15 aprile il capitano vola a Bologna, uno dei due ma-gistrati che lo accompagna è Paolo Borsellino, per il quale questa inchiesta costituisce il suo “master”» in mafia. Basile e Borsellino vanno a interrogare due vecchie conoscenze al soggiorno obbligato: lo zio di Riina, Giacomo, e il cugino di Leggio, Giuseppe. I due compaiono con Bagarella, i Di Carlo, Nino Marchese e Gioè in una foto rinvenuta in via Pecori Giraldi. Vi compare pure una persona che nessuno sa riconoscere.
Basile e Borsellino vogliono sapere chi è. Riina e Leggio tengono fede alla loro mafiosità: sostengono che erano di passaggio, che sono capitati in quella foto per combinazione, che niente sanno di quel distinto signore con i capelli brizzolati. Quest’altro «maschio bianco non identificato» è Lorenzo Nuvoletta, il boss della camorra più impegnato sul fronte dell’eroina. Giacomo Riina e Giuseppe Leggio finiscono in gattabuia, ma le domande del capitano fanno intendere a Riina e ai suoi compari che Basile può infliggere una seconda battuta d’arresto al consorzio della droga. Per l’ufficiale dei carabinieri viene deciso lo stesso trattamento riservato a Russo, Giuliano,Terranova. La sera del 4 maggio del 1980 è festa a Monreale per la ricorrenza del Crocifisso. Basile partecipa con la famiglia al ricevimento in comune, poi si avvia verso la caserma con la moglie e la figlioletta in braccio L’affrontano in tre, fanno fuoco: Basile stramazza, la bimba è illesa, la moglie si getta sul corpo del marito per fargli da scudo, si salva per miracolo. Dopo poche ore, le battute dei carabinieri portano all’arresto di tre giovani nelle campagne di Monreale: Giuseppe Madonna, Armando Bonanno,Vincenzo Puccio. Il posto di Basile viene preso dal capitano Mario D’Aleo che riesce ad individuare l’organigramma del nuovo vertice corleonese. La sera del 13 Giugno del 1983 viene ucciso a Palermo in via Scobar insieme all’appuntato Giuseppe Bommarito e al carabiniere Pietro Morici. Lo squadrone della morte è composto da Raffaele Ganci, da suo figlio Domenico, da suo nipote Paolo Anselmo, da Salvatore Biondino e da Michelangelo La Barbera.(Tratto da: Alfio Caruso, Da cosa Nasce Cosa Storia della mafia dal 1943 ad oggi, Longanesi e C.). Tertulliano scrisse che “il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani” parafrasando questa frase possiamo affermare che il sangue dei martiri della giustizia è seme di una nuova società.
PARTE II
GESÙ E MAMMONA
L’atteggiamento di Gesù di fronte al denaro è indubbiamente relativo all’intenzione con la quale questo è visto dall’uomo. Mammona è una parola aramaica che significa “beni” ed indica non solamente beni in denaro. Il termine “Mammona” è utilizzato da Gesù per indicare la personificazione della ricchezza male guadagnata. Certamente il Rabbi di Nazareth esprime, nei suoi insegnamenti e nei suoi “detti” un giudizio severo criticando la forza seduttrice della ricchezza, dichiarandola un rischio nei riguardi della scelta per la salvezza. E allora si trovano sulle sue labbra parole dure e severe come: “Quanto dif-ficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel Regno di Dio” (Mc 10,23). Addi-rittura nel Vangelo secondo Luca troviamo una frase ancora più dirompente di Gesù”Ma guai a voi, ricchi, perché avete gia la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete (Lc. 6,24-25). Eppure questo Gesù che chiama con disprezzo la ricchezza con l’epiteto di “mammona”, non evita, durante la sua vita pubblica, i ricchi, né si mostra fortemente ribelle nei loro confronti. Appare nel suo comportamento un diverso atteggiamento: giudizio negativo della ricchezza, fino a chiamarla “iniqua ricchezza” (Lc 16,9), che è però associato ad un dialogo con i ricchi ed i benestanti. Un rapporto che lui molte volte cerca di instaurare, anche nel caso in cui alcuni di questi ricchi non incrociano la propria strada con lui. Nel cuore di Gesù c’è la suprema esigenza di “salvare tutti”: ricchi e po-veri, potenti e deboli. Anche se i deboli ed i poveri hanno un posto privilegiato nel suo cuore. L’incontro con Zaccheo, a Gerico, è emblematico di questo atteggiamento di Gesù che al di sopra di tutto pone l’uomo nella sua totalità. Entrato in Gerico, Gesù attra-versava la città. Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «E` andato ad alloggiare da un peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch’egli è figlio di Abramo; il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto» (Lc 19, 1-10). Poco prima Luca aveva “riportato l’episodio del «notabile» ricco che proprio perché attaccato alle sue ricchezze si era rifiutato di seguire Gesù (Lc 18, 18-23), e le dure parole di commento da parte del Maestro «E’ più facile per un cammello passare per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel Regno di Dio»(Lc 18,25). Tutto questo contribuiva a creare un caso “difficile” sia per Zaccheo che per Gesù il quale, ovviamente, dopo quelle parole non poteva mostrarsi troppo indulgente verso un ricco. Eppure il «difficile», anzi «l’impossibile per gli uomini» (Lc 8,27), avviene! Cristo non esclude nessuno dal suo regno che è offerto a tutti, ricchi e poveri, a condizione di «cambiare» il proprio cuore, cioè di «convertirsi». Gesù non condanna la ricchezza per sé stessa ma perché essa tende a diventare un idolo, che viene adorato e servito al posto di Dio (Mt 6,24), assorbe energie fisiche e spirituali, rende sordi al richiamo del Regno e alle necessità dei fratelli ( Luca 16,19-31). Chiede la rinuncia ai beni terreni soprattutto come atto d’amore verso i fratelli bisognosi. Per Gesù la ricchezza che non viene in alcun modo messa al servizio degli altri è «iniqua» (Lc16,9). Segno di peccato. Insomma il discorso sulla ricchezza permette a Gesù di sottolineare anche i riflessi di bontà sociale richiesti dalla conversione al Vangelo.
Tra “Dio e mammona” chi scegliere?
Non fatevi tesori sulla terra, ma in cielo
Accade a volte di leggere o ascoltare insegnamenti riguardo al diritto che avremmo ri-cevuto in Cristo di ottenere ricchezze e prosperità anche quaggiù sulla terra. Secondo questi insegnamenti, essendo diventati figli di Colui al quale appartengono tutte le cose, non dovremmo rassegnarci più a vivere come persone di modeste condizioni, perché una tale vita sarebbe segno di una fede incerta e di un rapporto ipocrita con il Padre celeste, ma dovremmo piuttosto esercitare il nostro diritto di figli ed ereditare le benedizioni materiali preparate per noi già su questa terra. Chi è povero o malato dovrebbe ravvedersi, e chiedere perdono per la sua poca fede. Per essere buoni cristiani bisogne-rebbe quindi essere il più possibile attivi e produttivi, occupare sempre i primi posti nella società e suscitare così negli altri il desiderio di diventare come noi.
È vero: Abramo, Isacco e Giacobbe sono stati uomini molto ricchi. Dio li ha benedetti anche visibilmente e hanno avuto grande abbondanza di beni materiali. Anche Davide “morì in prospera vecchiaia, sazio di giorni, di ricchezze e di gloria” (1Cronache 29:28). Per non parlare di suo figlio Salomone, che fu il più grande di tutti i re della terra non solo per saggezza ma anche per le sue ricchezze (1Re 10:23 e 2Cronache 9:22). Ma a-vevano essi forse cercato le ricchezze e la prosperità materiale? O non, piuttosto, in primo luogo “il regno di Dio e la sua giustizia”, ottenendo poi anche quello che non a-vevano chiesto? (cfr. in particolare 2Cronache 1:11).
Anche Giobbe era molto ricco, ma dopo aver perso tutti i suoi molti averi, adorò il Si-gnore e disse: “nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo alla terra; il Signore ha dato, il Signore ha tolto; sia benedetto il nome del Signore”. (Giobbe 1:21). Queste parole riecheggiano in quelle di Paolo a Timoteo: “La pietà, con animo contento del proprio stato, è un grande guadagno. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo, e neppure possiamo portarne via nulla; (…) l’amore del denaro è
radice di ogni specie di mali; e alcuni che vi si sono dati, si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori.” (1Timoteo 6:6-7 e 10).
Le ricchezze materiali non sono certo un male in sé, ma il desiderio delle ricchezze è certamente un desiderio sbagliato, perché, in sé, le ricchezze, non sono nemmeno un bene e se le consideriamo un bene in sé, automaticamente le trasformiamo in un male, dato che ci mettiamo il nostro cuore facendone il nostro tesoro e diventando così paurosi e vulnerabili, perché ci siamo fatti un tesoro in terra dove le cose si consumano e possono venire rubate (Matteo 6:19-21 e Luca 12:33-34).
Il benessere e le ricchezze terrene, in sé, non sono né bene, né male. Lo diventano a se-conda di come le vediamo e di come le viviamo. Possono essere uno strumento di con-solazione e una ragione di ringraziamento e di lode, ma possono anche diventare un pa-drone duro, che regna su di noi invece di Dio. Gesù ci avverte dicendoci chiaramente: “voi non potete servire Dio e Mammona” (Matteo 6:24 e Luca 16:13;).
Effettivamente, il vangelo del regno di Dio è predicato ai poveri (Matteo 11:5 e Luca 7:22). Per questo il Signore ha detto: “Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli” (Matteo 5:3). Anche Abramo e Giobbe erano poveri, in spirito. Perché non confidavano nelle ricchezze, ma in Dio, loro redentore. E per questo avevano vita e co-raggio. Difatti, mentre l’empio si innalza pieno d’orgoglio e cade, “il giusto vivrà per la sua fede” (Abacuc 2:4). Così, è anche scritto: “l’empio fugge senza che nessuno lo per-seguiti, ma il giusto se ne sta sicuro come un leone.” (Proverbi 28:1), perché chi confida nelle ricchezze, teme di perderle; mentre chi sa di non avere nulla in questa terra (e di non avere quindi nulla da perdere), può avere il coraggio di mettere a rischio anche quello che possiede pur di essere fedele al Signore Gesù e poter entrare nel regno dei cieli.
Come per controbilanciare la nostra naturale tendenza a desiderare il benessere materiale, l’influenza sociale e le comodità, e a dare perciò un valore sproporzionato ai soldi con cui li si può acquistare (il pensiero, cioè, che “quanti più soldi abbiamo, tanto meglio per noi”), due insegnamenti contenuti nei Vangeli mettono in luce il rischio che in verità si corre ad avere molti beni e, rispettivamente, il vantaggio di averne pochi.
Il primo di questi insegnamenti è contenuto nelle parole che Gesù disse ai suoi discepoli dopo che se ne fu andato quel ricco a cui aveva detto “Va’, vendi tutto ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi” (Mc 10:21). Quel ricco se ne era andato tutto rattristato perché aveva molti beni e darli via tutti era un’impresa superiore alle sue forze. Allora Gesù aveva detto: “quanto è difficile per quelli che confidano nelle ricchezze entrare nel regno di Dio!” (Mc 10:24)
L’esempio opposto è quello della povera vedova che aveva dato in offerta tutti i pochi spiccioli che possedeva (Marco 12:42 e Luca 21:2). Per lei quei due spiccioli erano tutto quello che aveva, ma siccome agli occhi umani quel “tutto” era poca cosa, era riuscita a darlo volentieri e dandolo aveva offerto di più, agli occhi di Dio, di quello che con i loro ricchi doni avevano offerto i più ricchi di Israele che avevano dato del loro superfluo.
In conclusione, la domanda è: se avendo di più riusciamo a dare di meno (davanti a Dio, che non considera quanto diamo, ma piuttosto quanto tratteniamo per noi), ci conviene davvero affaticarci tanto per potere guadagnare e offrire di più? Non facciamo piuttosto meglio a liberarci da tutto ciò che rischia di diventare causa di affanno e di preoccupa-zione e scegliere, come Maria di Betania, la parte buona che non ci sarà tolta e che con-siste in quel tesoro celeste e quella fonte di benedizione spirituale che è la comunione con il nostro Signore Gesù?
PARTE III
IL PERDONO
LE PARABOLE DELLA MISERICORDIA
Non possiamo fare un cammino di ricerca del Gesù storico senza porre l’attenzione su quello che gli studiosi d’oggi considerano un elemento essenziale della missione del Maestro di Nazareth: il carattere sapienziale del suo insegnamento. Ed è proprio in que-sto ambito che poniamo l’accento, considerando in particolare le parabole della miseri-cordia. In questa nostra ricerca vedremo innanzitutto il messaggio di Gesù contenuto in queste parabole. Poi cercheremo di verificare la loro storicità e, infine, trarremo le somme verificando ciò che queste parabole ci dicono di Gesù e della sua identità. Le parabole in questione sono: la pecorella smarrita, la dramma ritrovata ed il figliuol prodigo. Ma prima di prestare attenzione a questi testi, è importante inquadrare la cornice storico-sociale, cioè il tipo di uditorio a cui è rivolto il messaggio delle tre parabole di Luca. E’ la folla di Galilea, quella composta da ogni tipo di persone, soprattutto la gente semplice ed umile. C’è anche l’elite della società ebraica: gli scribi ed i farisei. Infine ci sono, in mezzo agli altri, due categorie di persone associate sempre nella condanna del mondo religioso: i pubblicani ed i peccatori: “Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano: «Costui riceve i peccatori e mangia con loro». Allora egli disse loro questa parabola: «Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va dietro a quella perduta, finché non la ritrova? Ritrovatala, se la mette in spalla tutto contento, va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta. Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione. O quale donna, se ha dieci dracme e ne perde una, non accende la lucerna e spazza la casa e cerca attentamente finché non la ritrova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, dicendo: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dracma che avevo perduta. Così, vi dico, c’è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte»”(Lc 15,1-10). Un pastore s’avvede di aver lasciato per strada una delle cento pecore. E allora lascia le 99 per andare alla ricerca della pecorella smarrita. E una volta ritrovata corre dai suoi amici per dare la buona notizia. Al termine di questo brano Gesù conclude: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta. Così, vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione”. La seconda parabola narra della donna che custodisce gelosamente il suo patrimonio di denaro (dieci dracme). S’avvede di aver smarrito una dramma e subito si mette a cercarla, rovistando per tutta la casa. E quando la trova invita le amiche a rallegrarsi con lei. Anche qui c’è il commento conclusivo di Gesù: Così, vi dico, c’è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte».(Lc 15,1-10). Ed ecco la terza parabola, la più rappresentativa delle tre: “Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l’anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: E’ tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si arrabbiò, e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo. Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato»”(Lc 15,12-28). Mentre nelle parabole precedenti i protagonisti sono il buon pastore e la donna di casa, qui, invece, è il Padre. Appare chiaro come Gesù si rivolga ai due gruppi che sono presenti in questo momento della sua predicazione: i peccatori, che individua nel figlio perduto e poi ritrovato, ed i farisei che identifica nel primo figlio, quello che non ha abbandonato il Padre. Nell’insegnamento di Gesù, anche se il figlio è peccatore, il Padre non lo ha dimenticato e quando è ancora lontano il padre lo vede e commosso gli corre incontro, gli si getta al collo e lo bacia. Gesù identifica il fratello maggiore negli scribi e farisei, coloro cioè che si considerano fedeli alla Torah, eppure hanno smarrito il volto stesso di Dio e “al suo posto se ne hanno costruito uno senza volto e senza cuore, esattore scrupoloso, e, proprio per questo, impietoso di quanto gli deve ogni uomo. Un Dio simile rende atei gli uomini. Ma il Dio di Gesù è diverso: è vero Dio, cioè Padre”(Antonio Fanuli, Le parabole della misericordia, in Storia di Gesù, 3° vol. Ed. Rizzoli, 836). L’abbraccio del Padre significa, per il Figlio ritrovato, la restituzione dell’antica dignità perduta, la riammissione al posto d’onore della famiglia, l’intimità familiare. L’amore ed il perdono del Padre vuol dire proprio questo: l’amore di Dio non conosce confini, ma si china misericordioso sull’uomo e sull’uomo peccatore. E’ qui il cuore della rivelazione, il centro di quel messaggio di salvezza che Gesù annunzia, non solo agli scribi, ai farisei e ad ogni pio israelita; ma soprattutto ai pubblicani ed ai peccatori, alle meretrici ed a tutti coloro che si sentono “lontani” dallo sguardo Amoroso di Dio. Costatata, allora, la sublimità di questo messaggio, ci chiediamo ora se esso ha un suo fondamento storico e cosa ci dice a riguardo di Gesù. Due delle tre parabole della misericordia, la dramma ritrovata ed il figliuol prodigo, sono riportate solo nel vangelo di Luca, mentre quella della pecorella smarrita è menzionata, seppur con delle piccole variazioni, anche nel Vangelo di Matteo. E’ chiaro che in questi racconti c’è un primo fondamento storico evidenziato dal fatto che il messaggio annunciato, quello di un Dio che va in cerca del peccatore, seppur presente nell’Antico Testamento ( Sal 103, 8-18; 130,3-4; Ger 31,20; Ez 18,21-23; 33,11; Is 55,7 ed altri ancora) è estraneo all’ambiente giudaico del tempo di Gesù. Quindi abbiamo un primo indizio in quanto “si possono considerare come appartenenti a Gesù quelle parole o quei fatti che non si possono attribuire né al pensiero, né alle abitudini, né alle tendenze dell’ambiente ebraico”. Anzi nel mondo sociale e religioso degli ebrei i pubblicani “sono odiati dal popolo e considerati alla stessa stregua dei peccatori e delle prostitute (Cfr. pubblicano, in Dizionario enciclopedico della Bibbia e del mondo Biblico, Ed. Massimo, 616). C’è un’altra testimonianza a favore della storicità delle parabole della misericordia, specialmente di quella della pecorella smarrita. La testimonianza proviene da una fonte molto considerata dagli studiosi contemporanei: il Vangelo apocrifo di Tommaso, una collezione di detti sapienziali di Gesù, un testo molto antico giunto a noi in copto ma, originariamente di lingua siriaca. Secondo Pius-Ramon Tragan, l’origine della raccolta di lógia, detti di Gesù, contenuta in questo Vangelo va ricercata nella predicazione degli itineranti galilei, coloro cioè che iniziarono a trasmettere l’insegnamento del Nazareno dopo la sua scomparsa dall’area geografica in cui egli era ben conosciuto (Pius-Ramon Tragan, La preistoria dei vangeli, tradizione cristiana primitiva. Ed. Servitium, 172). Ed è proprio il Vangelo di Tommaso a contenere tra le altre parabole, quella della pecorella smarrita. Non solo, ma anche in un altro testo antico apocrifo, chiamato il Vangelo della verità, troviamo presente la medesima parabola della pecorella smarrita (Cfr. Emilio Rasco, Evoluzione nella tradizione: un esempio, in Storia di Gesù, vol. 3, Ed. Rizzoli, 832).Quindi, a parte i limiti, per due parabole, della sola attestazione di Luca, controbilanciati peraltro dallo spirito di ricerca storica indicato dallo stesso evangelista quando nel prologo sostiene chiaramente di aver fatto ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi (Lc 1,3), possiamo ben pensare che queste parabole della misericordia abbiano un solido fondamento storico, comprovato soprattutto dal fatto che la premura di Gesù verso i peccatori è un atteggiamento originale del Gesù storico, specialmente nella sua qualità di Rabbi, di Maestro. Inoltre, il fatto che la parabola della pecorella smarrita sia attestata da Matteo (Mt 18,12-14) e Luca (Lc 15, 4-7), dimostra che quasi certamente i due vangeli sono partiti da una fonte comune alla quale, più tardi, faranno riferimento il Vangelo apocrifo di Tommaso ed il Vangelo della verità (Cfr. Emilio Rasco, Evoluzione nella tradizione: un esempio, in Storia di Gesù, vol. 3, Ed. Rizzoli, 832). Una fonte ovviamente più antica dei due vangeli. E allora, cosa ci dicono del Gesù storico, le parabole della misericordia? Cosa ci rivelano della sua identità? Un dato è sicuro al cento per cento. Il Gesù storico ha il volto misericordioso verso i piccoli (Mt 18,12-14) e verso i peccatori(Lc 15,4-7). Una premura che dimostra l’originalità di un sentimento sublime e paterno che invita i peccatori alla conversione perché anche loro sono invitati al banchetto del Regno.
San Silvano l’atonita e l’amore per i nemici
La maniera d’intedere la giustizia, per gli uomini, è molto diversa da quella di Dio. Ri-scontriamo questo già nelle fonti scritturistiche. La Bibbia, comunque, rimane lettera morta fintanto che non si riscontra la testimonianza di chi l’ha vissuta, e verificata. San Silvano l’atonita è un santo che ha avuto sicuramente un rapporto intimo con Dio ed è a partire da qui che le sue parole hanno acquistato autorevolezza. In questo passo si esa-mina l’amore cristiano. Il cristiano non ama i nemici perché deve semplicemente farlo ma perché ne è abilitato. Ciò avviene quando l’uomo entra veramente in contatto con Dio. Il contatto comporta la conoscenza. Se ciò non avviene può succedere che anche un teologo e un monaco parlino di Dio ma non lo vivano. Ne consegue che costoro saranno ben lungi dall’amare i propri nemici e saranno difficilmente delle guide sicure. Ciò che da verità, vita e forza al cristianesimo non sono dunque le buone intenzioni o i moralistici propositi ma l’inspiegabile mutamento della vita. Solo con ciò è possibile sostenere il paradossale e quanto il mondo giudica follia.
Colui che non ama i suoi nemici non può conoscere il Signore né la dolcezza del Santo Spirito.
Oh, quant’è immensa la misericordia di Dio per noi!
Molti uomini ricchi e potenti donerebbero qualcosa dei loro beni pur di poter vedere il Signore e la sua purissima Madre; tuttavia non è davanti alla ricchezza che Dio si mani-festa ma davanti ad un’anima umile.
Perchè utilizzare dei denari? San Spiridione transformò un serpente in oro; e noi non abbiamo bisogno d’altro che del Signore: in lui sta la pienezza della vita.
Se il Signore non ci ha concesso di conoscere il segreto di numerose cose di questo mondo è perché non ne abbiamo veramente bisogno. Non possiamo conoscere l’intera creazione con la nostra sola intelligenza.
Ma il Creatore del Cielo e della terra e di tutto ciò che esiste ci accorda di conoscerla attraverso lo Spirito Santo. Nello stesso Spirito conosciamo la Madre di Dio, gli angeli e i santi e constatiamo che Egli brucia d’amore per loro.
Tuttavia colui che non ama i suoi nemici non può conoscere il Signore né la dolcezza dello Spirito Santo.
Lo Spirito Santo c’insegna ad amare i nemici fino ad averne compassione come se fossero figli nostri.
Esistono uomini che augurano la dannazione e i tormenti nel fuoco infernale ai loro ne-mici o ai nemici della Chiesa. Costoro pensano in tal modo perché non hanno imparato dallo Spirito Santo ad amare Dio. Chi lo ha fatto versa lacrime per il mondo intero. Tu dici: “È un criminale che bruci, dunque, nel fuoco dell”nferno”. Ma io ti domando: “Se Dio ti desse un bel posto nel Paradiso e, da là, tu vedessi nel fuoco colui al quale hai au-gurato dei tormenti, non avresti pietà di lui, chiunque egli sia, fosse pure un nemico della Chiesa?”. Oppure avresti un cuore di ferro? Ma in Paradiso non c’è bisogno di ferro. Là si ha bisogno di umiltà e di amore di Cristo che ha compassione per tutti.
Colui che non ama i suoi nemici non ha la grazia di Dio. (p. 259)
[…]
Colui che biasima gli uomini malvagi e non prega per loro non conoscerà mai la grazia di Dio
Parecchi santi martiri hanno conosciuto il Signore e il suo aiuto tra le prove. Parecchi monaci hanno compiuto grandi slanci ascetici e sopportato penosi oneri per amore del Signore; pure loro hanno conosciuto il Signore e hanno lottato per vincere le passioni che li tormentavano. Essi pregavano per tutto il mondo e la grazia divina insegnava loro ad amare i nemici. Colui che non li ama non può conoscere il Signore che è morto sulla Croce per i propri nemici. Egli stesso ci ha lasciato un esempio da seguire e ci ha dato il comandamento d’amare i nostri nemici.
Il Signore è amore. Ci ha comandato di amarci gli uni gli altri e d’amare pure i nemici. Il Santo Spirito ci rivela l’amore.
L’anima che non ha mai conosciuto il Santo Spirito non comprende come si possa amare i nemici e non l’accetta. Ma il Signore ha compassione per tutti gli uomini e chiunque voglia essere con il Signore deve amare i suoi nemici.
Chi ha conosciuto il Signore nello Spirito Santo diviene simile a Cristo, come dice San Giovanni il Teologo: “Saremo simili a lui, poiché lo vedremo come egli è” e noi vedremo la sua Gloria.
Tu mi dirai che sono numerosi coloro che soffrono per ogni sorta di male e patiscono per la malizia degli uomini. Ma io ti dico di umiliarti sotto la potente mano di Dio e la
Grazia t’istruirà e, tu stesso, vorrai soffrire per amore del Signore. Ecco cosa ti rivelerà lo Spirito Santo che noi conosciamo nella Chiesa.
Ma colui che biasima gli uomini malvagi e non prega per loro non conoscerà mai la grazia di Dio. (p. 326)
(Tratto da Starets Silouane : Moine du Mont Athos. Vie – Doctrine – Écrits. Éditions Présence, Sisteron, 1995)
PARTE IV
IL CONCETTO DI USURA NEL TEMPO
Poche parole hanno assunto, nel corso dei secoli, significati così diversi, per non dire antitetici, come il termine “usura” .L’etimo latino dei vocabolo deriva in ultima istanza dal verbo “utor” (usare).
Infatti, in origine, con il termine usura si designava il frutto del denaro dato in prestito, senza che la parola implicasse significati indegni o moralmente riprovevoli. In seguito, col diffondersi dei fenomeno della crescente esosità dei prestatori di denaro, l’uso della parola fu ristretto ad indicare quei prestiti che comportavano una eccessiva gravosità dell’impegno finanziario dei debitore.
Con il termine usura ci si riferisce alla riscossione da parte di chi presta denaro in ope-razioni che non debbono dar luogo ad interesse: per questo motivo usura e interesse non sono sinonimi perché l’usura ha luogo laddove non vi è produzione o trasformazione materiale di beni concreti.
Da sempre dunque, il problema della liceità dell’usura, di denaro o altro oggetto fungibile, ha continuamente intrigato filosofi, teologi, moralisti e perfino poeti: tra i pensatori nemici dell’usura ricordiamo Platone, Aristotele, San Tommaso d’Aquino e Karl Marx.
In ogni tempo, la questione dell’usura ha impegnato a fondo le menti dei legislatori dì vari Paesi: per esempio, già nel II millennio a.C. nel codice di Hammurabi, composto di quasi trecento norme giuridiche, figura anche il tema dell’interesse.
Nella Grecia antica, filosofi e pensatori di grande rilievo, quali Platone e Aristotele, non si discostarono troppo da una valutazione negativa del carattere dell’usura, anche se nella società in cui vivevano la proprietà privata della terra, un alto grado di divisione dei lavoro, il commercio (soprattutto marittimo) e l’uso della moneta erano fenomeni già esistenti.Ma la vera e propria trattazione dei concetto di usura avviene nella Bibbia, nel Deuterenomio, dove compaiono precetti contro chi pratica l’usura nei confronti del proprio fratello. Il Deuterenomio formò uno dei cardini dell’etica basata sulla fratellanza di sangue delle comunità ebraiche: in esso si statuiva la solidarietà dei mishpaha (clan) e l’esclusione dei nokri (lo straniero) dai privilegi e dagli obblighi della comunità; inoltre proibiva all’ebreo di ritrarre qualunque neshek (interesse) dal proprio fratello, rendendolo lecito, invece, nei confronti dei nokri.
Per tutto il Medioevo, qualsiasi forma di pagamento di interessi su somme di denaro date e ricevute in prestito, fu considerata usuraia, e pertanto, condannata dalla Chiesa come peccaminosa e vietata dalle leggi dello Stato come reato; quanto alla possibilità ad esercitare l’usura nei confronti dello straniero, questo avveniva da parte ebraica nei con-fronti dei cristiani, ma non nel senso inverso, poiché i cristiani medievali non hanno considerato gli ebrei come stranieri.
Il filosofo e teologo che ebbe maggiore impatto sul pensiero etico-economico nella Chiesa nel Medioevo, e che esercitò l’enorme influsso sui pensatori religiosi e laici che lo seguirono, fu San Tommaso d’Aquino (1225-1274) che considerava ogni forma di usura da condannare come innaturale e quindi peccaminosa.
Nelle sue riflessioni sull’usura San Tommaso attribuisce al peccato dell’avarizia la causa di tale pratica; mentre la società civile e le leggi positive non condannano l’usura per opportunità politiche ed economiche, le leggi ecclesiastiche non possono tollerare nes-suna forma permissiva verso le attività usuraie.
Con l’evoluzione dei traffici e con lo sviluppo di una nuova società mercantile di tipo capitalistico, l’accezione del termine usura venne restringendosi, fino a indicare la ri-chiesta e la corresponsione di tassi esorbitanti applicati ai prestiti in denaro, laddove un tasso moderato viene solitamente chiamato interesse.
Con lo sviluppo delle tecniche produttive, con l’intensificarsi delle comunicazioni e dei commerci, il panorama dell’Europa mutò profondamente: si sviluppò sempre di più un’economia di tipo mercantile in cui anche il denaro diventava una merce come le altre, una merce che aveva prezzo, un prezzo costituito dal tasso di interesse.
Al di là di tutte le proibizioni religiose o civili il prestito a interesse diventava sempre più un elemento insostituibile della vita economica; non a caso nacquero a Firenze, Ve-nezia, Milano, Siena i primi grandi banchieri, specializzatisi nel fornire i capitali a com-pagnie mercantili e agli stessi sovrani in cambio di interessi o di appalti vantaggiosi.
Nel corso dei XV secolo si assiste in Italia alla nascita di un nuovo istituto di credito al consumo, il cosiddetto “Monte di Pietà”. La locuzione, che traduce il latino “Mons Pietatis” , indica “monte”, nel senso economico di cumulo, fondo di valute, adibito a beneficio dei bisognosi, per fini di misericordia; in sostanza, ci si sforza di applicare un rimedio all’usura, di trovarne una nuova fonte di difesa in grado di garantire gli strati più deboli della società.
Ai primi dei Cinquecento la chiesa cattolica per la prima volta si pronunciava con un certo possibilismo sul problema dei prestiti di denaro a interesse. Il Pontefice Leone X pur confermando la condanna generale dell’usura, autorizzava il pagamento di piccole somme per le spese di gestione dei Monti di Pietà.
Negli stessi decenni anche Martin Lutero (1483-1546), prende di mira l’ usura, attac-cando tale pratica con la stessa risolutezza dei padri della Chiesa e dei papi. Anzi nei suoi due Sermoni sull’usura dei 1519 e dei 1520, Lutero non solo ribadisce che il prestito di denaro deve essere gratuito, ma, condanna anche quel pagamento di un compenso previsto e ammesso dal diritto canonico.
Come se non bastasse, la messa in scena dei Mercante di Venezia di Shakespeare ebbe in Inghilterra l’effetto di ravvivare ulteriormente le dispute dottrinali sull’usura: al nucleo ideale della commedia, il rapporto dell’uomo col denaro, la critica rivolse l’attenzione al tema dell’usura che si presentava come un importante problema sia economico c e morale.La discussione sulla liceità o meno dell’interesse finanziario continuò all’inìzio dei secolo XVII. I mercantilisti, pur credendo nella produttività della moneta, erano in favore dell’accumulazione di capitale monetario, e perciò contrari all’esazione di interessi eccessivi. Nel 1625 Francesco Bacone, nel noto saggio sull’usura Of Usuríe si pronuncia in favore dell’usura, fenomeno che il filosofo considera inevitabile e per questo da regolamentare attraverso le leggi; il completo rovesciamento della posizione aristotelica sull’usura avviene però nel Settecento a opera di uomini ‘moderni’ il cui pensiero è fortemente condizionato dalle nuove idee dell’Illuminismo: questi affrontarono problemi dell’economia politica e dei commercio comprese le questioni relative all’interesse finanziario.
Verso la fine del Settecento, la Rivoluzione francese segna la fine di un’epoca, tanto in politica quanto in economia e l’Assemblea Nazionale dei 1789, riconosciuta dal re Luigi XVI e proclamatasi in Costituente, deliberò la soppressione dei regime feudale e la di-chiarazione dei diritti dell’uomo e dei cittadino; fra le varie libertà proclamate, c’era an-che la libertà dei commercio e dei credito.
Ai primi dell’Ottocento, il codice napoleonico riconosceva l’autonomia dell’iniziativa privata in campo economico, garantendo il diritto di proprietà e concedendo, all’articolo 1905, la facoltà di “stipulare interessi per il semplice prestito di denaro, di derrate o di altra cosa mobile”.
Anche la Chiesa cattolica, da allora in poi, di norma non avrebbe più condannato l’interesse finanziario in genere, ma si sarebbe limitata alla sola condanna dei tassi usu-rari.
Il fenomeno dell’usura è andato di recente dilagando in Italia in modo preoccupante a tal punto di avviare una lotta efficace contro l’usura significa colpire il più delle volte gli interessi della Mafia e della criminalità organizzata.
L’usura, che per i cristiani è un peccato multiforme e molteplice, una specie di idra a sette teste, come fenomeno criminale è per la società civile un reato tentacolare, una sorta di piovra dalle mille connessioni, essendo collegata all’estorsione, al riciclaggio dei denaro sporco, alla speculazione finanziaria ed edilizia, al narco-traffico, alla prostituzione.
Anche coloro che si macchiano di questo reato appartengono alle più svariate classi so-ciali e talora rivestono le qualifiche professionali più insospettabili chiamati non a caso “cravattai” o “strozzini”.
Secondo un’ indagine del CENSIS [1] il ricorso all’usura si intensifica nei periodi di re-cessione economica quando diventa più arduo accedere alle fonti ufficiali dei credito. Per molti aspetti il ricorso all’usura appare una strada obbligata per quanti
non riescono ad ottenere credito dalle banche, a causa delle eccessive e onerose garanzie richieste nonché dei lunghi tempi di istruttoria per accedere al credito.
La suddetta indagine del CENSIS ha inoltre riconosciuto quattro categorie di usurai, e cioè: l’usuraio parassita, una sorta di dilettante dell’usura, che si contenta di un interesse non troppo esoso; l’usuraio semiprofessionista, che, per così dire, esercita l’usura come “secondo lavoro”, per impiegare proficuamente quella parte dei suo reddito che nasconde al fisco; il gruppo usurario di quartiere, un’organizzazione che opera quasi scientifi-camente specializzandosi per settori d’attività; l’usuraio investitore, collegato con la criminalità organizzata e che dispone di ingenti capitali e di società insospettabili.
Nel mercato “nero” dei credito si possono distinguere tre forme fondamentali dei pre-stito ad usura: il cosiddetto prestito “a strozzo”; il mercato illegale dei titoli; il prestito “esoso.” Il primo tipo d’usura, quello tradizionale, si può suddividere in prestito a inte-resse, la forma più diffusa, e il prestito “a fermo”, appetibile per i commercianti o chiunque abbia bisogno immediato di liquidità per l’acquisto di grosse partite di merce sottocosto.
Il mercato illegale dei titoli consiste nella commercializzazione di assegni postdatati, le tratte, le cambiali. Esso è tanto diffuso, specie nei rapporti con i fornitori e i grossisti, che malgrado gli interessi elevati, molte volte non si ha neppure la consapevolezza che si tratti di varianti al prestito ad usura.
Il prestito “esoso” viene generalmente esercitato da società che svolgono un’opera di íntermediazione finanziaria e che prendono soldi dalle banche a tassi normali per riven-derli poi a tassi notevolmente più alti a coloro i quali non possono avvalersi dei canali ufficiali dei credito, come i soggetti con assegni protestati. Il triste fenomeno dell’usura sembra essere distribuito equamente in tutto il territorio nazionale, benché colpisca di preferenza le città rispetto alle campagne, e il Mezzogiorno piuttosto che il resto dei pa-ese.
Quanto al modo di considerare il fenomeno usurario un atteggiamento generale di severa condanna. Quanto alle misure e ai provvedimenti con i quali combatterla, è purtroppo invalso un diffuso pessimismo sulla praticabilità e l’utilità delle iniziative rivolte ad assistere le vittime dell’usura anche mediante l’istituzione di fondi per il risarcimento dei danni subiti.
Dell’usura come reato se ne occupa non solo il codice penale agli articoli 644 e 644 bis e da ultimo la legge 7 marzo 1996 n. 108, ma anche il codice civile italiano.
L’articolo 1815 recita: “Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispon-dere gli interessi al mutuante. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale”.
Alcune sentenze di Cassazione hanno stabilito che per l’ipotesi dei mutuo con interessi usurari ricorre solo quanto sussistano tutti gli elementi costitutivi dei reato d’usura, e cioè non solo l’esorbitanza degli interessi convenuti, ma anche lo stato di bisogno dei mutuatario, dei quale abbia approfittato il mutuante.
Stabilita la nullità degli interessi usurari, resta aperto, come si diceva, il problema di determinare la misura degli interessi stessi. Per quanto riguarda l’usura nel diritto cano-nico dei nostro secolo, dobbiamo dire che il periodo repressivo della Chiesa contro l’usura ebbe fine con la bolla di Leone X, la quale apriva la strada ai prestiti dei Monti di Pietà; ma abbiamo anche notato come ancora nel tardo Settecento chi difendeva la liceità dell’interesse potesse incorrere nella condanna dei canonisti e nelle ire della Santa Inquisizione. Sino a tutto ]’Ottocento, la legislazione canonica rimase sostanzialmente fedele alla condanna dei prestito a interesse di denaro e cose fungibili.
Nel codex iuris canonici dei 1917 resta ferma la riprovazione dell’usura anche sul piano giuridico dal momento che tale comportamento sì pone come espressione di avarizia e di lesione dei comandamento cristiano fondamentale della carità .
La situazione è radicalmente cambiata con l’entrata in vigore dei codex iuris canonici dei 1983, con il quale il diritto canonico non si occupa più dell’usura come reato: l’esercizio dei prestito a interesse viene lasciato alla sfera della coscienza individuale, come questione d’ordine morale più che giuridico.
Nella codificazione canonica dei 1983 non esiste una normativa specifica riguardante l’usura e lo stesso termine scompare sia nella trattazione riguardante i beni temporali della Chiesa che nella parte penalistica dei nuovo codice.
[1] Rapporto finale, CENSIS, Roma, 1994, p.71
(Tratto da: Daniela Caponi,Tesi di Laurea su: Profili dell’usura e della polemica antie-braica nel Rinascimento. Il mercante di Venezia di Shakespeare).
Il Catechismo della Chiesa Cattolica,nella parte terza dedicata alla vita morale,pone l’accento,al capitolo primo,sulla dignità della persona umana che si radica nella creazione ad immagine e somiglianza di Dio e che deve tendere alla vocazione alla beatitudine divina. Con i suoi atti liberi la persona umana si conforma, o no, al bene promosso da Dio e attestato dalla coscienza morale. All’articolo terzo,il CCC,continua parlando della libertà dell’Uomo e della responsabilità derivante dalle sue scelte. La libertà è nell’uomo una forza di crescita e di maturazione nella verità e nella bontà…quanto più si fa il bene,continua il CCC,tanto più si diventa liberi. La libertà rende l’uomo responsabile dei suoi atti nella misura in cui sono volontari. All’articolo quarto il CCC pone la questione della moralità degli atti umani,per continuare con la moralità e le passioni e la formazione della coscienza morale la quale è un giudizio della ragione umana mediante la quale la persona umana riconosce la qualità morale di un atto concreto che sta per porre,sta compiendo o ha compiuto. L’articolo otto pone l’accento sul concetto di peccato e di misericordia. Il peccato è una mancanza contro la ragione,la verità,la libertà,la retta coscienza;è una trasgressione in ordine all’amore verso dio e verso il prossimo,a causa di un perverso attaccamento a certi beni (tra cui certamente il denaro).Esso ferisce la natura dell’uomo e attenta alla solidarietà umana. Il peccato trascina al peccato;con la ripetizione dei medesimi atti genera il vizio. Ne derivano inclinazioni perverse che ot-tenebrano la coscienza e alterano la concreta valutazione del bene e del male. Nel capitolo secondo della terza parte,il CCC,pone l’attenzione sulla comunità umana,sulla persona e sulla società. La persona umana ha bisogno della vita sociale. Il CCC richiama il principio di sussidiarietà. Da sottolineare i concetti di “bene comune” che comporta:il rispetto della persona in
quanto tale,il benessere sociale e lo sviluppo del gruppo stesso,la stabilità e la sicurezza di ogni ordine giusto. Al concetto di bene comune è connesso quello di “giustizia sociale” la quale non si può ottenere se non nel rispetto della dignità trascendente dell’uomo. Infine,la solidarietà umana.
Usura: spunti di riflessione pastorale
Massimo Rastrelli s.j.
La Chiesa è e vive per generare vita, vive nel generare vita abbondante, nel generare vita eterna, rapporti umani con Dio e rapporti divini tra gli uomini. L’usura si pone agli antipodi, perché genera morte, sia come fatto in sè che come cultura della morte. L’usura non deve considerarsi come un fatto peccaminoso fine a se stesso, perché in realtà causa molti altri misfatti ed è sintomo di coscienza totalmente pervertita. L’usura è certamente un furto e, come tale, una lesione della giustizia e una grave violazione dell’ordine morale. Riparare il peccato di usura, esercitata per anni e ai danni di molti, comporta la restituzione del maltolto e richiede un pentimento, non solo morale, ma anche finanziario ed economico. E questo crea problemi di non facile soluzione. Ma l’usura è anche un rapporto di grave e continuata oppressione alla libertà altrui, perché di fatto riduce la vittima a una vera condizione di schiavitù. In questo si pone in contraddizione diretta con l’iniziativa redentiva di Dio, tutta intesa invece a riscattare ed esaltare la dignità della persona. L’usura coinvolge la famiglia. Colui che accetta di ricorrere all’usuraio accetta di fatto che non solo lui, ma la sua famiglia e i figli debbano sottostare alle minacce della prepotenza dell’usuraio, che continua a minacciare violenza e la stessa morte in caso di ribellione, come la cronaca ampiamente dimostra.
Non basta! Questo terribile flagello induce anche guasti gravi e una grave degenerazione nell’assetto socio-economico della convivenza civile.
Dove l’usura si diffonde si produce inflazione, con conseguente generale impoverimento della nazione, che turba anche i rapporti internazionali.L’usura produce denaro, senza costi, con altissimo rendimento, senza produzione di beni o di servizi, con l’acquisto di potere sociale e politico, che si traduce anche in una frequente impunibilità, e tutto questo con crescente assoggettamento di persone e beni a proprio uso e consumo. E’ insomma la negazione del concetto di civiltà.Di fronte a deviazioni morali così devastanti, la Chiesa deve studiare bene il fenomeno ma soprattutto deve scendere in campo per una forte azione di contrasto, predicando e offrendo modelli di rapporti uma-ni completamente contrari, che diano prova di amore, gratuità, solidarietà, rispetto della persona e della sua divina dignità.Un’ispirazione atea, agnostica, o anche soltanto mate-rialisticamente sociale della vita, porta gli uomini ad aggregarsi in gruppi di potere, che a loro volta creano strutture di peccato. Se, invece, la Chiesa favorisce opposte e libere organizzazioni di onestà per il rispetto della dignità umana, per il servizio dei bisogni obiettivi, gli uomini potranno fare quella necessaria esperienza che li porterà a organiz-zarsi in forme aperte alla solidarietà secondo l’ispirazione del Vangelo. E anche questa la missione della Chiesa, il vivere coerentemente quella verità che va predicando.
Compito della politica e della scienza
Lo stesso ragionamento vale per la formulazione delle leggi. I politici non devono essere lasciati a se stessi. Se ciò avvenisse, produrrebbero facilmente leggi a servizio dei loro interessi particolari. L’esperienza mi ha fatto toccare con mano che un apporto di studio e di proposta sui contenuti delle leggi, lungi dall’essere ritenuto un’ingerenza indebita, è apprezzato e richiesto. Questo è tanto più necessario, quanto più, presso i laici, si oscura la luce cristiana della coscienza.E’ importante seguire l’andamento delle scienze finanziarie ed economiche, ma le teorie che rivendicavano la totale indipendenza della scienza economica dall’etica, oggi sempre più dimostrano i loro limiti. E’ necessario invece che la scienza economica abbia un preciso riferimento etico, perchè se si ama il profitto più dell’uomo non si è in grado di porsi a servizio dell’uomo, come è compito di ogni scienza.
PARTE V
ALCUNI BRANI PER UNA RIFLESSIONE CONDIVISA
OMELIA DI GIOVANNI PAOLO II,per la beatificazione di Pina Suriano
Loreto, 5 settembre 2004
1. “Quale uomo può conoscere il volere di Dio?” (Sap 9,13). La domanda, posta dal Libro della Sapienza, ha una risposta: solo il Figlio di Dio, fatto uomo per la nostra sal-vezza nel grembo verginale di Maria, può rivelarci il disegno di Dio. Solo Gesù Cristo sa qual è la via per “giungere alla sapienza del cuore” (Sal resp.) e ottenere pace e salvezza.
E qual è questa via? Ce l’ha detto Lui nel Vangelo di oggi: è la via della croce. Le sue parole sono chiare: “Chi non porta la propria croce e non viene dietro di me, non può essere mio discepolo” (Lc 14, 27).
“Portare la croce dietro a Gesù” significa essere disposti a qualsiasi sacrificio per amore suo. Significa non mettere niente e nessuno prima di lui, neanche le persone più care, neanche la propria vita.
2. Carissimi Fratelli e Sorelle, convenuti in questa “splendida vallata di Montorso”, come l’ha qualificata l’Arcivescovo Mons. Comastri, che ringrazio di cuore per le calorose parole rivoltemi. Saluto, con lui, i Cardinali, gli Arcivescovi e i Vescovi presenti; saluto i sacerdoti, i religiosi, le religiose, le persone consacrate; e soprattutto saluto voi giovani, appartenenti all’Azione Cattolica, che, guidati dall’Assistente generale Mons. Francesco Lambiasi e dalla Presidente nazionale Dottoressa Paola Bignardi, che ringrazio per il caloroso indirizzo, avete voluto raccogliervi qui, sotto lo sguardo della Madonna di Loreto, per rinnovare il vostro impegno di fedele adesione a Cristo Gesù.
Voi lo sapete: aderire a Cristo è una scelta esigente. Non a caso Gesù parla di “croce”. Egli tuttavia precisa immediatamente: “dietro di me”. È questa la grande parola: non siamo soli a portare la croce. Davanti a noi cammina Lui, aprendoci la strada con la luce del suo esempio e con la forza del suo amore.
3. La croce accettata per amore genera libertà. Lo ha sperimentato l’apostolo Paolo, “vecchio e ora anche prigioniero per Cristo Gesù”, come lui stesso si definisce nella lettera a Filemone, ma interiormente pienamente libero. Proprio questa è l’impressione che si coglie dalla pagina ora proclamata: Paolo è in catene, ma il suo cuore è libero, perché abitato dall’amore di Cristo. Per questo, dal buio della prigione in cui soffre per il suo Signore, egli può parlare di libertà ad un
amico che sta fuori del carcere. Filemone è un cristiano di Colossi: a lui Paolo si rivolge per chiedergli di liberare Onesimo, ancora schiavo secondo il diritto dell’epoca, ma ormai fratello per il battesimo. Rinunciando all’altro come suo possesso, Filemone avrà in dono un fratello.
La lezione che scaturisce da tutta la vicenda è chiara: non c’è amore più grande di quello della croce; non c’è libertà più vera di quella dell’amore; non c’è fraternità più piena di quella che nasce dalla croce di Gesù…….
6. Anche la beata Pina Suriano – nativa di Partinico, nella diocesi di Monreale – ha amato Gesù con un amore ardente e fedele al punto da poter scrivere in tutta sincerità: “Non faccio altro che vivere di Gesù”. A Gesù lei parlava con cuore di sposa: “Gesù, fammi sempre più tua. Gesù, voglio vivere e morire con te e per te”.
Aderì fin da ragazza alla Gioventù Femminile di Azione Cattolica, di cui fu poi dirigente parrocchiale, trovando nell’Associazione importanti stimoli di crescita umana e culturale in un clima intenso di amicizia fraterna. Maturò gradualmente una semplice e ferma volontà di consegnare a Dio come offerta d’amore la sua giovane vita, in particolare per la santificazione e perseveranza dei sacerdoti.
7. Cari Fratelli e Sorelle, amici dell’Azione Cattolica, convenuti a Loreto dall’Italia, dalla Spagna e da tante parti del mondo! Oggi il Signore, attraverso l’evento della beati-ficazione di questi tre Servi di Dio, vi dice: il dono più grande che potete fare alla Chiesa e al mondo è la santità.
Vi stia a cuore ciò che sta a cuore alla Chiesa: che molti uomini e donne del nostro tempo siano conquistati dal fascino di Cristo; che il suo Vangelo torni a brillare come luce di speranza per i poveri, i malati, gli affamati di giustizia; che le comunità cristiane siano sempre più vive, aperte, attraenti; che le nostre città siano ospitali e vivibili per tutti; che l’umanità possa seguire le vie della pace e della fraternità.
8. A voi laici spetta di testimoniare la fede mediante le virtù che vi sono specifiche: la fedeltà e la tenerezza in famiglia, la competenza nel lavoro, la tenacia nel servire il bene comune, la solidarietà nelle relazioni sociali, la creatività nell’intraprendere opere utili all’evangelizzazione e alla promozione umana. A voi spetta pure di mostrare – in stretta comunione con i Pastori – che il Vangelo è attuale, e che la fede non sottrae il credente alla storia, ma lo immerge più profondamente in essa.
Coraggio, Azione Cattolica! Il Signore guidi il tuo cammino di rinnovamento!
L’Immacolata Vergine di Loreto ti accompagna con tenera premura; la Chiesa ti guarda con fiducia; il Papa ti saluta, ti sostiene e ti benedice di cuore.
Azione Cattolica Italiana, grazie!
Breve profilo biografico di Pina Suriano
Tracciato da S.E.Rev.ma Mons.Cataldo Naro, nel giorno della beatificazione di Pina Suriano dinnanzi a Sua Santità Giovanni Paolo II, Spianata di Montorso Domenica, 5 settembre 2004
Nella luminosa schiera dei giovani e delle giovani che in Sicilia,particolarmente a partire dagli anni immediatamente seguenti la prima guerra mondiale,promossero e animarono i rami giovanili dell’Azione cattolica,testimoniandone con generosità l’impegno ecclesiale e civile,spicca la figura della venerabile Pina Suriano,che la Santità Vostra iscrive oggi nell’albo dei Beati. Nata a Partinico,grosso centro abitato dell’arcidiocesi di Monreale nella provincia di Palermo,nel 1915,trovò il primo sostegno del cammino della vita cristiana nell’esempio dei suoi genitori,nella frequentazione della parrocchia e nella guida delle suore dell’asilo del locale Collegio di Maria,nell’insegnamento ricevuto dalla sua maestra della scuola elementare e,più complessivamente,nell’ambito cittadino che viveva una tradizione cristiana. Di questa iniziale formazione conservò la devozione alla Madonna del Ponte,usò andare annualmente in pellegrinaggio,come la gran parte dei suoi concittadini. E conservò anche l’amore alla musica appresa alla scuola delle suore collegane. Fu poi per anni organista della parrocchia. Entrata giovanissima nelle fila dell’Azione Cattolica nella parrocchia della chiesa madre,allora unica parrocchia della città,collaborò per impiantare l’associazione nella nuova parrocchia del Rosario,eretta a metà degli anni Trenta, e ne divenne presidente della Gioventù Femminile di Azione Cattolica. Nella Parrocchia esercitò con passione il compito di catechista e prestò la sua intelligente collaborazione in iniziative caritative ed educative,tra le quali una scuola di cucito per ragazze,in cui mise a frutto le capacità acquisite nell’esercizio della sua professione di sarta. Nel clima intenso di amicizia e di reciproco sostegno tra le giovani di Azione Cattolica alimentò il suo slancio d’amore sempre più totale al Signore Gesù,unico suo bene. Maturò gradualmente una generosa volontà di consegnarsi a Dio come offerta vivente assieme al suo sposo Gesù,includendo nell’offerta anche il de-siderio,rivelatosi impossibile ad attuarsi,di essere accolta in un istituto di vita consacrata. Portò nella sua preghiera d’intercessione tutto il mondo e tutta la Chiesa, a partire dai sacerdoti. Fu dispensatrice di gioia anche nella sofferenza fisica e sull’esempio della Madre del signore cantò la misericordia di colui che anche nella sua vita aveva operato cose grandi. Consumata dall’amore,il 19 maggio dell’anno santo 1950,mentre si prepa-rava a recarsi in chiesa per l’incontro quotidiano col suo sposo divino,fu da lui introdotta nell’eterna festa degli amici di Dio e resa partecipe per sempre della luce dei santi. La Santità Vostra ne riconobbe l’eroicità delle virtù il 18 febbraio 1989.
La fede: pietra miliare del rapporto con Dio
di DIVO BARSOTTI
Esercizi di Muzzano (Luglio 1999)
Avete invitato l’assemblea a pregare e parto proprio da una invocazione, da una pre-ghiera che voi avete fatto, che Dio cioè aumenti in noi la fede, la speranza e la carità.
Parlando dell’esperienza di Dio noi dobbiamo dire con ferma e assoluta certezza che soltanto la fede può stabilire un rapporto tra noi e Dio, fra Dio e noi.
Come non abbiamo un rapporto con le stelle fisse, così non potremmo avere un rapporto con Dio senza avere ricevuto il dono della fede.
Se non ci fosse la fede, saremmo nella impossibilità assoluta di pregare!
Anche se noi dicessimo le preghiere, le preghiere rimarrebbero, non salirebbero al di là delle nubi perché la nostra forza non è tale da poter spingerei al di là di tutto quello che è creato fino a Dio; pertanto, dobbiamo renderei conto, che una esperienza di Dio se esige le virtù teologali, le esige perché senza queste virtù l’uomo si trova nell’impossibilità di stabilire un qualsiasi rapporto con la divinità e il primo dono, il primo strumento che il Signore ci dà per stabilire con Lui un rapporto è la fede.
Se noi viviamo la vita religiosa, viviamo un certo contatto con Dio attraverso la fede, la fede che ci fa conoscere Dio, ci fa conoscere le sue esigenze. Ma l’anima ne ha paura. Siamo così poveri uomini, siamo creature cosi deboli, che rapporto possiamo avere con Dio? Egli ci chiede una santità che è al di fuori delle possibilità dell’uomo di essere rag-giunta e tuttavia, anche se noi sentiamo che siamo dei poveri uomini, incapaci di tutto, ma soprattutto incapaci di rispondere alle esigenze di Dio, tuttavia noi ci sentiamo atti-rati da Lui e non possiamo fare a meno di Lui e quanto più lo conosciamo, tanto più ci attrae la Sua bellezza ci attrae il Suo amore e ci sentiamo come portati via, come trasci-nati da una forza alla quale non possiamo resistere, andiamo verso il Signore.
L’esperienza di Dio è prima di tutto questo!
Nasce dalla fede ed è insieme il timore e l’attrazione del desiderio. Sono due sentimenti che non sono mai l’uno senza l’altro! C’è sempre una certa paura, voi l’avete speri-mentata prima di fare la consacrazione: quante volte ci sono delle persone che hanno fatto l’aspirantato per più di un anno, anche due anni e non sanno decidersi perché han-no paura.
Dove è la loro forza? Come fanno ad avere la sicurezza che poi saranno fedeli? Non rie-scono ad essere fedeli nelle piccole cose! Mancare di fedeltà a Dio una volta che ci si sia consacrati a Lui sembra tale cosa peccaminosa da far rifuggire la consacrazione e, tuttavia s’insiste, si continua a venire, si riesce a partecipare un po’ alla vita della Comunità, perché, lo dicevo prima, ci sono sempre gli stessi due sentimenti: la paura e l’attrazione.
Questo distingue l’esperienza di Dio nella vita del cristiano. Conoscete voi Dio? Se voi non conoscete Dio non c’è né paura né attrazione: vivete una vita religiosa, si, però solo apparentemente: non vivete nulla, vivete soltanto una vita così, vuota, perché quel Dio a cui dovreste accedere è un Dio di carta, è un Dio che non è un Dio vivente, è un Dio che non fa paura perché è a vostra immagine e somiglianza, è un Dio che non vi attrae perché anche la vita religiosa che uno vive nei confronti di Dio è soltanto un riempire il vuoto della vita. Ma non è riempirla di amore, di un desiderio vivo di unione; si vivacchia, così, e non si vive né una vita umana, né una vita religiosa. È il pericolo tante volte anche di coloro che vogliono vivere una vita religiosa, cioè che non vivono né una vita umana, né una vita religiosa; si trascinano giorno per giorno, anno per anno in una vita mediocre, una vita senza luce, senza desideri, senza aspirazioni, senza nemmeno paura, si va avanti come per forza di inerzia.
Timore e ardore: sinonimi di vita nuova
Se c’è la fede, tutto nasce da lì: ecco, Dio non è più un Dio di carta, è il Dio vivente!
Lo conosci, ma lo conosci in quanto è una Persona, non lo conosci perché sai il catechi-smo, non lo conosci perché conosci la teologia, lo conosci perché l’hai veduto, perché Egli è entrato nella tua vita, perché Egli si è manifestato a te, e perché la manifestazione di Dio alla tua anima ha voluto dire per la tua anima un desiderio incoercibile di essere unita a Lui e, nello stesso tempo, una grande paura per il senso della tua debolezza, per il senso della tua impotenza, della tua povertà spirituale. Conoscenza di fede che è molto maggiore, molto più importante di una conoscenza teologica.
È soltanto così che nasce la vita religiosa, nasce da questa conoscenza di fede.
Un teologo può parlare della Santissima Trinità fumando una sigaretta, ed è una cosa spaventosa, se si pensa bene, ma lo può fare perché Dio è un Dio un po’ di carta, un Dio con il quale si ragiona facilmente: è un Dio senza potenza, che non ha alcuna forza nella tua vita interiore. Perché? Perché la fede è poca, la fede è poca! Una persona, una donna, una semplice donna, magari analfabeta, che non conosce altro magari che un po’ di catechismo può vivere una unione con Dio, può vivere una fede più viva, anche dei te-ologi.
Senza dubbio santa Teresa, o santa Gemma Galgani avevano più fede del vescovo della loro diocesi. Pensiamo santa Gemma Galgani e il vescovo di Lucca del tempo. È im-pressionante la differenza che vi è fra un vescovo buono ma mediocre, e questa anima che è totalmente presa dall’amore del Cristo, che non vede altro che Lui, che non pensa altro che a Lui, che vive una vita in cui veramente viene consumata dall’amore.
Certamente la fede di santa Gemma era molto più grande assai della fede del suo vesco-vo, anche se il vescovo era vescovo e Gemma Galgani era una povera scema, come lei si firmava.
Quello che conta nella vita religiosa, dunque, è la fede perché la fede è l’organo che ci mette in comunione con Dio. Vorrei sapere: è lo stesso guardare una fotografia della montagna o scalare la montagna?
Vi sembra la stessa cosa? Vediamo, vi sembra davvero la stessa cosa? Non credo davve-ro, ebbene quelli che vivono, che parlano anche di Dio possono essere come quelli che guardano una fotografia. Altro è guardare la fotografia, altro è scalare la montagna, altro è vivere un contatto vero con Dio.
Guardate bene che la fede vi deve mantenere in un contatto reale con una persona vi-vente. . Dio è, Dio esiste, Dio è qui!
Dio, con tutta la sua esigenza di amore, con tutta la pienezza della Sua santità: Egli è qui, e l’anima ha un trasalimento grande. Non riesce a vivere insieme a questo Dio così grande, ne ha quasi paura, eppure dicevo prima, questa paura di Dio si unisce nell’anima a una impossibilità di fuggire perché si sente, nello stesso tempo, attirata da Lui e tu senti che la tua vita è soltanto nella risposta a questa attrazione che provi e che il Signore esercita su di te.
È, direi, proprio questa l’esperienza fondamentale: quando si parla dell’esperienza di Dio dobbiamo pensare che quello che distingue questa esperienza sono questi due sen-timenti, mai uno senza l’altro. Può essere che qualche volta prevalga non so l’attrazione alla paura, altre volte la paura o almeno il senso del rispetto invece dell’amore, ma questi due sentimenti sono sempre presenti. Se non c’è il timore dovete avere paura, se non avete paura dovete avere paura perché Dio non è proporzionato all’uomo.
Ti senti di vivere insieme a un gigante, ti senti di vivere una santità che ti brucia, che ti consuma: ti getteresti volentieri nel fuoco? Non credo! Non ti sei mai gettato nel fuoco, ecco, non ti senti anche di gettarti in questo Dio. Un senso di timore nasce sempre nell’anima. Che cosa mi chiederà il Signore? Che cosa vorrà da me? Come potrò vivere io un rapporto con Lui?
Ed ecco allora si cerca di vivere una vita anche buona, ma la vita buona che vogliamo vivere, le virtù, sono una difesa contro Dio: se Lui mi lascerà in pace cercherò di dire le mie preghierine, farò quest’altra cosa, quest’altra così e Dio sarà contento e io vivo la mia vita lo stesso. Quando io gli ho dato un po’ di qualche cosa di mio, credo di averlo accontentato e posso così vivere la mia vita.
Non è così che possiamo vivere una vita religiosa: se conosci Dio non puoi fare patti con Lui, è Lui che fa i patti con te, ma tu non puoi fare i patti con Dio. Anche se siamo nella religione dell’alleanza non siamo sul medesimo piano. Da una parte c’è Dio, Dio che tutto può pretendere, tutto può volere perché Dio non è proporzionato all’uomo: dall’altra c’è l’uomo con la sua piccolezza, con la sua incapacità, con la sua povertà, con i suoi peccati.
Vivere con semplicità la vita cristiana nella fede e nella speranza
In questo rapporto così strano, perché veramente è strano se noi ci pensiamo bene, l’anima vive una vita del tutto nuova nei confronti della vita degli uomini che non hanno fede.
Per un’anima che ha fede è impossibile accantonare questo Dio. Anche se tu cerchi di allontanarti, per la paura che hai, non ce la fai perché nello stesso tempo Egli ti attira.
Ed allora che cosa avviene? Avviene che la tua vita è una vita drammatica: gli altri pos-sono vivere nella pace, ma è la pace della morte. Noi non viviamo la pace!
Lui lo ha detto: “Io non sono venuto a portare la pace, ma la guerra”!
È un dramma quello che si vive, è una lotta terribile quella che l’uomo vive, non solo perché l’uomo è l’uomo e Dio è Dio, ma perché l’uomo non è mai autonomo: o è in di-pendenza da Dio o è in dipendenza dal maligno, dal male, e la vita cristiana è un com-battimento, il campo di battaglia è il tuo cuore!
Da una parte c’è Dio che però non combatte ma si fa presente e la sua presenza vince tutti gli orrori del male. Dall’altra parte però c’è il maligno che si insinua e ti combatte, vuole prendere possesso di te. Oltre dunque che essere sentimento di paura e di attrazio-ne la vita religiosa cristiana, nella sua esperienza, è anche una esperienza di una lotta che si svolge nel tuo intimo. Altro che pace! La pace si avrà, ma sulla sommità, quando si è arrivati in cima ti puoi riposare, ma durante il cammino guarda di non fermarti perché è pericoloso, puoi sdrucciolare e precipiti giù.
Puoi guardare ed avere il senso della paura nel vedere i dirupi che da ogni parte ti cir-condano. Nella nostra vita religiosa viviamo un combattimento terribile.
È Dio che permette, ed è il maligno che in tutti i modi vuol prendere possesso di noi ma Dio ci protegge ad una condizione, però: che noi abbiamo fiducia.
Oltre dunque alla fede ci vuole la speranza, quello che ha detto quella nostra sorella nelle preghiere di questa sera: “aumenta in noi Signore la fede, la speranza e la carità”.
La fede non può andare da sola perché la fede ci dice le esigenze di Dio, ma non ci dà la forza di compierle, noi abbiamo bisogno di aver fiducia nell’aiuto di Dio, vi è un bisogno di credere che Dio non ci abbandona, abbiamo bisogno di sapere che Egli sarà pronto ad aiutarci nei nostri bisogni, nei nostri pericoli: guai se perdiamo questa fiducia nel suo aiuto! Da noi soli non possiamo nulla.
Abbiamo bisogno oltre che della fede, di una speranza viva.
La fede senza la speranza è comunque la morte perché la fede non stabilisce una unità nell’amore.
Ci dà il senso della grandezza di Dio, il senso della pochezza dell’uomo, ma come unire questi due, l’uomo e Dio, se non hanno nulla in comune?
In comune è la fiducia, la comunione di vita è la fiducia che la crea, perché l’anima che ha veduto Dio, che ha sentito il bisogno di tendere a Lui, ora si affida alla sua provvidenza, si mette nelle mani di Dio, si lascia portare, ma a una condizione: deve avere in Lui una fiducia cieca!
Noi dobbiamo chiudere gli occhi, non aver paura: soltanto così si compiranno le opere di Dio.
Se voi leggete la vita dei santi voi potete capire come questa esperienza sia una espe-rienza comune nella vita spirituale.
Quale esperienza? L’esperienza che Dio ci soccorre nella misura che noi ci fidiamo di Lui.
La vita cristiana vissuta come vincolo di amore.
Da noi non possiamo far nulla, da noi siamo incapaci di fare anche il più piccolo passo, ma se ci mettiamo nelle mani di Dio possiamo attraversare anche il mare. Basta chiudere gli occhi ed ecco allora c’è lo Spirito Santo che, come dice il Libro dell’Esodo, apre le sue ali e così che noi possiamo salire sulla groppa dell’aquila e lasciarci portare dall’aquila stessa: ma questo è possibile se c’è la fiducia altrimenti non lo facciamo!
Noi riusciremo ad andare di là, cioè a salvarci nonostante la lotta, nonostante il pericolo se sapremo fidarci di Dio.
Da una parte dunque la fede, non la fede però senza la speranza, perché è sì la fede che ci fa vedere le cose, ma non ci dà la capacità di unirci a Dio; ci fa vedere Dio, ma non rende possibile per noi la nostra unione con Lui. È Dio che stabilirà quell’unione, ma la stabilirà nella misura che noi lasceremo che Egli possa operare in noi ed Egli opererà in noi nella misura che noi ci abbandoneremo alla sua forza.
Vedete come è semplice la vita cristiana?
È grande la vita cristiana, è grandissima, ma è anche estremamente semplice. Si tratta di conoscere Dio e rimanere conquistati dalla sua bellezza. E conoscendo Dio impariamo a conoscere anche noi stessi, ma scopriamo anche di non sapere come potranno unirsi questi due esseri talmente diversi: da una parte Dio l’Onnipotente, da una parte Dio la santità stessa, da una parte Dio l’Infinito e dall’altra parte questo omuncolo che siamo noi. Come unire i due esseri?
Li unirà la speranza, la fiducia, l’abbandono a Dio stesso che interviene nella nostra vita. La speranza non è atto dell’uomo, è un atto di Dio. Di un Dio che vive in te, di un Dio a cui devi abbandonarti, di un Dio dal quale devi lasciarti possedere. Allora se ti lasci possedere da Lui, tutto andrà bene, tutto si compirà secondo il tuo desiderio e secondo anche l’onnipotenza di Dio. Vedete come è chiara la vita religiosa nei suoi principi ed anche nelle sue forme? Non abbiamo bisogno di tante storie, di tanti discorsi, si tratta di conoscere, ma di conoscere Dio come un essere vero, non conoscerlo come da una cartolina, non conoscere Dio per sentito dire.
Ricordate come finisce il Libro di Giobbe? “Prima parlavo di Te per sentito dire, ma ora che ti ho conosciuto mi prostro nella polvere e nella cenere, in silenzio di fronte a Dio”. Così anche per noi: avendolo conosciuto, sì, ora sappiamo che cosa voglia dire la vita religiosa, ma sappiamo anche che da noi non possiamo proprio fare nulla. È questo il passaggio dalla fede alla speranza, speranza che ci dona di poter essere portati a Lui e condotti dal Suo Spirito.
E poi la carità, che è il frutto di quello che la speranza avrà compiuto nella nostra anima, perché il desiderio e la speranza dell’anima non può essere che una sola cosa: che il rapporto che sembrava impossibile fra l’uomo e Dio si realizzi invece in una alleanza di amore. La vita cristiana è, dice San Tommaso D’Aquino: quaedam amicitia, è un legame di amore.
Di un amore che ha tutti i caratteri di ogni amore, di amore filiale da parte dell’uomo, di amore paterno da parte di Dio. È amore di sposo nei confronti di Dio che è lo sposo nei confronti dell’anima che è la sposa: è amore di amicizia perché Egli è un fratello nostro, Gesù si è fatto nostro fratello.
Tutti i rapporti che sono propri dell’uomo quaggiù e sono tantissimi, tutti sono realizzati nel nostro rapporto con Lui, talmente Dio ci prende totalmente, ci possiede e ci trasforma in Sé.
Accogliere l’amore per essere la gioia ed il fine di Dio
L’ unione con Dio fa sì che noi siamo due in un solo corpo, siamo due in una sola vita.
Non si distrugge la distinzione personale di ciascuno di noi da Dio.
Io rimango Divo Barsotti anche dopo la morte; però non vivrò più la mia vita, vivrò la vita di Dio se avrò la fortuna, la gioia di poter andare in paradiso. Vivere la vita stessa di Dio!
Non avrò un mio essere particolare, il mio essere è Cristo perché sono inserito nel Cri-sto.
Il Cristo è glorioso, il Cristo è in Cielo, alla destra del Padre anche col suo corpo che è risorto. Allora se noi siamo nel Cristo voi capite che può continuare la vita anche corpo-rale. In che senso possa avvenire questo è difficile capirlo, ma giustamente Rosmini a-veva intuito che attraverso la morte l’uomo realizza il fatto di essere un solo corpo con Cristo Gesù.
Comunque quanto detto da Rosmini resta una affermazione che è sub judice, cioè non posso dire che sia la verità: si può studiare, può darsi che sia la verità, ma oggi come oggi la Chiesa non si pronunzia.
La cosa importante è però comunque un’altra: che attraverso la fede e la speranza l’uomo finalmente vive un rapporto di amore, di un amore che lo colma, di un amore che gli dona il senso di una pienezza, di una dolcezza ineffabile, il senso di una presenza viva di amore. L’anima si libera da ogni peso, non conosce più la propria povertà e i propri peccati, non conosce più che l’amore di Dio: tutta la sua vita è questa gioia di essere amata, tutta la sua vita è questa esperienza di essere il fine di Dio.
Sappiamo che Dio è il fine dell’uomo, che l’uomo non può trovare la sua pace e il suo fine che in Dio stesso ma una cosa molto più grande è vera: che noi siamo il fine di Dio perché se egli ci ama, l’amato per l’amante è il termine ultimo.
L’amante si ordina all’amato e Dio si ordina all’uomo e vive in tal modo che noi siamo, dobbiamo essere la sua ricchezza, e la sua gioia.
Dice sant’Ireneo, il più grande teologo dei primordi della Chiesa: Gloria Dei vivens homo, la gloria di Dio è l’uomo vivente. Perché?, Ma perché Dio vede nell’uomo il suo bene! Se veramente Egli ci ama non può non vedere in noi la Sua ricchezza.
Molte di voi sono sposate, vostro marito vi deve amare altrimenti non lo avreste nem-meno sposato, vostro marito si è innamorato di voi. Che cosa vuol dire innamorato di voi? Ha sentito che doveva realizzare la sua vita nell’unione con voi, perché voi eravate per lui la sua ricchezza e la sua gioia, senza di voi non poteva vivere! Quando si ama è così! Così è anche Dio, Egli ci ama, non può stare senza di noi, per questo si è fatto uo-mo, per questo ha vissuto la nostra vita, per questo vive anche oggi qui con noi ed è questa la carità come la viviamo nel tempo presente.
In paradiso ancora non so, non ho ancora l’esperienza della vita beata, ma ho l’esperienza della vita cristiana nel mondo. E qual è questa esperienza? Questa presenza di Dio come un amico, questa presenza di Dio come uno che mi ama, che vuole stare con me, che mi chiede soltanto di fargli posto nella mia vita, nel mio cuore: non mi disturba, non rende più pesante la mia vita, l’alleggerisce piuttosto, la colma di pace, dona alla mia anima un senso vivo di gioia; mi sento conosciuto e amato.
Dio si è fatto uomo come noi per farci una sola cosa con Lui
Noi avremmo avuto paura se non avessimo fatto questo cammino della fede, della spe-ranza, fino all’amore, avremmo avuto paura di Dio: ma invece il cammino che ci ha condotto dalla fede alla carità ci fa vivere in unione con un Dio che si è fatto uomo come noi perché nessuna distanza ci separi da Lui, perché nessuna distanza separi noi da Lui e Lui da noi. E questa distanza è vinta perfino se noi siamo peccatori perché ha preso su di Sé il nostro peccato così che noi potessimo vivere con Lui senza timore: Egli è l’agnello che ha tolto, che toglie i peccati del mondo.
Quando io dico la Messa, subito prima della comunione, quando alzo il Corpo del Si-gnore e dico: “Ecco l’agnello di Dio che toglie i peccati del mondo”, ho l’impressione che in quel momento non esistano più peccati, non solo i miei, ma anche quelli di tutti gli altri uomini, né degli assassini, né degli adulteri: tutto è perdonato da parte di Dio!
Naturalmente c’è l’uomo, bisogna che accetti di essere amato, ci vuole un consenso dell’uomo che è libero di accogliere o meno: però da parte di Dio, tutto è già dimenticato perché Dio non vive che il suo amore senza limiti e senza misura; a noi resta soltanto aprirci a questo amore gratuito ed immenso!
Vogliamo essere amati? Vuoi essere amata? Vogliamo essere amati! Questa è la vita cristiana: aprirci ad accogliere Dio!
Un Dio che si fa uguale a noi, che prende sopra di Sé i nostri pesi, perché ha tolto da noi il nostro peccato per prenderlo sopra di Sé perché non voleva che noi fossimo accasciati sotto il peso delle nostre colpe, È L’amore, l’amore!
Dio ci ama in tal modo da essersi fatto uguale a noi, uno con noi. Domani Egli ci farà una sola cosa con Sé: ora Lui si è fatto uomo con noi. È un povero uomo, che vive per trenta anni nella casa di Nazareth; un predicatore itinerante che predica a degli umili contadini e pescatori; un uomo che è condannato a morte e muore sopra la croce. Ma domani Egli farà sì che noi siamo come Lui, nella gloria del Cielo, saremo figli di Dio in questa meravigliosa grandezza che ci è promessa, di essere veramente suoi figli. Non sappiamo che cosa questo voglia dire, però ci insegna San Giovanni nella Prima Lettera, che “allora lo vedremo così come Egli è perché saremo simili a Lui.”
Ora è Dio che si fa uguale a noi povero, nascosto, sofferente, morto. Domani farà noi simili a Sé: la gloria, la ricchezza del Cielo, la gioia infinita dell’amore, di un amore e-terno! Ecco che cosa è, miei cari fratelli, l’esperienza di Dio nel Cristianesimo.
II MEDITAZIONE
Il mistero trinitario
Se noi pensiamo a Dio, uno, noi allora dobbiamo di che Dio non può essere rapporto con le cose. E nemmeno in sé stesso è diviso, non può conoscere nemmeno sé stesso, perché il Dio uno è un Dio immutabile, ma fermo, si direbbe senza vita.
Di qui la necessità e l’importanza per noi di capire che se entriamo in rapporto con Dio, se Dio entra in rapporto con noi, è perché Egli è trino nelle persone, senza una moltipli-cazione di rapporti dentro la Divinità che rimane come muta, rimane senza vita, senza conoscenza, senza amore.
Dante era cristiano, però, se voi leggete con attenzione alcuni passaggi della Divina Commedia, vedrete che Dante riconosce che il Dio uno è sì un Dio che è amato, ma che non ama. “L’amor che muove il sole e le altre stelle” è Dio in quanto muove le creature, le creature tendono a Lui perché in Lui trovano la loro perfezione, ma Dio non ha alcun rapporto con la creazione, nessun rapporto con queste anime che lo cercano perché è un Dio si direbbe morto.
Per vivere abbiamo bisogno di comunicare e la vita in Dio è la trinità delle persone.
Infatti Dio è Padre, ma se è Padre c’è il Figlio altrimenti non sarebbe Padre!
Avete mai visto voi qualcuno che fosse padre senza avere figli? Se uno è padre avrà un figlio, sarà un figlio adottivo, ma bisogna che sia un figlio senno dire padre è sbagliato.
Se voi mi chiamate padre vuol dire che vi sentite figli di questo stupido che sono io, se non vi sentite figli usate un linguaggio che non ha senso.
Ora Dio invece è Padre, Figlio e Spirito Santo e nel rapporto che si stabilisce fra ogni Persona divina e l’altra Persona correlativa è il principio e la pienezza di ogni vita perché ogni vita non può essere altro che una lontanissima partecipazione alla vita immensa di un Dio che è amore infinito, che si dona all’altra Persona e l’altra Persona che diviene amore ugualmente infinito che ritorna alla sua sorgente.
Vivere per partecipazione l’immensità divina
Noi tutto questo lo diciamo e lo viviamo, ma senza accorgercene: forse anche il sacerdote tante volte dice male l’oremus. Che cosa avete detto alla fine l’Ora media? “Per il nostro Signore Gesù Cristo, che vive e regna nello Spirito Santo…” Sempre la preghiera nel cristiano implica un entrare per noi in questo mirabile infinito, in questa corrente infinita di amore che passa dal Padre al Figlio e dal Figlio ritorna al Padre nell’unità dello Spirito Santo. Senza di questo la nostra preghiera non vale nulla! Per noi sarebbe impossibile stabilire un rapporto con Dio se non vivessimo una certa partecipazione alla vita di Dio, alla vita trinitaria.
Una mistica cristiana è sempre una mistica trinitaria, non è la mistica del Dio uno, perché la mistica dei Dio uno è impossibile: se Dio è uno e non è personale rimane bellezza, rimane tutto quello che volete: grandezza, immensità, onnipotenza. Ma è un’immensità muta, una immensità come morta perché non entra in comunione con nulla, né nulla entra in comunione con essa.
Voi sapete infatti che stando alla creazione, senza che noi possiamo parlare di quella e-conomia divina per la quale Dio è entrato in comunione con il mondo, con la creazione Dio non entra in rapporto con le cose, rimane nella sua solitudine infinita ed eterna. Magari sono gli uomini, secondo quello che diceva Plotino, che aspirano a Lui, ma Lui non aspira a nulla, Lui non vede nulla, Lui non ama nulla. L’amore di Dio implica l’amore del Padre al Figlio, l’amore del Figlio ai Padre nell’unità dello Spirito Santo.
Vivere dunque l’esperienza di Dio vuoi dire vivere questo nostro entrare misteriosa-mente nel mistero stesso di Dio, la nostra vita non può essere altro che una partecipa-zione lontanissima ma reale, alla vita stessa di Dio: e Dio è vivente ! È vivente proprio perché è Padre, Figlio e Spirito Santo.
Dio per mezzo del Figlio si comunica al mondo nello Spirito Santo
Voi vedete l’importanza che hanno certi misteri, che sembrano lontani dalla nostra vita e, invece, senza di questi, non si capisce nulla.
Se Dio non fosse Trinità sarebbe un Dio morto: d’altra parte ogni persona divina è tutto Dio ed è un unico Dio.
Parlare dell’esperienza di Dio vuoi dire parlare di questa esperienza dell’uomo che co-nosce Dio come trino, lo ama partecipando all’amore infinito che passa da una Persona divina all’altra Persona correlativa.
Di fatto chi è Dio per noi?
La preghiera cristiana come si esprime? Precisamente si esprime in tal modo che noi comprendiamo che nessun rapporto è possibile nell’uomo verso Dio se non in quanto Egli è il nostro Padre.
Lo sapete il Padre nostro? Lo conoscete? La preghiera cristiana già ci mette di fronte al Padre: non di fronte alla immensità, perché davanti all’infinità si rimane muti. Ma se questa infinità, ma se questa immensità è il Padre tuo, tu vivi una certa partecipazione a questa immensità divina, tu vivi una certa partecipazione a questa sua santità infinita.
La cosa importante è questa: la vita implica un rapporto. Dio è rapporto infinito di amo-re nelle tre Persone divine. Dio si partecipa e in Sé medesimo Dio partecipa Sé stesso. Piuttosto che partecipare, dona Sé stesso, travasa Sé stesso dal Padre nel Figlio e fa sì che il Figlio poi totalmente ritorni al Padre nell’unità dell’amore, ma di un amore che di per sé non esiste: è una comunione di vita!
L’amore è unione!
Parlare di esperienza di Dio vuol dire dunque parlare dell’esperienza che noi dobbiamo avere di questa nostra partecipazione alla vita divina. Come avviene questa partecipa-zione alla vita divina? Come è possibile che avvenga questa partecipazione alla vita di-vina? Se la vita divina si esprime e si fa presente nella trinità delle persone, come noi viviamo la vita di Dio? È semplice! Tutto il mistero della vita soprannaturale nasce da questa verità: dal Padre, per mezzo del Figlio, Dio si comunica al mondo nello Spirito Santo.
Nello Spirito Santo, per mezzo del Figlio, tutta la creazione ritorna in Dio
Il Padre dunque è all’inizio della vita spirituale ed è al termine: all’inizio perché tutto procede da Lui, alla fine perché tutto a Lui ritorna ed in Lui tutto trova riposo.
Tutto dal Padre procede, infatti dal Padre è generato il Figlio di Dio. Il Figlio di Dio non sarebbe Figlio se non ci fosse il Padre.
È il Padre che si travasa in qualche modo nel Figlio unigenito, ma il Figlio unigenito non vive in sé. È Figlio e pertanto, vive in rapporto col Padre; perciò tutto il Figlio vive ora nella contemplazione del Padre, vive nel donarsi al Padre. E tutto questo come avviene?
Nell’unità dell’amore, non dell’amore del Dio uno, ma nell’amore che è proprio della vita delle Persone divine in quanto vivono e in quanto sono questa comunione immensa di amore, questo braciere infinito, questo incendio di amore che è la vita intima di Dio. Allora, vedete, che cosa è la vita spirituale cristiana? Se vogliamo conoscere l’esperienza di Dio dobbiamo dire chi è il Padre? Come vive il Padre per me? Come il Padre si comunica a me?
Di fatto, voi lo vedete, la preghiera della Chiesa e sempre rivolta a Dio Padre, pochissime volte è rivolta al Figlio e quasi mai allo Spirito Santo, almeno nell’Oremus. Non c’è nemmeno un’Oremus che abbia come termine lo Spirito Santo, come Persona della Tri-nità alla quale mi rivolgo.
Ci sono le Sequenze, ci sono i Responsori che possono dire: “Vieni o Spirito creatore, vieni Santo Spirito” ma non è la preghiera ufficiale, la preghiera della Colletta.
Nell’Oremus è sempre il Padre perché non posso entrare in rapporto con Dio che in quanto sono figlio. Ecco l’importanza della nostra divina adozione filiale! Se non fossimo figli, noi saremmo totalmente sconosciuti a Dio e Dio sarebbe totalmente sconosciuto a noi, non ci sarebbe nessuna, nessuna possibilità di stabilire un qualunque rapporto con Dio. Perché capite, se noi fossimo rapporto con Dio, indipendentemente dal Padre che cosa succederebbe? Succederebbe che la Trinità sarebbe Padre, Figlio, Spirito Santo e Divo Barsotti. Ma non è così! La teologia non vede questa possibilità. Rimane la Trinità delle Persone divine, non si aggiunge nessuno ma le persone create possono partecipare della vita della Trinità.
Come fanno a partecipare della vita della Trinità? Vi ho detto sempre che vi è un abisso infinito fra la creatura ed il Creatore: se ora dico che l’uomo non può entrare in rapporto con Dio se non vive in Dio, questo vivere in Dio come è possibile, dal momento che l’uomo non potrebbe mai superare l’infinita distanza che lo separa da Dio? È semplice! Perché Dio si è fatto uomo!
Il Creatore si è fatto creatura
Voi capite, e per me è assolutamente certo, ma se togliete l’Incarnazione del Verbo e la Trinità di Dio, non esiste religione, non può esistere nulla, nulla, nulla!
Ma se esiste l’Incarnazione, se veramente l’Incarnazione è un fatto reale, allora essa di-viene il fondamento di ogni vita religiosa.
Cosa implica infatti l’Incarnazione? Una cosa meravigliosa, la cosa più bella e stupenda che si possa pensare. Una bambina, qui ci sono anche delle persone abbastanza giovani, ma la Madonna è la più giovane di tutti voi: non c’è nessuno qui che abbia 14 anni, Ma-ria Santissima aveva 14 anni. Non aveva studiato: voi avete studiato o almeno siete an-dati alle elementari, Maria Santissima no.
Ebbene questa bambina può dire ora a Dio: “Tu sei mio Figlio”, perché era Figlio di Maria ed era Dio; cioè l’Incarnazione ha reso possibile un rapporto. Facendosi uomo, Dio si fa Figlio di Maria.
È un rapporto essere figli. Dio diviene Figlio dell’uomo, Figlio della Vergine.
La Vergine diviene la Madre di Dio.
L’Incarnazione è il fondamento di ogni vita religiosa perché è per mezzo dell’Incarnazione che noi ora possiamo entrare in rapporto con una Persona divina, con la Persona del Figlio.
Noi entriamo in rapporto con la Persona del Figlio perché nel Figlio noi siamo generati dal Padre, dal Padre dunque per la sua volontà, per suo decreto Egli genera il Figlio non più nell’eternità, ma nel ventre di una bambina.
La vita cristiana è questo. Dio che entra dentro di noi, ci fa partecipi della filiazione del Figlio di Dio. Voi capite allora che la nostra vita è una partecipazione, anche se infini-tamente lontana, alla vita stessa di Dio.
Il Padre è Padre mio perché sono figlio adottivo, ma non come nel mondo. L’adozione filiale ci fa partecipi della natura divina, siamo in qualche modo trasformati. Il Padre ci genera nell’atto stesso in cui genera il Figlio suo. Dice infatti la sacra scrittura: “Ci generò nella Parola, nel Verbo della verità, cioè nel Figlio.” Generando il Figlio di Dio, il Padre genera anche noi, ma capite che cosa vuol dire questo? E come è possibile che non impazziamo? C’è davvero da impazzire! Vuol dire che Dio, nella sua infinita grandezza, Dio, il Padre, tutto si travasa in me: io non posso riceverlo perché sono una creatura, ma da parte di Dio non c’è una partecipazione, da parte di Dio, in quanto Dio è ed è infinitamente semplice, egli si dona tutto o non si dona. È l’uomo che dà una misura al dono di Dio, nella sua fede, ma se l’uomo fosse capace di una fede che lo rendesse capace di accogliere l’infinito, accoglierebbe l’infinito, perché Dio quando si dona non si può dare per parte: se si potesse dare per parte non sarebbe più Dio perché non sarebbe l’Essere semplicissimo che non si divide, l’Essere semplicissimo che non si moltiplica, l’Essere semplicissimo che è Uno e che è infinito.
Ora, la vita spirituale: prima di tutto è questo essere generati. Ecco una delle cose più grandi!
Vivere la vita cristiana vuoi dire questo: accogliere Dio in sé, Dio che si comunica a te.
Si è detto qualche volta che la vita cristiana ha una analogia con la vita umana, anche con la vita sessuale: ma è vero questo perché di fatto il primo atto della vita cristiana implica che il Padre celeste, comunicando a me la sua parola che è seme, concepisce questa parola in me e il Cristo nasce da me. Non è più il Figlio di Dio nella sua natura divina, ma è il Figlio di Dio stesso nella natura umana che ha assunto. È una natura dunque che dice non più l’infinità di Dio, ma una partecipazione reale da parte dell’uomo alla vita intima divina.Il Padre ci genera nel Figlio suo!
L’eterna generazione del Figlio al Padre: essenza della nostra vita spirituale
La generazione del Verbo nell’eternità, è una generazione nella quale io sono coinvolto. È come un fiume che trascina con sé tutti gli arbusti, tutti i sassi, ed anch’io sono quei sassi. Ma questa corrente infinita di amore non può non trascinare con sé, portare con sé tutto l’universo nel seno del Padre, perché il Padre si comunica a tutto l’universo nel dono della parola, del seme. E col seme, con la parola, il Verbo viene concepito. Non vive più soltanto nel seno del Padre, vive nel seno di Maria, nel ventre di Maria. Pensate: dal seno del Padre, per nove mesi, vive nel seno della Vergine! Eppure è il Figlio di Dio ed è più dell’infinito, è Dio stesso.
Egli vive nel ventre di una donna e così noi dobbiamo vivere la vita spirituale. Ci basti pensare questa cosa: siccome Dio è eterno, e Dio non può compiere un atto che finisce perché l’atto suo è un atto di eternità, ne viene che il Padre ci comunica in questo mo-mento il suo Figlio. Vivere la vita spirituale vuol dire dunque accogliere in noi il Verbo di Dio, vuol dire accogliere in noi il Padre celeste che si comunica a noi nel Figlio suo. Io non posso sentirmi separato, dipende da me se voglio accettare o meno il Figlio di Dio, ma il Padre mi dona costantemente, in un atto unico, eterno, suo Figlio che diviene mio Figlio. Egli vive in me.
La prima cosa della vita spirituale è questa: è un atto del Padre che comunicandoci il Fi-glio suo, vive in noi e ci fa suoi figli. Questo atto è tutta la vita. Io lo posso vivere mentre faccio la prima colazione, lo vivo in questo momento che vi parlo, lo posso vivere quando prego più attentamente, sottraendomi ad ogni altro pensiero o ad ogni altro atto.
Ed è questo che dice la vita cristiana: siccome l’atto divino è un atto unico che dura e-ternamente, è necessario che la vita cristiana tenda sempre più all’unità e diventi sempre più una sola cosa, e non invece molteplicità di fatti, di devozioni, di preghiere. Noi ab-biamo bisogno di una certa molteplicità perché abbiamo bisogno di risvegliarci ogni volta, però in una visione non nuova nel senso, ma nuova nella forma; allora ci risvegliamo un po’, altrimenti l’abitudine fa sì che perdiamo il contatto con questa verità così grande.
Però, di fatto se l’atto del Padre è unico ed eterno, l’atto nel quale Egli genera il Figlio genera anche noi nel Figlio suo. Se questo atto è eterno, vuole dire che in ogni momento io posso accogliere Dio. Non si tratta di accogliere qualsiasi grazia, di essere più buoni, ma di accogliere Dio, Dio stesso che si comunica a noi in questo momento… domani, oggi, in ogni istante della mia vita, se cammino, se dormo, se cammino, se sto fermo, se mangio, se bevo. Sempre e comunque vivere questo atto.
È forse anche l’atto di una madre che genera il suo bambino? No, è qualche cosa di più e di molto più grande ancora, perché quello che viene generato in Maria è il Figlio di Dio che diviene sì, suo Figlio, ma rimane anche Figlio di Dio. Maria santissima è la genitrice di Dio, e la Madre di Dio. Questo Figlio di Dio che è anche Figlio di Maria, lo è pienamente, perché la Vergine santa ha vissuto una fede che supera la perfezione di fede di tutte le altre creature.
La santità di Maria dipende dalla sua fede, perché tanta è la fede dell’uomo, tanta è la capacità dell’uomo di accogliere Dio. Si tratta di accogliere Dio in ogni istante, di acco-gliere Dio che è l’infinito. Non avremo mai una fede così grande da poterci aprire ad accogliere in noi l’infinito, così da poter vivere pienamente la vita di Dio. Ma comunque non vivremo mai come ha vissuto Maria, perché la fede della Vergine è quello che maggiormente fa di Lei la creatura più santa di tutte le creature.
La nostra santità non è nostra, sarebbe un errore dire che la nostra santità è qualcosa di nostro, perché la prima cosa che fa Dio è togliere la proprietà: tutto è Lui, tutto deve es-sere Suo.
Non si tratta dunque di volere una nostra santità, si tratta di accogliere la santità di Dio, ed è quello che noi viviamo: se noi viviamo la Santa Messa, non riceviamo forse il Corpo, il Sangue, l’anima e la divinità di Cristo Signore? L’esperienza, dunque, di Dio, esige che noi in qualche modo entriamo nel mistero della vita intima di Lui, entriamo nel mistero della vita di Dio per la volontà positiva, ma infinitamente libera, di Dio che vuole comunicarsi al mondo. E Dio si comunica al mondo precisamente nel medesimo mistero nel quale il Padre si comunica al Figlio e il Figlio ritorna al Padre nell’unità dello Spirito Santo. Non c’è altro!
Tutto qui. Se poi, nell’Incarnazione, noi vogliamo capire il perché della morte di croce, la cosa è semplice, perché divenendo un solo uomo con tutti noi, Gesù deve assumere non solo la nostra natura, ma i nostri peccati, deve assumere la nostra responsabilità di peccato. Tutti i peccati del mondo si rovesciano su di Lui, non in quanto Egli pecca, ma in quanto subisce il peso di tutta la responsabilità umana che lo fa schiavo, condannato alla peggiore delle sentenze, perché la crocifissione era propria degli schiavi (san Paolo, pure condannato, non viene crocifisso, perché era cittadino romano).
Gesù è lo schiavo che si addossa tutto il peso dei peccati, ma è sempre lo stesso Figlio di Dio che, facendosi uomo, si fa uno con tutti noi ed uno con noi non può farsi che as-sumendo la responsabilità universale.
Però prima di parlare di Gesù parliamo appunto di questo primo atto, del primo aspetto di questa vita spirituale: è il Padre che genera il Figlio, è il Padre da cui procede lo Spirito Santo, insieme al Figlio. Ecco, la prima cosa è questa.
La vita spirituale ci riporta a vivere la generazione eterna del Figlio al Padre. La nostra vita spirituale non può essere una generazione dall’eternità perché non c’eravamo. Non può essere dunque eterna da prima, cioè non è eterna in noi perché non siamo nati all’origine, ma è eterna per il futuro… la morte non esiste! Veramente questo atto per il quale Dio si dona rimane in eterno. La morte non tocca quell’atto di Dio: noi viviamo.
Si tratta di vivere questo accogliere Dio in noi. Pensate: è Dio che dobbiamo accogliere ed in ogni istante, anche ora Egli è qui! Ogni istante può essere una comunione spirituale nella quale il Padre si comunica a noi, si dona a noi, come dice il Vangelo di Giovanni e come tante volte ripete la liturgia nella Messa: il Padre genera il Salvatore e lo Spirito Santo, dice la liturgia. Tutto qui: il Padre che ci dona il suo Figlio.
Il dono dei Figlio per la nostra vita eterna
Ci dona suo Figlio perché ci fa una cosa sola con Lui, ci dona suo Figlio perché fa sì che il Figlio che è generato da Lui venga in noi, venga in noi ad essere concepito come uomo. Ed ecco allora qui, Maria, che è una donna in carne ed ossa.
Però se anche si comunica ad una creatura già esistente, la comunicazione che fa Dio di Sé a questa creatura è la comunicazione del Figlio di Dio: ne fa una sola cosa con il Figlio di Dio, generando il figlio di Dio in Lei, per Lei. Si tratta dunque di accettare questo dono di Dio.
Ecco, vedete come è semplice la vita cristiana: è la Trinità santa che in qualche modo si riflette, non so, come uno specchio: qua c’è la realtà del Dio uno e trino, ma la realtà del Dio uno e trino si riflette nella sua luce sullo specchio della creazione, e la creazione sono io nella misura in cui la mia anima è tersa e la mia anima vive nella fede la riflessione di questa luce che viene dal Padre. Ed essa si riflette in questo specchio che è la mia anima e io divengo uno come ciò che è stato Gesù, ma in modo diverso. Divengo come il sacramento della sua presenza, perché Dio in Sé non lo conosco, Dio in Sé non lo posso vedere, ma lui si riflette in me e in me lo riconosco.
Ed è per questo, vedete, che noi se conosciamo Dio, non lo conosciamo in Sé stesso, ma lo conosciamo in Cristo Gesù. Ve lo ricordate quello che dice il prologo nel Vangelo di Giovanni?
“Iddio, nessuno lo ha mai visto, l’unigenito Figlio che è nel seno del Padre Egli ce lo ha rivelato”.
Perché Lui che è infinito mistero nell’azione del Figlio incarnato nel ventre di Maria, si rende presente, perché chi è vissuto al tempo di Gesù lo ha visto e vedendo Lui ha ve-duto il Figlio di Dio.
La rivelazione che noi abbiamo di Dio è questa rivelazione riflessa. È Dio che in qualche modo si riflette nello specchio della creazione.
Perciò noi diveniamo, e questa è la missione del cristianesimo, la prima missione del cristianesimo, diveniamo testimoni di questa presenza, diveniamo sacramento che rivela al mondo Dio medesimo. Dio in Sé rimane puro mistero, ma Dio comunicandosi all’uomo, fa ora dell’uomo lo specchio in cui si riflette la divinità perché Dio, generan-doci come figli, non distrugge la nostra natura umana, ma si manifesta nel nostro corpo mortale, si manifesta nella nostra vita umana semplice e povera, ma è sempre Lui ed è soltanto Lui.
Ecco la prima cosa che vorrei che voi meditaste: l’esperienza di Dio è l’esperienza della vita trinitaria in quanto si riflette e si comunica misteriosamente, in un certo modo, al mondo. Dobbiamo allora capire una cosa: che la vita spirituale ha principio in Dio e non in noi, nella nostra volontà, ma nella onnipotenza del Padre che, solo, agisce. È Lui che inizia la nostra vita, è per Lui che la nostra vita può proseguire, sempre in dipendenza da Dio.
È stolto pensare che noi possiamo camminare verso Dio: è Lui che ci porta, è Lui che discende fino a noi e ci unisce a Sé ed è Lui che traendoci a Sé ci solleva poi al Padre nel Cristo. Ma la cosa che vorrei che vi rimanesse è proprio questa: rendetevi conto della nostra dipendenza da Dio fin dall’inizio. Non c’è principio nell’uomo alla sua vita spirituale: il principio, l’arché, la sorgente, è il Padre celeste. Dal Padre, ricordatevi la formula che è molto semplice ed è facile da ricordare, dal Padre, per il Figlio nello Spirito Santo, Dio si comunica al mondo. Dal Padre: ecco la sorgente di tutto l’archè, ma il Padre non si può comunicare che per mezzo del Figlio e nel Figlio medesimo, nel Figlio che si fa uomo, nel Figlio che, non cessando di essere Figlio di Dio, diviene anche Figlio dell’uomo, diviene nostro fratello, diviene nostro sposo pur rimanendo Figlio di Dio. Ma il fatto che noi siamo un solo figlio c perciò riceviamo il Padre in noi e viviamo in questa unione col Padre la nostra filiazione divina, tutto questo non può avvenire che per opera dello Spirito Santo.
Perché, chi è lo Spirito Santo?
Ecco un’altra cosa che dovremmo dire: ha un nome lo Spirito Santo o non ha nome? Noi diciamo: Spirito Santo; dunque ha un nome!
Eh no, perché anche il Padre è Spirito e anche il Padre è Santo, anche il Figlio di Dio è come il Figlio e come il Padre, cioè è Spirito anche il Figlio di Dio ed è Santo anche il Figlio di Dio.
Il termine Spirito Santo è un termine generico di per sé, ormai si usa questa espressione per parlare dello Spirito Santo perché l’ha usata anche nostro Signore, però nostro Si-gnore ha detto anche che Egli è il Paraclito, il consolatore. Il nome vero, secondo San Basilio, dello Spirito Santo sarebbe il dono. È Dio infatti che per mezzo dello Spirito Santo si dona, si riversa verso di noi. Noi non abbiamo alcun diritto di possedere Dio, ma Dio si comunica a noi nello Spirito Santo, nel dono che Egli fa di Sé stesso: questo sarebbe il dono!
Vorrei che voi vi fermaste soltanto a questa considerazione che è totalmente, come dire, comprensiva di tutto il mistero, di tutta la vita spirituale. Cioè di come nella Trinità di-vina il Padre è l’archè è la sorgente perché è dal Padre che è generato il Figlio ed è dal Padre per il Figlio che procede lo Spirito Santo, ma sempre dal Padre. Così anche nella vita spirituale tutto nasce dal Padre che per mezzo del Figlio che Egli ci dona, ci unisce a Sé nello Spirito Santo.
Vivere per riportare a Dio tutti i suoi doni
Perciò ritorna l’espressione che dicevo prima: dal Padre per mezzo del Figlio nello Spi-rito Santo, Dio si comunica al mondo. Si comunica a me, si comunica a voi, sempre per mezzo del Figlio nello Spirito Santo, ma sempre il Padre. Però, se Dio si comunica a noi, ora noi diveniamo capaci di comunicarci al Padre. Il Padre ha bisogno poiché ha donato Sé stesso nella generazione del Figlio in noi e dunque sarebbe senza il Figlio. Ma ecco ora, invece, il Padre riceve il Figlio attraverso di noi. La vita spirituale ora diventa una risposta a Dio che esige da noi Sé medesimo.
È Dio che ora esige da noi il suo Figlio ed è questo che fa la Chiesa. Ma che cosa fa re-almente la Chiesa? Dona il Figlio al Padre! Senza il dono della Chiesa il Padre sarebbe senza il Figlio, cioè Dio esige da me Sé medesimo, Sé medesimo infinito!
Da te, Dio medesimo, Sé infinito reclama, da te, da ciascuno di noi! Dio infinito, Dio medesimo Sé infinito reclama! Ed ecco allora tutta la vita spirituale, Dio aspetta da noi la sua vita, aspetta da noi Sé medesimo infinito, perché avendo donato Sé stesso nella generazione del Figlio non può fare senza. E quale sarà l’atto della Chiesa? Il resto sono tutte cose importanti ma non risolvono nulla. La vita della Chiesa tutta si raccoglie nel fatto che io celebro la Messa.
Cosa è la Messa? È il dono del Figlio al Padre. È una offerta!
Se leggete il canone romano, la prima preghiera eucaristica, tante volte si parla di offrire, offrire, ma che cosa offri? Il pane e il vino? Ma che cosa se ne fa nostro Signore? Scusatemi tanto!
No, da te Dio vuole Sé stesso, non può volere che Sé stesso. Dio, d’altra parte, non è che questa volontà di essere Lui, perciò tutta la volontà di Dio di essere Sé medesimo ora, diviene esigenza con la quale Egli chiede a te il suo Figlio. “Tutti i doni che mi hai donato, ecco io li riporto a Te, li dono a Te”. E i doni sono uno solo, il Figlio di Dio! È per questo che noi dobbiamo essere il Figlio perché se non siamo il Figlio, Dio non sa di che farsene di noi! Ma se noi siamo una sola cosa col Figlio, un solo corpo, un solo spi-rito con Lui, il Padre non può fare a meno del nostro dono perché è quasi attraverso di noi che il Padre riceve sé Stesso.
La speranza è nei giovani
di Rocco Chinnici*
“Abbiamo una città tra le più dilaniate dal fenomeno delinquenziale. Una città permeata di mafia. La mafia domina a Palermo. Ha dominato e continua a dominare. Fino a un certo periodo la sua attività era limitata al controllo delle aree edificabili e al contrab-bando delle sigarette. Ora invece abbiamo una attività nuova della mafia: quella della droga, che siccome è lucrosissima ha fatto esplodere questo contrasto, i cui momenti specifici non siamo riusciti ancora ad individuare in modo completo, ma che sappiamo essere un contrasto di interessi. Sarà che c’è un gruppo che vuole inserirsi e un altro che vi si oppone, sarà che ci sono questioni di miliardi non ancora risolte. Indubbiamente ciò che caratterizza oggi la città è, dal punto di vista della criminalità e del susseguirsi di tutti questi
omicidi, un contrasto tra gruppi di mafia che si dilaniano fra loro”.
Chi parla è il dott. Rocco Chinnici, consigliere istruttore dirigente l’ufficio istruzione del tribunale di Palermo. Un uomo ludico e rigoroso che svolge il suo lavoro quasi con religiosa dedizione.
Certo, non è la ferocia con cui la mafia compie i suoi delitti che fa meraviglia, né lo spreco di morti, né la teatralità dei crimini. Ci sono fatti nuovi che spiegano quel che sta accadendo a Palermo?
I fatti nuovi sono questi. In passato non c’era stato un intervento deciso dell’autorità. Perché noi siamo venuti a conoscenza di certi fatti sul finire del 1978. Solo allora fu av-viata un’indagine per accertare quello che poteva esserci di vero nelle notizie vaghe e imprecise circa un afflusso di denaro di provenienza illecita dagli Usa in Italia. E dob-biamo dare atto al compianto dott. Boris Giuliano dell’intelligenza e del coraggio con cui seppe indicare il canale Usa-Italia. Fu lui che per primo parlò anche dell’eroina prodotta in Sicilia e trasferita in America con il compenso di notevoli quantità di denaro. Dopo di lui indagò il capitano Basile, e così si ebbe la certezza, attraverso riscontri obiettivi, che quello che aveva detto il vicequestore Giuliano rispondeva a verità. Si trattava ormai di individuare i soggetti, e di procedere come si è proceduto.
Perché sino a quella data la magistratura non sapeva nulla?
Il motivo è questo. L’autorità giudiziaria viene informata dalla polizia attraverso i rap-porti giudiziari. Noi giudici non abbiamo una iniziativa diretta per individuare i reati, i rei. La prima linea è costituita dai carabinieri, dalla polizia, dalla guardia di finanza. Prima del 1978 sulla materia droga avevamo notizie vaghe. C’era stato sì un processo nel 1966-67 che ebbe vicende alterne: questione di incompetenza territoriale, invio a Roma, poi ritorno a Palermo. Ma si concluse con un nulla di fatto. C’era stato anche un altro processo, ma si concluse con una condanna di poco conto, perché allora fu difficile acquisire elementi probatori di certezza. Ripeto, solo sul finire del 1978 noi potemmo avviare un lavoro solido e deciso.
Boris Giuliano, Cesare Terranova, Emanuele Basile, Gaetano Costa, Piersanti Mattarella, ecc., grandi vittime della mafia. Un tempo, se si eccettuano pochi casi come la strage di Ciaculli, quando cadeva un carabiniere, un poliziotto, si poteva pensare a un incidente. Adesso invece la mafia mira in alto, attacca i gangli dello stato in modo scoperto e sistematico. Perché?
In genere, quando si parla di mafia si fanno delle distinzioni: mafia vecchia, mafia nuova. Io ho sempre sostenuto che la mafia è una e una sola, anche se opera in diversi settori economici e in diverse province, perché una delle caratteristiche della mafia è l’interprovincialità. Ora, il collegamento dell’associazione mafiosa con “Cosa Nostra”, cioè con la mafia americana – che poi si dice americana perché opera in America, ma
i suoi esponenti sono di origine siciliana, della provincia di Trapani e principalmente di Palermo – ha comportato trasformazioni. Il cambiamento consiste in questo: in una maggiore spregiudicatezza e nell’abbandono di certe regole che prima portavano a ri-sparmiare il poliziotto, il magistrato, le donne, ecc. Insomma, la mafia siciliana trapian-tata in America ha assimilato il metodo gangsterico e ricattatorio degli americani. Motivo per cui abbiamo una mafia che ha sempre una finalità ben precisa: arricchirsi in qualsiasi modo con qualunque mezzo ma cambia i sistemi e i metodi.
Quando vi siete accorti che i metodi erano cambiati?
Dalla strage di viale Lazio. Allora si è capito che la mafia aveva cambiato metodi, pur rimanendo associazione per delinquere con finalità d’arricchimento illecito. Prima quel era l’attività della mafia? Imporre il pizzo, imporsi nella aree edificabili, controllare tutte le costruzioni, l’erogazione delle acque per uso irriguo, il contrabbando. Dal 1970 invece comincia a commettere i reati più odiosi che possano esistere: nel nord il sequestro di persona, da noi il traffico della droga. La mafia uccide giornalmente. Perché tutti i ragazzi che muoiono in America, in Francia, Inghilterra, Norvegia, Italia ecc. per overdose, indubbiamente devono pesare sulle associazioni mafiose produttrici e spacciatrici di eroina. Pur di fare soldi! ecco perché la mafia oggi è più spregiudicata che mai, spietata, gangsterica nel senso proprio della parola. L’importante è fare soldi, dollari. Se poi dal traffico dell’eroina migliaia e migliaia di giovani muoiono, non importa. Ripeto, la mafia è stata sempre odiosa, ma oggi è più odiosa che mai.
C’è un dato che desta meraviglia negli omicidi di questi ultimi mesi: molte vittime ri-sultano incensurate …
Non deve meravigliare il fatto che parecchie persone di queste uccise recentemente non abbiano precedenti penali. Anzi, io posso dire che quelli che non hanno precedenti penali sono la maggioranza dei mafiosi. Perché? perché sono intelligenti, furbi, abili. E quindi in buona percentuale riescono a sfuggire alla giustizia.
Solo intelligenza e abilità hanno? Non hanno anche qualche aiuto politico o qualche connivenza di magistrato?
Su questo posso dire che non è mai emerso ufficialmente, cioè attraverso atti processuali, un rapporto di connivenza
con politici e uomini della legge. Tuttavia che dei rapporti ci siano stati non sono in grado né di escluderlo né di ammetterlo.
Anche nel fenomeno della cosiddetta economia sommersa della città sembra che abbiano un ruolo persone che sono mafiose ma che come tali non sono conosciute. Sulla stampa nazionale si è letto di funzionari di banche che sono finiti in galera perché implicati nel riciclaggio del denaro sporco.
Neppure questo deve stupire. E’ una pista, questa del collegamento fra
imputato di traffico di droga e funzionario di banca, che offre elementi per potersi for-mare un quadro più preciso al fine di ottenere risultati assai concreti.
Che ne pensa del “siciliano mafioso” di cui di tanto in tanto si sente parlare? Il presi-dente della commissione antimafia disse che la mafia in Sicilia è uno stato mentale che pervade tutti a tutti i livelli.
Niente di vero. Il siciliano mafioso è una sciocchezza enorme. Io mi rifaccio volentieri alla storia, passata e recente. Quando Mussolini in un famoso discorso disse: debellere-mo mafia e contromafia, a questo scopo diede pieni poteri al prefetto Mori, il quale ne fece uso e abuso. E tuttavia proprio il Mori che non può essere tacciato di benevolenza verso la mafia, nei luoghi nei quali intervenne perché ritenuti centri di mafia poté de-nunciare e arrestare solo il 2 per cento di persone che risultarono essere associate alla mafia. Quando Mori dice di avere debellato la mafia esagera, perché la mise solo un po’ a tacere, anche perché non arrivò a colpire la mafia dei colletti bianchi che è la più peri-colosa perché è quella inserita nel potere. Cosa voglio dire? Voglio dire che non è tutto vero quel che si dice sulla mafia. Non è vero che sia così estesa. Non è vero che sia così potente. Non è vero infine che abbia creato una mentalità, un comportamento, un co-stume. Quindi non ritengo affatto giustificata l’opinione di taluni studiosi, specie stra-nieri, i quali dicono che il siciliano è mafioso.
Quindi l’opinione secondo cui in Sicilia la mafia ha un consenso popolare non ha fon-damento…
Assolutamente. Questo giudizio non lo condivido, non l’ho mai condiviso. Ci vorrebbe Mori!, dice la gente quando a Palermo o nel palermitano succede un omicidio. Che si-gnifica questo? Significa che la gente non vuole la mafia. I giovani non vogliono la mafia. Tutti i giovani, quelli politicizzati e quelli di nessun credo politico. Nei piccoli paesi dove esiste la mafia, i mafiosi vengono segnati a dito, e vengono sopportati perché sono temuti.
E l’omertà? Che cosa è l’omertà?
Nel 99 per cento dei casi l’omertà è paura, non connivenza. Non deve impressionare il fatto che, come qualcuno ha rilevato, ai funerali dei mafiosi partecipi molta gente. Intanto questo non accade sempre: a Salemi dietro la bara di Zizzo, un boss di primissimo piano, non c’era nessuno. Poi, guardate le targhe delle macchine in quella circostanza: non sono solo della provincia dove si svolgono i funerali.
Quindi, secondo lei non si può parlare di cultura favorevole alla mafia.
No, nella maniera più categorica. A parte il fatto che il fenomeno della mafia è circo-scritto a quattro province della Sicilia, perché ci sono centri, paesi della Sicilia dove la mafia non esiste, non è mai esistita. No, la mafia in Sicilia non ha mai avuto il consenso popolare.
Alcuni studiosi hanno sostenuto la tesi che la mafia ha svolto, o in talune
forme continua a svolgere, un ruolo di supplenza rispetto allo stato, debole o assente.
No, questo è assurdo. Del resto guardiamo come interviene il potere mafioso. Vediamo quel che succede a Palermo: un giovane di 17-18-20 anni che si “autostrangola”, che viene buttato nell’immondizia! Questa me la chiamate giustizia? Questo è un potere che può sostituirsi a quello dello stato? Questa è solo vendetta, ferocia, esercitata su giovani che probabilmente hanno rubato, hanno fatto azioni delittuose ai danni di qualche boss o di qualcuno legato ai mafiosi. Non si può parlare di mafia capace di succedere allo stato.
La classica domanda, dott. Chinnici: che fare?
La mia fiducia è nelle nuove generazioni. Nel fatto che i giovani, i credenti, non credenti, della sinistra, democratici, di nessuna militanza politica, si ribellano, respingono il potere della mafia. Questa è la grande speranza che sta germogliando. E’ necessaria però un’opera di più ampia sensibilizzazione. Specialmente in rapporto al fenomeno droga e ai centinaia e centinaia di milioni che la sua organizzazione comporta. La nostra società corre un gravissimo pericolo. Ecco perché i giovani devono insorgere contro la mafia e la sua droga, con tutte le forze e il coraggio che hanno. Bisogna capire quanto è triste e sconvolgente vedere dei giovani semidistrutti dell’eroina. Oggi a Palermo abbiamo 3000-3500 eroinomani. Fra dieci anni questa cifra potrà raddoppiare. Quale problema, quale dramma! Purtroppo qui da noi, col pressappochismo che ci contraddistingue, questo problema non viene affrontato come si dovrebbe. Abbiamo i grossi problemi della crisi economica, della politica, e si è portati a sottovalutare quello della droga, i cui effetti deleteri non li vediamo ancora, ma li vedremo fra dieci anni. Perché il tossicodipendente diventa un peso per la società, oltre che per le famiglie. Le 50 mila lire per le dosi di eroina bisogna trovarle! Come vi spiegate i 50 mila furti all’anno nella città di Palermo? Un’alta percentuale di rapine viene consumata da soggetti drogati. I nuovi accattoni sono i drogati. I furti nell’appartamento, delle autovetture! La piccola rapina al portinaio dello stabile è opera spesso di drogati, perché il delinquente non rischia di rubare portafogli col pericolo di venire arrestato. Ecco il problema, che prima di essere giudiziario è sociale, civile, umano. E i danni di tante famiglie, i suicidi di tanti ragazzi, di qualche genitore, le epatiti da siringa! Come si può rimanere insensibili, inerti? La mafia oggi è diventata la portatrice dei malanni più gravi. Perché in passato se rapinava, se estorceva, se imponeva il pizzo, tutto sommato non cagionava tutto il male che oggi invece produce con la droga. Ecco perché bisogna avere la consapevolezza e il
coraggio di mobilitare tutte le forze vive e responsabili della società. Mafia e droga sono un binomio inscindibile. La droga è oggi la principale
attività della mafia. La droga viene smerciata dalla mafia. La mafia come
associazione per delinquere è stata sempre fuori legge. Ma ora è anche contro l’umanità. Il traffico della droga io lo considero un delitto di lesa umanità.
Sembra che oggi a Palermo sia diventato facile trovare dei killers, con poche centinaia di migliaia di lire…
Sì, ho saputo notizie agghiaccianti. Ci sono ragazzi di 16-17 anni delle zone depresse della città che vanno in giro armati con la P38 e che sono capaci di commettere omicidi per 100 mila lire. Oramai tra gli spacciatori di droga ci sono ragazzi che trovano molto facile guadagnarsi 200-300 mila lire spacciando eroina. Che uno spacciatore di droga diventi anche omicida non c’è da meravigliarsi. Non voglio drammatizzare, ma non dobbiamo sottovalutare la situazione. Abbiamo una città che vive sotto l’incubo dei de-litti, degli omicidi, delle rapine. E noi abbiamo il dovere di reagire in tutti i modi come componenti di questa società. E ciò in particolare devono farlo gli educatori nelle scuole, i padri di famiglia, i politici, i sacerdoti…
Che ne pensa dell’iniziativa del vescovo di Palermo di radunare nella cattedrale tutti i cittadini e gli uomini di buona volontà in questo momento, su questi problemi?
E’ una iniziativa altamente lodevole, opportuna e giusta, che denota la sensibilità e l’impegno del cardinale verso i problemi della città. La chiesa non può rimanere insen-sibile. Io credo che se il cardinale non prendesse questa posizione verrebbe meno ai suoi doveri sacerdotali.
La chiesa siciliana, a parte il cardinale Pappalardo, finora collegialmente non ha preso mai, se non incidentalmente, posizione contro la mafia…
Io ho conosciuto molto da vicino Vittorio Bachelet, ed ho venerazione per la memoria di quell’uomo: era un puro. In un incontro a Grottaferrata io parlai di taluni preti mafiosi. Bachelet si turbò. Per lui era inconcepibile che un prete potesse essere non dico mafioso, ma sospettato di mafia. Purtroppo, abbiamo avuto qualche prete mafioso: è storia. Però, ecco, la chiesa ha il dovere sacrosanto di intervenire. Se la chiesa tace incorre, a mio giudizio, in un gravissimo errore, perché viene meno alla sua missione.
E’ dunque una novità quello che sta facendo il cardinale Pappalardo…
E’ una grande novità. E speriamo che sia seguita in tutti i pulpiti, in tutte le piccole chiese, nelle chiese di città e di campagna, in tutte le parrocchie. Speriamo che ogni par-roco, ogni sacerdote, ogni suora, ogni religioso consideri anche questo impegno contro la mafia, contro la droga, come un preciso dovere del suo ministero. Io questo mi auguro: che l’iniziativa del cardinale Pappalardo non sia isolata, non duri una domenica, ma sia portata avanti da tutto il clero, da tutti i cristiani. Io credo che su questo dovere non si possono avere, neppure lontanamente, dubbi.
*Testo della conversazione pubblicata in Segno, a. VII, Nuova Serie, n. 10-11 (27), Pa-lermo ottobre-novembre 1981, col titolo “Palermo, una città dominata dalla mafia”.
Tratto da L’illegalità protetta. Attività criminose e pubblici poteri nel meridione d’Italia. A cura di Francesco Petruzzella; La Zisa pgg. 38- 47.
Io, Falcone, vi spiego cos’è la mafia
Michele Pantaleone
In quest’articolo pubblicato da “L’Unità” il 31 maggio 1992, otto giorni dopo la strage di Capaci, il giudice Giovanni Falcone traccia con chiarezza un quadro dell’evoluzione di Cosa Nostra a partire dal dopoguerra e denuncia la sottovalutazione che, per molto tempo, ha caratterizzato l’approccio delle istituzioni al problema della mafia.
Io, Falcone, vi spiego cos’è la mafia
Nella relazione finale della Commissione d’inchiesta Franchetti-Sonnino del lontano 1875/76 si legge che «la mafia non è un’associazione che abbia forme stabili e organismi speciali… Non ha statuti, non ha compartecipazioni di lucro, non tiene riunioni, non ha capi riconosciuti, se non i più forti ed i più abili; ma è piuttosto lo sviluppo ed il per-fezionamento della prepotenza diretta ad ogni scopo di male». Si legge ancora: «Questa forma criminosa, non… specialissima della Sicilia», esercita «sopra tutte queste varietà di reati»…«una grande influenza» imprimendo «a tutti quel carattere speciale che distingue dalle altre la criminalità siciliana e senza la quale molti reati o non si commetterebbero o lascerebbero scoprirne gli autori»; si rileva, inoltre, che «i mali sono antichi, ma ebbero ed hanno periodi di mitigazione e di esacerbazione» e che, già sotto il governo di re Ferdinando, la mafia si era infiltrata anche nelle altre classi, cosa che da alcune testi-monianze è ritenuta vera anche oggidì». Già nel secolo scorso, quindi, il problema mafia si manifestava in tutta la gravità; infatti si legge nella richiamata relazione:«Le forze militari concentrate per questo servizio in Sicilia risultavano 22 battaglioni e mezzo fra fanteria e bersaglieri, due squadroni di cavalleria e quattro plotoni di bersaglieri montani, oltre i Carabinieri in numero di 3120».
Da allora, bisogna attendere i tempi del prefetto Mori per registrare un tentativo di seria repressione del fenomeno mafioso, ma i limiti di quel tentativo sono ben noti a tutti.
Nell’immediato dopoguerra e fino ai tragici fatti di sangue della prima guerra di mafia degli anni 1962/1963 gli organismi responsabili ed i mezzi di informazione sembrano fare a gara per minimizzare il fenomeno. Al riguardo, appaiono significativi i discorsi di inaugurazione dell’anno giudiziario pronunciati dai Procuratori Generali di Palermo.
Nel discorso inaugurale del 1954, il primo del dopoguerra, si insisteva nel concetto che la mafia «più che una associazione tenebrosa costituisce un diffuso potere occulto», ma non si manca di fare un accenno alla gravissima vicenda del banditismo ed ai compor-tamenti non ortodossi di “qualcuno che avrebbe dovuto e potuto stroncare l’attività cri-minosa”; il riferimento è chiaro, riguarda il Procuratore Generale di Palermo, dottor Pili espressamente menzionato nella sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Viterbo il 3/5/1952: «Giuliano ebbe rapporti, oltre che con funzionari di Pubblica Sicurezza, anche con un magistrato, precisamente con chi era a capo della Procura Generale presso la Corte d’appello di Palermo: Emanuele Pili».
Nella relazioni inaugurali degli anni successivi gli accenni alla mafia, in piena armonia con un clima generale di minimizzazione del problema, sono fugaci e del tutto rassicuranti.
Così, nella relazione del 1956 si legge che il fenomeno della delinquenza associata è scomparso e, in quella del 1957, si accenna appena a delitti di sangue da scrivere, si dice ad «opposti gruppi di delinquenti».
Nella relazione del 1967, si asserisce che il fenomeno della criminalità mafiosa era entrato in una fase di «lenta ma costante sua eliminazione» e, in quella del 1968, si raccomanda l’adozione della misura di prevenzione del soggiorno obbligato, dato che «il mafioso fuori del proprio ambiente diventa pressoché innocuo».
Questi brevissimi richiami storici danno la misura di come il problema mafia sia stato sistematicamente valutato da parte degli organismi responsabili benché il fenomeno, nel tempo, lungi dall’esaurirsi, abbia accresciuto la sua pericolosità.
E non mi sembra azzardato affermare che una delle cause dall’attuale virulenza della mafia risieda, proprio, nella scarsa attenzione complessiva dello Stato nei confronti di questa secolare realtà.
Debbo registrare con soddisfazione, dunque, il discorso pronunciato dal Capo della Po-lizia, Vincenzo Parisi, alla Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza. In tale intervento, particolarmente significativo per l’autorevolezza della fonte, il Capo della Polizia, in sostanza, individua nella criminalità organizzata e in quella economica i pro-venti della maggior parte delle attività illecite del nostro paese tra le quali spiccano so-prattutto il traffico di stupefacenti e il commercio clandestino di armi. Sottolineando che la criminalità organizzata – e quella mafiosa in particolare – è, come si sostiene in quell’intervento, «la più significativa sintesi delinquenziale fra elementi atavici… e ac-quisizioni culturali moderne ed interagisce sempre più frequentemente con la criminalità economica, allo scopo di individuare nuove soluzioni per la ripulitura ed il reimpiego del denaro sporco».
L’argomentazione del prefetto Parisi, ovviamente fondata su dati concreti, ha riacceso l’attenzione sulla specifica realtà delle organizzazioni criminali e denuncia, con toni giustamente allarmanti, il pericolo di una saldatura tra criminalità tradizionale e crimi-nalità degli affari: un pericolo che minaccia la stessa sopravvivenza delle istituzioni de-mocratiche come ci insegnano le esperienze di alcuni paesi del Terzo mondo, in cui i trafficanti di droga hanno acquisito una potenza economica tale che si sono perfino of-ferti – ovviamente, non senza contropartite – di ripianare il deficit del bilancio statale. Ci si domanda allora, come sia potuto accadere che una organizzazione criminale come la mafia anziché avviarsi al tramonto, in correlazione col miglioramento delle condizioni di vita e del funzionamento complessivo delle istituzioni, abbia, invece, vieppiù accresciuto la sua virulenza e la sua pericolosità.
Un convincimento diffuso è quello – che ha trovato ingresso perfino in alcune sentenze della Suprema Corte – secondo cui oggi saremmo in presenza di una nuova mafia, con le connotazioni proprie di un’associazione criminosa, diversa dalla vecchia mafia, che non sarebbe stata altro che l’espressione, sia pure distorta ed esasperata, di un “comune sen-tire” di larghe fasce delle popolazioni meridionali. In altri termini, la mafia tradizionale non esisterebbe più e dalle sue ceneri sarebbe sorta una nuova mafia, quella mafia im-prenditrice per intenderci, così bene analizzata dal prof. Arlacchi.
Tale opinione è antistorica e fuorviante.
Anzitutto, occorre sottolineare con vigore che Cosa Nostra (perché questo è il vero no-me della mafia) non è e non si è mai identificata con quel potere occulto e diffuso di cui si è favoleggiato fino a tempi recenti, ma è una organizzazione criminosa – unica ed unitaria – ben individuata ormai nelle sue complesse articolazioni, che ha sempre mantenuto le sue finalità delittuose. Con ciò, evidentemente, non si intende negare che negli anni Cosa Nostra abbia subito mutazioni a livello strutturale e operativo e che altre ne subirà, ma si vuole sottolineare che tutto è avvenuto nell’avvio di una continuità storica e nel rispetto delle regole tradizionali. E proprio la particolare capacità della mafia di modellare con prontezza ed elasticità i valori arcaici alle mutevoli esigenze dei tempi costituisce una della ragioni più profonde della forza di tale consorteria, che la rende tanto diversa.
Se oltre a ciò, si considerano la sua capacità di mimetizzazione nella società, la tremenda forza di intimidazione derivante dalla inesorabile ferocia delle “punizioni” inflitte ai trasgressori o a chi si oppone ai suoi disegni criminosi, l’elevato numero e la statura criminale dei suoi adepti, ci si può rendere però conto dello straordinario spessore di questa organizzazione sempre nuova e sempre uguale a sé stessa. Altro punto fermo da tenere ben presente è che, al di sopra dei vertici organizzativi, non esistono “terzi livelli” di alcun genere, che influenzino e determinino gli indirizzi di Cosa Nostra.
Ovviamente, può accadere ed è accaduto, che, in determinati casi e a determinate condi-zioni, l’organizzazione mafiosa abbia stretto alleanze con organizzazioni similari ed ab-bia prestato ausilio ad altri per fini svariati e di certo non disinteressatamente; gli omicidi commessi in Sicilia, specie negli ultimi anni, sono la dimostrazione più evidente di specifiche convergenze di interessi fra la mafia ed altri centri di potere.
“Cosa Nostra” però, nelle alleanze, non accetta posizioni di subalternità; pertanto, è da escludere in radice che altri, chiunque esso sia, possa condizionarne o dirigerne dall’esterno le attività. E, in verità, in tanti anni di indagini specifiche sulle vicende di mafia, non è emerso nessun elemento che autorizzi nemmeno il sospetto dell’esistenza di una “direzione strategica” occulta di Cosa Nostra. Gli uomini d’onore che hanno collaborato con la giustizia, alcuni dei quali figure di primo piano dell’organizzazione, ne sconoscono l’esistenza.
Lo stesso dimostrato coinvolgimento di personaggi di spicco di Cosa Nostra in vicende torbide ed inquietanti come il golpe Borghese ed il falso sequestro di Michele Sindona non costituiscono un argomento “a contrario” perché hanno una propria specificità tutte ed una peculiare giustificazione in armonia con le finalità dell’organizzazione mafiosa.
E se è vero che non pochi uomini politici siciliani sono stati, a tutti gli effetti, adepti di “Cosa Nostra”, è pur vero che in seno all’organizzazione mafiosa non hanno goduto di particolare prestigio in dipendenza della loro estrazione politica. Insomma Cosa Nostra ha tale forza, compattezza ed autonomia che può dialogare e stringere accordi con chic-chessia mai però in posizioni di subalternità.
Queste peculiarità strutturali hanno consentito alla mafia di conquistare un ruolo ege-monico nel traffico, anche internazionale, dell’eroina.
Ma, per comprendere meglio le cause dell’insediamento della mafia nel lucroso giro della droga, occorre prendere le mappe del contrabbando di tabacchi, una delle più tradizionali attività illecite della mafia. Il contrabbando è stato a lungo ritenuto una violazione di lieve entità perfino negli ambienti investigativi e giudiziari ed il contrabbandiere è stato addirittura tratteggiato dalla letteratura e dalla filmografia come un romantico avventuriero. La realtà era però ben diversa, essendo il contrabbandiere un personaggio al soldo di Cosa Nostra, se non addirittura un mafioso egli stesso ed il contrabbando si è rivelato un’attività ben più pericolosa di quella legata ad una violazione di un interesse finanziario dello Stato, in quanto ha fruttato ingenti guadagni che hanno consentito l’ingresso nel mercato degli stupefacenti della mafia ed ha aperto e collaudato quei canali internazionali – sia per il trasporto della merce sia per il riciclaggio del danaro – poi utilizzati per il traffico di stupefacenti.
Occorre precisare, a questo proposito, che già nel contrabbando di tabacchi, si realizzano importanti novità della struttura mafiosa. È ormai di comune conoscenza che Cosa Nostra è organizzata come una struttura piramidale basata sulla “famiglia” e ogni “uomo d’onore” voleva intrattenere rapporti di affari prevalentemente con gli altri membri della stessa “famiglia” e solo sporadicamente con altre famiglie, essendo riservato ai vertici delle varie “famiglie” il coordinamento in seno agli organismi direttivi provinciali e regionale.
Assunta la gestione del contrabbando di tabacchi – che comporta l’impiego di consistenti risorse umane in operazioni complesse che non possono essere svolte da una sola famiglia – sorge la necessità di associarsi con membri di altre famiglie e, perfino, con personaggi estranei a Cosa Nostra. Per effetto dell’allargamento dei rapporti di affari con altri soggetti spesso non mafiosi sorge la necessità di creare strutture nuove di coor-dinamento che, pur controllate da Cosa Nostra, con la stessa non si identificassero.
Si formano, così, associazioni di contrabbandieri, dirette e coordinate da “uomini d’onore”, che non si identificavano, però, con Cosa Nostra, associazioni aperte alla partecipazione saltuaria di altri “uomini d’onore” non coinvolti operativamente nel con-trabbando, previo assenso e nella misura stabilita dal proprio capo famiglia.
In pratica, dunque, l’antica, rigida compartimentazione degli “uomini d’onore” in “fa-miglie” ha cominciato a cedere il posto a strutture più allargate e ad una diversa artico-lazione delle alleanze in seno all’organizzazione. Cosa Nostra però non si limita ad e-sercitare il controllo indiretto su altre organizzazioni criminali similari, specialmente nel Napoletano, per assicurare un efficace funzionamento delle attività criminose. Il fatto che esiste anche a Napoli una “famiglia” mafiosa dipendente direttamente dalla “pro-vincia” di Palermo, non deve stupire perché la presenza di “famiglie” mafiose o di se-zioni delle stesse (le cosiddette “decine”), fuori della Sicilia, ed anche all’estero, è un fenomeno risalente negli anni. La stessa Cosa Nostra statunitense, in origine, non era altro che un insieme di “famiglie” costituenti diretta filiazione di Cosa Nostra siciliana.
Quando Cosa Nostra interviene sul contrabbando presso la malavita napoletana, dunque, lo fa allo scopo dichiarato di sanare i contrasti interni ma più verosimilmente con l’intenzione di fomentare la discordia per assumere la direzione dell’attività.
Ecco perché, nel corso degli anni, sono stati individuati collegamenti importanti tra e-sponenti di spicco della mafia isolana e noti camorristi campani, difficilmente spiegabili già allora con semplici contatti fra organizzazioni criminali diverse.
Ed ecco, dunque, perché il contrabbando di tabacchi costituì una spinta decisiva al co-ordinamento fra organizzazioni criminose, tradizionalmente operanti in territori distinti; coordinamento la cui pericolosità è intuitiva.
Nella seconda metà degli anni ‘70, pertanto, Cosa Nostra con le sue strutture organizza-tive, coi canali operativi e di riciclaggio già attivati per il contrabbando e con le sue larghe disponibilità finanziarie, aveva tutte le carte in regola per entrare, non più in modo episodico come nel passato, nel grande traffico degli stupefacenti.
In più, la presenza negli Usa di un folto gruppo di siciliani collegati con Cosa Nostra ga-rantiva la distribuzione della droga in quel paese.
Non c’è da meravigliarsi, allora, se la mafia siciliana abbia potuto impadronirsi in breve tempo del traffico dell’eroina verso gli Stati Uniti d’America.
Anche nella gestione di questo lucroso affare l’organizzazione ha mostrato la sua capa-cità di adattamento avendo creato, in base all’esperienza del contrabbando, strutture agili e snelle che, per lungo tempo, hanno reso pressoché impossibili le indagini.
Alcuni gruppi curavano l’approvvigionamento della morfina-base dal Medio e dall’Estremo Oriente; altri erano addetti esclusivamente ai laboratori per la trasforma-zione della morfina-base in eroina; altri, infine, si occupavano dell’esportazione dell’eroina verso gli Usa.
Tutte queste strutture erano controllate e dirette da “uomini d’onore”. In particolare, il funzionamento dei laboratori clandestini, almeno agli inizi, era attivato da esperti chimici francesi, reclutati grazie a collegamenti esistenti con il “milieu” marsigliese fin dai tempi della cosiddetta “French connection”.
L’esportazione della droga, come è stato dimostrato da indagini anche recenti, veniva curata spesso da organizzazioni parallele, addette al reclutamento dei corrieri e collegate a livello di vertice con “uomini d’onore” preposti a tale settore del traffico.
Si tratta dunque di strutture molto articolate e solo apparentemente complesse che, per lunghi anni, hanno funzionato egregiamente, consentendo alla mafia ingentissimi gua-dagni.
Un discorso a sé merita il capitolo del riciclaggio del danaro. Cosa Nostra ha utilizzato organizzazioni internazionali, operanti in Italia, di cui si serviva già fin dai tempi del
contrabbando di tabacchi, ma è ovvio che i rapporti sono divenuti assai più stretti e fre-quenti per effetto degli enormi introiti, derivanti dal traffico di stupefacenti. Ed è chiaro, altresì, che nel tempo i sistemi di riciclaggio si sono sempre più affinati in dipendenza sia delle maggiori quantità di danaro disponibili, sia soprattutto dalla necessità di eludere investigazioni sempre più incisive.
Per un certo periodo il sistema bancario ha costituito il canale privilegiato per il rici-claggio del danaro.
Di recente, è stato addirittura accertato il coinvolgimento di interi paesi nelle operazioni bancarie di cambio di valuta estera.
Senza dire che non poche attività illecite della mafia, costituenti per sé autonoma fonte di ricchezza (come, ad esempio, le cosiddette truffe comunitarie), hanno costituito il mezzo per consentire l’afflusso in Sicilia di ingenti quantitativi di danaro, già ripulito all’estero, quasi per intero proveniente dal traffico degli stupefacenti.
Quali effetti ha prodotto in seno all’organizzazione di Cosa Nostra la gestione del traffi-co di stupefacenti? Contrariamente a quanto ritenevano alcuni mafiosi più tradizionalisti, la mafia non si è rapidamente dissolta ma ha accentuato le sue caratteristiche criminali.
Le alleanze orizzontali fra uomini d’onore di diverse “famiglie” e di diverse “province” hanno favorito il processo, già in atto da tempo, di gerarchizzazione di Cosa Nostra ed al contempo, indebolendo la rigida struttura di base, hanno alimentato mire egemoniche. Infatti, nei primi anni ‘70 per assicurare un migliore controllo dell’organizzazione, veniva costituito un nuovo organismo verticale, la “commissione” regionale, composta dai capi delle province mafiose siciliane col compito di stabilire regole di condotta e di applicare sanzioni negli affari concernenti Cosa Nostra nel suo complesso.
Ma le fughe in avanti di taluni non erano state inizialmente controllate. Esplode così nel 1978 una violenta contesa culminata negli anni 1981-1982. Due opposte fazioni si af-frontano in uno scontro di una ferocia senza precedenti che investiva tutte le strutture di Cosa Nostra, causando centinaia di morti. I gruppi avversari aggregavano uomini d’onore delle più varie famiglie spinti dall’interesse personale – a differenza di quanto accadeva nella prima guerra di mafia caratterizzata dallo scontro tra le famiglie – e ciò a dimostrazione del superamento della compartimentazione in famiglie. La sanguinaria contesa non ha determinato – come ingenuamente si prevedeva – un indebolimento com-plessivo di Cosa Nostra ma, al contrario, un rafforzamento ed un rinsaldamento delle strutture mafiose, che, depurate degli elementi più deboli (eliminati nel conflitto), si ri-compattavano sotto il dominio di un gruppo egemone accentuando al massimo la se-gretezza ed il verticismo. Il nuovo gruppo dirigente a dimostrazione della sua potenza, a cominciare dall’aprile 1982, ha iniziato ad eliminare chiunque potesse costituire un o-stacolo. Gli omicidi di Pio La Torre, di Carlo Alberto Dalla Chiesa, di Rocco Chinnici, di Giangiacomo Ciaccio Montalto, di Beppe Montana, di Ninni Cassarà, al di là delle specifiche ragioni della eliminazione di ciascuno di essi, testimoniano una drammatica realtà. E tutto ciò mentre il traffico di stupefacenti e le altre attività illecite andavano a gonfie vele nonostante l’impegno delle forze dell’ordine.
La collaborazione di alcuni elementi di spicco di Cosa Nostra e la conclusione di inchie-ste giudiziarie approfondite e ponderose hanno inferto indubbiamente un duro colpo alla mafia. Ma se la celebrazione tra difficoltà di ogni genere di questi processi ha indotto Cosa Nostra ad un ripensamento di strategie, non ha determinato l’inizio della fine del fenomeno mafioso.
Il declino della mafia più volte annunciato non si è verificato, e non è, purtroppo, preve-dibile nemmeno. È vero che non pochi “uomini d’onore”, diversi dei quali di importanza primaria, sono in atto detenuti; tuttavia i vertici di Cosa Nostra sono latitanti e non sono sicuramente costretti all’angolo.
Le indagini di polizia giudiziaria, ormai da qualche anno, hanno perso di intensità e di incisività a fronte di una organizzazione mafiosa sempre più impenetrabile e compatta talché le notizie in nostro possesso sulla attuale consistenza dei quadri mafiosi e sui nuovi adepti sono veramente scarse.
Né è possibile trarre buoni auspici dalla drastica riduzione dei fatti di sangue peraltro circoscritta al Palermitano e solo in minima parte ascrivibile all’azione repressiva. La tregua iniziata è purtroppo frequentemente interrotta da assassini di mafiosi di rango, segno che la resa dei conti non è finita e soprattutto da omicidi dimostrativi che hanno creato notevole allarme sociale; si pensi agli omicidi dell’ex sindaco di Palermo, Giuseppe Insalaco e dell’agente della PS Natale Mondo, consumati appena qualche mese addietro. Si ha l’eloquente conferma che gli antichi, ibridi connubi tra criminalità mafiosa e occulti centri di potere costituiscono tuttora nodi irrisolti con la conseguenza che, fino a quando non sarà fatta luce su moventi e su mandanti dei nuovi come dei vecchi “omicidi eccellenti”, non si potranno fare molti passi avanti.
Malgrado i processi e le condanne, risulta da inchieste giudiziarie ancora in corso che la mafia non ha abbandonato il traffico di eroina e che comincia ad interessarsi sempre più alla cocaina; e si hanno già notizie precise di scambi tra eroina e cocaina già in America, col pericolo incombente di contatti e collegamenti – la cui pericolosità è intuitiva – tra mafia siciliana ed altre organizzazioni criminali italiane e sudamericane.
Le indagini per la individuazione dei canali di riciclaggio del denaro proveniente dal traffico di stupefacenti sono rese molto difficili, sia a causa di una cooperazione interna-zionale ancora insoddisfacente, sia per il ricorso, da parte dei trafficanti, a sistemi di ri-ciclaggio sempre più sofisticati.
Per quanto riguarda poi le attività illecite, va registrato che accanto ai crimini tradizionali come ad esempio le estorsioni sistematizzate, e le intermediazioni parassitarie, nuove e più insidiose attività cominciano ad acquisire rilevanza. Mi riferisco ai casi sempre più frequenti di imprenditori non mafiosi, che subiscono da parte dei mafiosi richieste perentorie di compartecipazione all’impresa e ciò anche allo scopo di eludere le investi-gazioni patrimoniali rese obbligatorie dalla normativa antimafia.
Questa, in brevissima sintesi, è la situazione attuale che, a mio avviso, non legittima al-cun trionfalismo. Mi rendo conto che la fisiologica stanchezza seguente ad una fase di tensione morale eccezionale e protratta nel tempo ha determinato un generale clima, se non di smobilitazione, certamente di disimpegno e, per quanto mi riguarda, non ritengo di aver alcun titolo di legittimazione per censurare chicchessia e per suggerire rimedi. Ma ritengo mio preciso dovere morale sottolineare, anche a costo di passare per profeta di sventure, che continuando a percorrere questa strada, nel futuro prossimo, saremo co-stretti a confrontarci con una realtà sempre più difficile.
Paolo Borsellino
da una lettera ad una insegnante
(…) 1. Sono diventato giudice perché nutrivo grandissima passione per il diritto civile ed entrai in magistratura con l’idea di diventare un civilista, dedito alle ricerche giuridiche e sollevato dalle necessità di inseguire i compensi dei clienti. La magistratura mi appariva la carriera per me più percorribile per dar sfogo al mio desiderio di ricerca giuridica, non appagabile con la carriera universitaria, per la quale occorrevano tempo e santi in paradiso. Fui fortunato e diventai magistrato nove mesi dopo la laurea (1964) e fino al 1980 mi occupai soprattutto di cause civili, cui dedicavo il meglio di me stesso. E’ vero che nel 1975, per rientrare a Palermo, ove ha sempre vissuto la mia famiglia, ero approdato all’ufficio istruzione processi penali, ma alternai l’applicazione, anche se saltuaria, a una sezione civile e continuai a dedicarmi soprattutto alle problematiche dei diritti reali, delle distanze legali, delle divisioni ereditarie. Il 4 maggio 1980 uccisero il capitano Emanuele Basile e il consigliere Chinnici volle che mi occupassi io dell’istruttoria del relativo procedimento. Nel mio stesso ufficio frattanto era approdato, provenendo anch’egli dal civile, il mio amico d’infanzia Giovanni Falcone, e sin da allora capii che il mio lavoro doveva essere un altro. Avevo scelto di rimanere in Sicilia e a questa scelta dovevo dare un senso. I nostri problemi erano quelli dei quali avevo preso a occuparmi quasi casualmente, ma se amavo questa terra di essi dovevo esclusivamente occuparmi. Non ho più lasciato questo lavoro e da quel giorno mi occupo pressoché esclusivamente della criminalità mafiosa. E sono ottimista perché vedo che verso di essa i giovani, siciliani e non, hanno oggi attenzione ben diversa da quella colpevole in-differenza che io mantenni sino ai quarant’anni. Quando questi giovani saranno adulti avranno più forza di reagire di quanta io e la mia generazione ne abbiamo avuta.
(…) 3. La mafia (Cosa Nostra) è un’organizzazione criminale, unitaria e verticisticamente strutturata, che si distingue da ogni altra per la sua caratteristica di «territorialità». Essa è divisa in famiglie, collegate tra loro per la dipendenza da una direzione comune (Cupola), che tendono a esercitare sul territorio la stessa sovranità che su esso esercita, o deve esercitare, legittimamente, lo Stato. Ciò comporta che Cosa Nostra tende ad appropriarsi di tutte le ricchezze che si producono o affluiscono sul territorio, principalmente con l’imposizione di tangenti (paragonabili alle esazioni fiscali dello Stato) e con l’accaparramento degli appalti pubblici, fornendo al contempo una serie di servizi apparenti rassemblabili a quelli di giustizia, ordine pubblico, lavoro, che dovrebbero es-sere gestiti esclusivamente dallo Stato. E’ naturalmente una fornitura apparente perché a somma algebrica zero, nel senso che ogni esigenza di giustizia è soddisfatta dalla mafia mediante una corrispondente ingiustizia. Nel senso che la tutela dalle altre forme di cri-minalità (storicamente soprattutto dal terrorismo) è fornita attraverso l’imposizione di altra e più grave forma di criminalità. Nel senso che il lavoro è assicurato a taluni (pochi) togliendolo ad altri (molti). La produzione e il commercio della droga, che pure hanno fornito Cosa Nostra di mezzi economici prima impensabili, sono accidenti di questo sistema criminale e non necessari alla sua perpetuazione. Il conflitto irreversibile con lo Stato, cui Cosa Nostra è in sostanziale concorrenza (hanno lo stesso territorio e si attribuiscono le stesse funzioni) è risolto condizionando lo Stato dall’interno, cioè con infiltrazioni negli organi pubblici che tendono a condizionare la volontà di questi perché venga indirizzata verso il soddisfacimento degli interessi mafiosi e non di quelli di tutta la comunità sociale. Alle altre organizzazioni criminali di tipo mafioso (camorra, ‘ndrangheta, sacra corona unita) difetta la caratteristica della unitarietà ed esclusività. Sono organizzazioni criminali che agiscono con le stesse caratteristiche di sopraffazione e violenza di Cosa Nostra, ma non ne hanno l’organizzazione verticistica e unitaria. U-sufruiscono inoltre in forma minore del «consenso» di cui Cosa Nostra si avvale per ac-creditarsi come istituzione alternativa allo Stato, che tuttavia con gli organi di questo viene a confondersi. (…)
[Il testo precedente consiste di due estratti da una lettera che la mattina del 19 luglio 1992 Borsellino aveva iniziato a scrivere in risposta ad una professoressa di Padova che tre mesi prima lo aveva invitato ad un incontro con gli studenti di un liceo. Abbiamo ripreso il testo dalle pp. 289-291 del bel libro di Umberto Lucentini ].
CONCLUSIONE
Quando il chicco di grano nascosto nel buio della terra porta i suoi frutti, non lo si può vedere più, perchè in se stesso non esiste più; ma puoi vederlo in tutti i frutti che da esso sono germogliati. Hanno un altro nome, un altro aspetto, un altro colore, un’ altra vita. Ma sono suoi frutti.
“A questa città vorrei dire: gli uomini passano, le idee restano, restano le loro tensioni morali, continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini.” Giovanni Falcone
“purtroppo i giudici possono agire solo in parte nella lotta alla mafia. Se la mafia è un’istituzione antistato che attiva consensi perché ritenuta Più efficiente dello stato,è compito della scuola rovesciare Questo processo perverso,formando giovani alla cultura dello stato e delle istituzioni” Paolo Borsellino
Prof. Michele Vilardo
Referente de Progetto Culturale della Chiesa ita-liana per l’Arcidiocesi di Monreale.











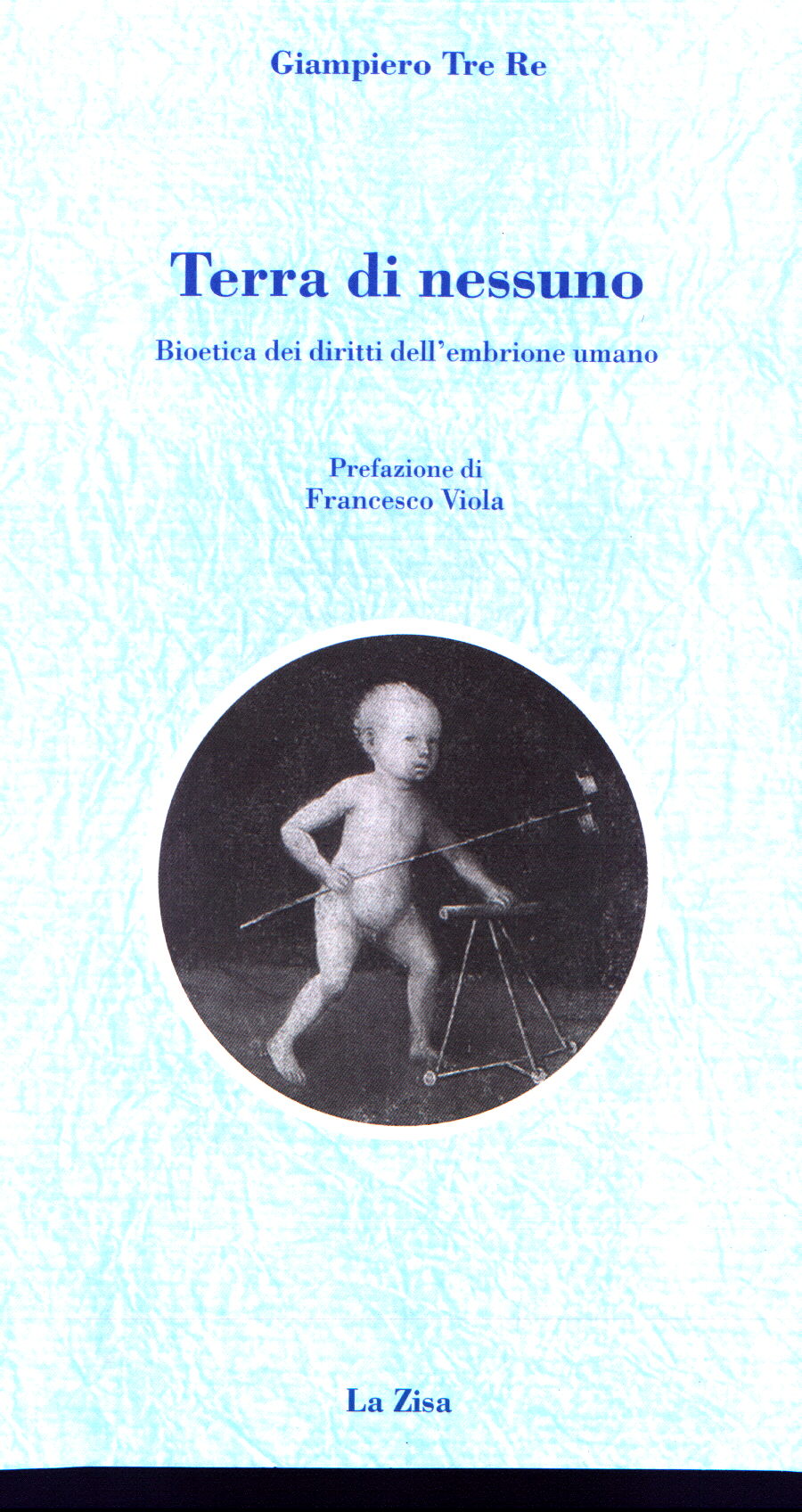
Hanno scritto